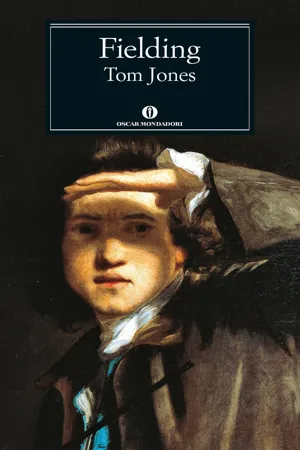![]()
1
Un capitolo straordinariamente lungo,
il più lungo di tutti i capitoli introduttivi,
riferito al meraviglioso
Dal momento che stiamo iniziando un nuovo libro nel quale il corso della nostra storia ci obbligherà a parlare di cose assai più strane e sorprendenti di quelle finora trattate, non è forse inutile, in una premessa o capitolo introduttivo, dire qualcosa di quel tipo di scrittura chiamato il “meraviglioso”.
A questo scopo, per il nostro e l’altrui bene, cercheremo di indicarne i limiti, cosa assolutamente necessaria in quanto è facile che critici1 di differente impostazione siano al proposito di parere diametralmente opposto; mentre infatti alcuni sono pronti ad ammettere, con Madame Dacier,2 che una cosa impossibile può essere tuttavia probabile, altri hanno invece così scarsa fede storica e poetica da non credere né possibile né probabile nulla che non abbiano potuto verificare di persona.
Penso quindi innanzitutto che da ogni scrittore si possa ragionevolmente pretendere che si tenga nei limiti del possibile, e che si ricordi che quanto è impossibile che un uomo compia, sarà molto difficile alla gente credere che l’abbia compiuto. Questa convinzione ha dato probabilmente origine a molte storie delle antiche divinità pagane, per la maggior parte di stampo poetico. Il poeta, propenso a eccessi e stravaganze di fantasia, si è rifugiato in quel dominio i cui confini sfuggivano al giudizio dei suoi lettori, i quali anzi, ritenendolo illimitato, non si stupivano dei prodigi in esso presenti. Un argomento, questo, portato con vigore in difesa dei portenti di Omero; e forse è veramente una difesa, non perché Ulisse, come Pope ha voluto, avesse raccontato una quantità di frottole ai Feaci, che erano gente piuttosto ottusa, ma perché il poeta scriveva per i pagani, per i quali le fiabe poetiche erano articoli di fede. Quanto a me, devo confessare che dato il mio carattere benevolo avrei preferito che Polifemo si fosse attenuto alla sua dieta lattea e avesse conservato il suo occhio; e che Ulisse non se la fosse presa tanto con i suoi compagni quando erano stati tramutati in porci da Circe, che poi mi pare abbia mostrato così poco riguardo per la carne umana da ritenerla adatta a farne del prosciutto.
Vorrei inoltre con tutto il cuore che Omero avesse conosciuto la regola di Orazio, che suggerisce di ricorrere il meno possibile ad agenti sovrannaturali: non avremmo in tal caso visto i suoi dèi scendere sulla terra per operazioni assolutamente banali, e comportarsi spesso in modo tale non solo da perdere ogni diritto al rispetto, ma da diventare oggetto di scherno e derisione. Cosa che deve aver scosso la credulità di ogni pagano pio e perspicace, e che si può giustificare unicamente accettando la supposizione da me più volte avanzata che questo grande poeta, quale senza dubbio Omero fu, fosse mosso dalla voglia di mettere in ridicolo la fede superstiziosa del suo tempo e del suo paese.
Ma mi sono dilungato troppo su una dottrina del tutto priva di utilità per uno scrittore cristiano, in quanto non potendo far posto nelle sue opere a nessuna di quelle schiere celesti che fanno parte del suo credo, sarebbe davvero puerile che andasse a snidare dalla teologia pagana quelle divinità da tempo ormai deposte dal loro trono immortale. Lord Shaftesbury ha detto che non c’è nulla di più freddo dell’invocazione di una musa da parte di uno scrittore moderno; avrebbe potuto aggiungere che non c’è nulla di più assurdo. Con molta maggior eleganza un moderno può invocare una ballata, come molti hanno pensato avesse fatto Omero, o un boccale di birra come l’autore di Hudibras, che forse ha ispirato più poesia e prosa di tutti i liquori di Ippocrene o d’Elicona.
I soli agenti sovrannaturali in qualche modo consentiti a noi moderni sono i fantasmi, ma esorterei gli autori a valersene con estrema misura. I fantasmi, come l’arsenico e altre pericolose droghe medicinali, devono essere usati con cautela, e ne sconsiglierei l’impiego in quelle opere, e da parte di quegli autori, che patirebbero fortemente d’esser mortificati dalle grasse risate dei lettori.
Quanto agli elfi, alle fate e ad altre creature del genere, evito volutamente di parlarne, dal momento che non desidero affatto costringere in angusti confini quelle straordinarie fantasie per le quali son troppo limitate le umane possibilità; le opere a esse dedicate devono essere considerate una nuova creazione, a cui spetta il diritto di obbedire ai propri gusti.
L’uomo è pertanto, salvo occasioni del tutto eccezionali, il più rilevante soggetto per la penna dei nostri storici o dei nostri poeti, ed è bene che nel riferirne le azioni si abbia cura di non andar oltre le sue capacità.
La possibilità di farlo non ci giustifica affatto: dobbiamo dunque limitarci alla probabilità. Questa è, io credo, l’opinione di Aristotele, o se non sua, di qualche altro saggio la cui autorità abbia lo stesso peso quando sia passato alla storia, secondo la quale «non vi sono scuse per il poeta che narri cose incredibili se non sono realmente accadute». Ciò può essere forse consentito alla poesia, ma inammissibile per la storia, perché lo storico è obbligato a riferire cose che è in grado di verificare, anche quando possano essere di così straordinaria natura da richiedere un alto grado di fede per essere credute. Tale fu il caso della sconfitta dell’esercito di Serse descritta da Erodoto o della fortunata spedizione di Alessandro riportata da Arriano; tale, in anni più recenti, la vittoria di Enrico V ad Agincourt, o quella di Carlo XII di Svezia a Narva. Esempi che più vi si riflette più appaiono straordinari.
Fatti di questo genere, che comunque accadono nel corso della storia, anzi ne sono parte essenziale, lo storico non solo ha il diritto di raccontarli come sono realmente accaduti, ma sarebbe imperdonabile se dovesse ometterli o comunque alterarli. Vi sono però altri accadimenti di minor peso e meno necessari che, sebbene ben testimoniati, vengono condannati all’oblio in omaggio allo scetticismo dei lettori. È il caso della memorabile storia del fantasma di George Villiers, della quale sarebbe stato più opportuno far dono al dottor Drelincourt3 perché lo mettesse in compagnia di quello di Mrs Veale all’inizio del suo Discorso sulla Morte, invece di inserirlo in un’opera solenne come la Storia della Ribellione.
Per la verità, può accadere che lo storico che pur si limiti a ciò che è realmente accaduto, rifiutando decisamente tutte le circostanze che, per quanto attestate, egli giudichi false, cada a volte nel meraviglioso; mai però nell’incredibile. Potrà a volte suscitare nel lettore stupore e sorpresa, ma non certo quell’avversione e quell’incredulità di cui parla Orazio. È cedendo alla finzione che noi trasgrediamo la regola di quell’attendibilità che raramente, se non mai, lo storico dovrebbe dimenticare, a costo di perdere la sua qualifica e diventare uno scrittore di romanzi.
In ciò tuttavia gli storici delegati a riferire fatti pubblici hanno un vantaggio su di noi che ci occupiamo solo di fatti privati. Il credito di cui godono i primi è sostenuto per lungo tempo dalla loro fama fra la gente, e gli atti pubblici, grazie alla concorde testimonianza di molti, daranno prova in futuro della loro autenticità. Anche un Traiano e un Antonino, anche un Nerone e un Caligola hanno goduto della fede dei posteri, e nessuno dubita che uomini così buoni e uomini così cattivi siano stati un tempo capi dell’umanità.
Ma noi che ci occupiamo di singole persone, che indaghiamo nelle segrete pieghe della loro mente, e traiamo esempi di vizi e virtù da tutti i più riposti angoli del mondo, siamo in situazione ben peggiore. Siccome non abbiamo notorietà, né testimonianze d’appoggio, né documenti a sostegno di ciò che diciamo, dobbiamo necessariamente tenerci nei limiti non solo della possibilità, ma anche della probabilità, e ciò soprattutto nel dare atto di ciò che è buono e gradevole. Malvagità e follia, se pure esorbitanti, sono in genere meglio credute, perché sono le cattive qualità a sostenere e rafforzare la fede.
Possiamo quindi, con poco danno, raccontare la storia di Fisher, che essendo vissuto a lungo grazie alla generosità di Mr Derby, e avendo ricevuto una mattina da lui un lauto compenso, intenzionato a impadronirsi di quanto ancora rimaneva nello scrigno del suo amico, si nascose in un pubblico ufficio del Temple dal quale era possibile accedere alle stanze di Mr Derby.
Vi rimase nascosto per molte ore, e prestò ascolto alla festa che quella sera Mr Derby aveva organizzato per i suoi amici, alla quale anche lui era stato invitato. In tutto questo tempo non sorse in lui alcun pensiero d’affetto o di riconoscenza capace di farlo recedere dal suo proposito, e quando il bravo gentiluomo ebbe congedato i suoi amici, uscì dal proprio nascondiglio, e recatosi in punta di piedi nella sua stanza gli sparò un colpo di pistola in testa. Questo caso sarà ancora creduto quando le ossa di Fisher saranno decomposte al pari del suo cuore. Anzi, si darà anche credito al fatto che due giorni dopo quello sciagurato se ne andò a teatro con due signore a vedere l’Amleto, e senza batter ciglio udì una delle due, che non sospettava affatto d’essergli seduta al fianco, dire a un tratto: «Oh Dio! E se qui ci fosse l’assassino di Mr Derby?», manifestando in tal modo una coscienza più indurita e insensibile di quella di Nerone, del quale Svetonio ci racconta che «dopo la morte di sua madre la coscienza della propria colpa gli divenne insopportabile», precisando che né le congratulazioni dei suoi soldati, né del senato, né del popolo riuscirono ad alleviarne il peso.
Dovrei però a questo punto dire al lettore d’aver conosciuto un uomo che grazie al proprio ingegno era riuscito a raggranellare una grossa fortuna in un campo agli inizi tutt’altro che favorevole, e l’aveva fatto preservando la propria integrità, non solo evitando di recare offesa o ingiustizia a chicchessia, ma incrementando il commercio e accrescendo il reddito pubblico. Una parte del suo reddito personale l’aveva spesa, rivelando un gusto superiore a quello di molti, in opere in cui all’altissima dignità era unita la semplicità più pura; un’altra parte, mostrando un grado di bontà veramente superiore, l’aveva impiegata in atti di carità a favore di persone scelte soltanto in base ai loro meriti o ai loro bisogni.
Aveva una notevole capacità di riconoscere il bene nelle situazioni difficili, pronto a intervenire per soccorrerle e subito dopo a nascondere accuratamente (forse troppo accuratamente) l’aiuto prestato. La sua casa, l’arredamento, i giardini, la sua tavola, la sua ospitalità privata e la beneficenza pubblica, tutto intrinsecamente ricco e nobile, privo di orpelli e di volontà di ostentazione, denotava le alte qualità del suo spirito. Nel rapporto con il prossimo si comportava con la più ineccepibile rettitudine; era religioso e devoto al suo Creatore, leale con zelo al suo re, tenerissimo con la moglie, gentile con i parenti, munifico con i dipendenti, fedele nelle amicizie.
Era un compagno allegro e tollerante, era indulgente con la servitù, buon ospite con i vicini, caritatevole verso i poveri, buono con tutti. Potessi aggiungere a tutto questo le qualifiche di saggio, coraggioso, raffinato, e altre positive qualità che la nostra lingua sia in grado di suggerire, direi con la massima sicurezza:
... Quis credet? nemo Hercule! nemo;
Vel duo, vel nemo.4
Eppure conosco un uomo identico in tutto a quello che ho appena descritto. Ma un solo esempio (e non ne conosco altri) non basta a giustificarci quando ci troviamo a scrivere per migliaia di persone che un uomo come quello non l’hanno mai conosciuto, o incontrato chi gli somigli. Simili rarae aves dovrebbero essere riservate a uno scrittore di epitaffi, o a qualche poeta che accettasse di descriverle in distici, o a passarle direttamente in rime con grazia noncurante e distratta, senza recare offesa a chi dovesse leggerle.
Le azioni umane, insomma, dovrebbero limitarsi al campo delle umane possibilità, e tali da poter essere compiute e quindi credute, perché quanto può essere straordinario e sorprendente in un uomo può risultare improbabile, o addirittura impossibile, ad altri cui viene raccontato.
Quest’ultimo requisito è ciò che i critici drammatici chiamano definizione del personaggio, e che richiede non solo un altissimo grado di discernimento ma anche un’esatta conoscenza della natura umana.
È stato giustamente notato da parte di un grande scrittore che lo zelo non potrà mai indurre nessuno ad agire in modo contrario alla propria natura, non più di quanto un vigoroso corso d’acqua possa spingere una barca a risalire la corrente, e io mi spingo a dire che non solo è impossibile che un uomo si comporti in tal modo, ma che sarebbe improbabile e miracoloso il solo pensarlo. Se le migliori gesta di Antonino fossero attribuite a Nerone, o ad Antonino i peggiori misfatti di Nerone, chi ci crederebbe? Riferite invece correttamente a ciascuno dei responsabili, quelle azioni rappresentano il vero “meraviglioso”.
I nostri moderni autori di commedie sono caduti quasi tutti in questo errore; nei primi quattro atti i loro eroi sono dei famigerati mascalzoni e le loro eroine donne di facili costumi; nel quinto però i primi diventano degnissimi gentiluomini e le seconde dame virtuose e discrete, senza che l’autore si dia sempre la pena di dire come e perché si sia verificato un simile mostruoso e incongruo cambiamento. Non vi è altra spiegazione invece se non quella che la commedia volge alla conclusione, e nulla è più naturale che un mascalzone si penta nell’ultimo atto della commedia come nell’ultima ora della propria vita. Di ciò ci rendiamo conto a Tyburn,5 luogo dove assai più propriamente potrebbero concludersi molte commedie, in quanto i loro eroi spiccano proprio per quelle qualità che non solo li mandano a finire sul patibolo, ma che gli fanno fare bella figura quando stanno per essere appesi.
Tenendo conto di questi limiti, io credo che qualsiasi scrittore possa permettersi di misurarsi con il meraviglioso a suo piacimento; anzi, se rispetta le regole della credibilità avrà maggiori possibilità di stupire il lettore, di attrarre la sua attenzione e di estasiarlo, proprio come nel quinto capitolo del Bathos6 dice un grandissimo genio: «La grande arte della poesia consiste nel mescolare la verità alla finzione, allo scopo di unire il credibile al sorprendente».
Non è infatti indispensabile che un buon autore, pur mantenendosi nei limiti del probabile, si valga di personaggi e di fatti triti, banali e comuni come quelli che accadono in ogni strada, in ogni casa, o che sono riportati nei giornali locali.
Non è neppure necessario che vieti a se stesso di presentare persone o cose di cui la maggior parte dei suoi lettori non abbia mai sentito parlare. Se lo scrittore osserva con rigore queste regole, avrà svolto il suo compito e avrà meritato una certa fiducia da parte del lettore, che sarà invece colpevole di sofistica incredulità se non gli presterà fede.
Ricordo a questo proposito un’illustre e giovane dama della quale era stato criticato, da parte di una vasta fascia di pubblico d’impiegati e apprendisti, il comportamento poco naturale sulla scena, che invece aveva suscitato l’approvazione di molte signore dell’alta società; una di queste, più perspicace delle altre, aveva dichiarato di riconoscere in lei una buona metà delle giovani di sua conoscenza.
2
La locandiera va a trovare Mr Jones
Quando il suo amico tenente lo lasciò, Jones cercò invano di dormire; era troppo eccitato e troppo sveglio per abbandonarsi al sonno. Pensò più con tormento che con gioia alla sua Sophia fino a giorno fatto, e poi chiamò per chiedere un po’ di tè. La locandiera ne approfittò per andare da lui di persona.
Era la prima volta che lo vedeva, o almeno la prima volta che s’occupava di lui, e dato che il tenente le aveva assicurato che era un vero gentiluomo, decise di trattarlo con il massimo riguardo; in realtà la sua era una di quelle case in cui i gentiluomini, per usare il linguaggio pubblicitario, ricevono un trattamento corrispondente al denaro che intendono spendere.
Mentre gli preparava il tè cominciò ad attaccare discorso. «Eh sì, signore,» disse «è un vero peccato che un bel giovane come voi si abbassi al punto di andare in giro con questa soldataglia. Sostengono d’essere dei gentiluomini, è vero, ma come diceva sempre il mio primo marito, dovrebbero ricordarsi che siamo noi a pagarli. Ed è molto duro per noi locandieri essere obbligati a pagarli e a mantenerli. Ne avevo venti l’altra notte, oltre agli ufficiali, anche se per la verità a questi io preferisco i soldati: non c’è mai nulla che vada bene per quei damerini; lo capireste dai conti, se li vedeste: una miseria! Mi pesa meno la famiglia di un buon possidente, ve l’assicuro, dalla quale prendiamo quaranta o cinquanta scellini per notte, senza contare i cavalli. Eppure non ce n’è uno, di quei degni ufficiali, che non si ritenga all’altezza di uno squire da 500 sterline all’anno. Nulla da dire che i loro soldati gli corrano dietro gridando sissignore, sissignore, ma a cosa servono tutte quelle arie, quando poi mi pagano uno scellino a testa? E poi, sapeste, bestemmiano da far paura; è impossibile far fortuna con gente simile, ve lo dico io. E quel tale che vi ha trattato in quel barbaro modo? Sono certa che gli altri erano pronti a dargli man forte; son tutti gente da forca, e se anche aveste rischiato di lasciarci la pelle, e sono lieta di vedere che non è così, le cose sarebbero andate allo stesso modo: uno vale l’altro, tutta gentaglia che avrebbe lasciato scappare l’assassino. Dio li perdoni; mai al mondo io vorrei dover rispondere d’un simile misfatto. Ma anche se è probabile che con l’aiuto di Dio la scampiate, a lui ci penserà la legge; e se darete l’incarico al legale Small, scommetto che gli si mette alle calcagna per tutto il paese anche se avrà già preso il volo, perché non si sa mai con quei ragazzi, oggi qui, domani là. Comunque spero che imparerete a essere più accorto per l’avvenire, e tornere...