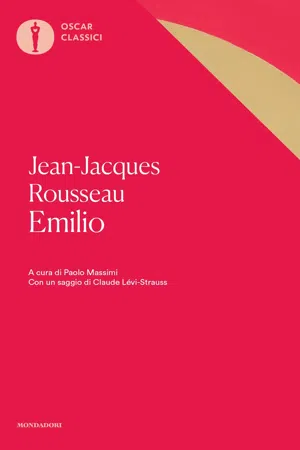
- 784 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Summa delle concezioni filosofiche di Rousseau sulla natura umana e sull'influsso esercitato dalla società, Emilio costituisce una chiave di volta nello sviluppo della sua dottrina: vagheggiato l'ideale di una società perfetta, è in queste pagine che vengono gettate le basi concrete della civiltà rinnovata. Emilio percorre le tappe della formazione intellettuale e morale di un individuo destinato a vivere nella società, ma capace di resistere alla sua influenza corruttrice. Un progetto ispirato ai principi di natura, libertà, rispetto dell'individualità del fanciullo, destinato a influenzare la riflessione pedagogica dal Settecento in poi e a diventare il punto di partenza della pedagogia moderna.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Emilio di Jean-Jacques Rousseau, Paolo Massimi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Didattica e Metodi di insegnamento. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Libro quarto
Periodo di maturazione
Com’è rapido il nostro passaggio su questa terra! Il primo quarto della vita è trascorso prima che l’uomo impari a goderne, l’ultimo quarto trascorre quando ormai non ne gode più. Dapprima non sappiamo vivere, poco dopo non ne abbiamo più la forza e nell’intervallo che separa queste due inutili estremità i tre quarti del tempo che resta sono consumati dal sonno, dal lavoro, dal dolore, dalla costrizione, da pene di ogni sorta. La vita è breve, non tanto per l’esiguità della sua durata, quanto perché, di questo breve tempo, quasi nulla ci è dato goderne. Per lontano che sia l’istante della morte da quello della nascita, la vita è sempre troppo breve quando questo spazio è male impiegato.84
Noi nasciamo, per così dire, due volte: l’una per esistere, l’altra per vivere; l’una per la specie, l’altra per il sesso. Coloro che considerano la donna come un uomo imperfetto hanno indubbiamente torto, ma l’analogia esteriore dà loro ragione. Fino all’età nubile, i fanciulli dei due sessi non hanno nulla in apparenza che li distingua: lo stesso volto, lo stesso aspetto, la stessa carnagione, la stessa voce, tutto è eguale; ragazze e ragazzi sono fanciulli: lo stesso nome basta per indicare esseri tanto simili. I maschi cui si impedisce l’ulteriore sviluppo del sesso conservano questa somiglianza per tutta la vita: sono dei grandi bambini; e le donne, poiché non perdono questi caratteri, sembrano sotto molti aspetti non essere mai altra cosa.
Ma l’uomo, in generale, non è fatto per restare sempre nella fanciullezza. Ne esce nel tempo stabilito dalla natura e questo momento di crisi, benché assai breve, ha conseguenze che durano a lungo.
Come il mugghiar del mare precede da lungi la tempesta, così questa tempestosa rivoluzione si annuncia col rumoreggiare delle passioni nascenti: un sordo fermento avverte che il pericolo è vicino. Un cambiamento dell’umore, frequenti moti di collera, una continua agitazione di spirito rendono il fanciullo quasi del tutto restio alla disciplina. Diventa sordo alla voce che lo rendeva docile; si tramuta in un leoncello, nell’impeto della sua febbre; non riconosce più la propria guida, rifiuta di lasciarsi dirigere.
Agli indizi morali di un umore che si modifica si accompagnano cambiamenti sensibili nell’aspetto. La fisionomia si sviluppa e assume l’impronta di un carattere; la rara e delicata lanugine che cresce sulle guance si fa scura e consistente. Muta voce, o piuttosto la perde: non è fanciullo né uomo, gli manca il timbro dell’uno e dell’altro. I suoi occhi, questi organi dell’animo che furono muti finora, trovano un linguaggio e si fanno espressivi; un fuoco nascente li anima, i loro sguardi più vivi hanno ancora una santa innocenza, ma hanno perduto la primitiva semplicità: intuisce ormai che possono tradirlo, impara ad abbassarli e ad arrossire; diviene sensibile prima di sapere ciò che sente, è inquieto senza ragione. È tutto un processo che può anche compiersi con lentezza e lasciarvi ancora del tempo: ma se la sua vivacità si fa troppo impaziente, se il suo moto di collera si muta in furore, se passa in un istante dall’irritazione alla tenerezza, se versa lagrime senza motivo, se, accanto ad esseri che cominciano a farsi pericolosi per lui, il suo sangue pulsa più rapido e l’occhio s’infiamma, se una mano di donna posandosi sulla sua lo fa fremere, se appare turbato o timido vicino a lei: Ulisse, o saggio Ulisse, sta bene attento! gli otri che chiudevi con tanta cura sono aperti; i venti sono già scatenati; non lasciare più il timone neppure un istante, o tutto è perduto.
È questa la seconda nascita di cui ho parlato, ora appunto l’uomo nasce veramente alla vita e nulla di umano è più estraneo per lui. Fin qui le nostre cure non furono che giuochi da fanciulli, ora soltanto assumono vera importanza. Quest’epoca in cui per solito la comune educazione finisce è proprio quella in cui la nostra deve cominciare. Ma, per esporre bene questo nuovo programma, è opportuno risalire alle origini della situazione che lo giustifica.
Le passioni sono i principali strumenti della nostra conservazione: è dunque impresa vana e insieme ridicola volerle distruggere, è come pretendere di controllare la natura, di riformare l’opera di Dio. Se Dio dicesse all’uomo di annientare le passioni che gli dà, Dio vorrebbe e non vorrebbe, sarebbe in contraddizione con se stesso. Mai egli ha dato quest’ordine insensato, nulla di simile è scritto nel cuore umano; e quello che Dio vuole che un uomo faccia, non glielo fa dire da un altro uomo, glielo dice da sé, lo scrive nel profondo del suo cuore.
Ora, chi volesse impedire alle passioni di nascere, sarebbe folle, a parer mio, quasi come colui che volesse annientarle; e se alcuni credono che tale sia stata fin qui la mia intenzione, mi hanno certamente capito molto male.
Ma una volta ammesso che è proprio della natura dell’uomo avere passioni, sarebbe forse logico concluderne che tutte le passioni che sentiamo in noi e vediamo negli altri sono naturali? La loro sorgente è naturale, è vero, ma mille rivoli estranei l’hanno ingrossata, ed ora è un gran fiume, che cresce senza tregua e in cui a fatica ritroveremmo qualche stilla delle sue acque sorgive. Le nostre passioni naturali sono molto limitate; sono strumenti della nostra libertà e tendono a conservarci. Tutte quelle che ci soggiogano e ci distruggono hanno altra origine: non è la natura a darcele, siamo noi stessi che, con suo danno, ce le procuriamo.
La sorgente delle nostre passioni, l’origine e il principio di tutte le altre, la sola che nasce con l’uomo e non l’abbandona mai finché vive, è l’amore di sé: passione primigenia, innata, anteriore a tutte le altre che, in fondo, non sono che sue modificazioni. In tal senso potremmo dire che tutte sono naturali. Ma queste modificazioni hanno per la maggior parte cause estranee, senza le quali non si sarebbero mai prodotte, e per di più, invece di giovarci, ci nuocciono; si discostano dal loro fine iniziale e vanno contro il loro stesso principio: è allora che l’uomo viene a trovarsi fuori della natura e si mette in contraddizione con se stesso.
L’amore di sé è sempre buono, sempre conforme all’ordine naturale. Poiché a ciascun individuo è in special modo affidata la propria conservazione, la prima e la più importante delle sue cure è e deve essere di attendere incessantemente ad essa: e come potrebbe attendervi con tanto zelo, se non l’avesse sommamente a cuore?
Dobbiamo dunque amare necessariamente noi stessi, per conservarci, dobbiamo amarci più di ogni altra cosa e, come immediata conseguenza di questo sentimento, non possiamo non amare ciò che giova alla nostra conservazione. Ogni fanciullo si affeziona alla propria nutrice: Romolo dovette affezionarsi alla lupa che lo aveva allattato. Dapprima quest’affezione è puramente meccanica. Ciò che favorisce il benessere di un individuo, lo attira; ciò che gli nuoce, gli ripugna: non è che cieco istinto. Ciò che trasforma questo istinto in sentimento e fa che l’affezione divenga amore, l’avversione odio, è l’intenzione manifesta di nuocerci o di giovarci. Nessun genere di passione nasce in noi verso gli esseri privi di sensibilità, che agiscono per un impulso ricevuto dall’esterno; ma quelli da cui ci attendiamo del bene o del male per loro interna disposizione, per loro volontà, quelli che vediamo agire liberamente a favore o contro di noi, ci ispirano sentimenti simili a quelli che ci dimostrano. Ciò che ci serve, lo ricerchiamo, ma colui che vuole servirci, lo amiamo. Ciò che ci nuoce, lo fuggiamo, ma colui che vuole nuocerci, lo odiamo.
Il primo sentimento di un fanciullo è di amare se stesso e il secondo, che deriva dal primo, è di amare quelli che gli stanno accanto; infatti, nello stato di debolezza in cui si trova, conosce gli altri solo per l’assistenza e le cure che ne riceve. Dapprima l’affezione che prova per la nutrice e per la governante non è che abitudine. Le ricerca perché ha bisogno di loro e gli fa comodo poterne disporre: è piuttosto conoscenza, questa, che benevolenza. Gli occorre molto tempo per capire che non soltanto gli sono utili, ma che vogliono esserlo; ed è allora che comincia ad amarle.
Un fanciullo è dunque naturalmente incline alla benevolenza, perché vede che quanti gli sono accanto tendono ad assisterlo e da tale osservazione deriva in lui l’abitudine a nutrire un sentimento amichevole verso i suoi simili. Ma via via che si estendono le sue relazioni, i suoi bisogni, i suoi legami di dipendenza, in senso attivo e passivo, si desta il sentimento dei suoi rapporti con gli altri e produce quello dei doveri e delle preferenze. Allora il fanciullo diviene imperioso, geloso, ingannatore e vendicativo. Se costretto all’obbedienza, non vedendo l’utilità di ciò che gli viene comandato, l’attribuisce al capriccio, all’intenzione di tormentarlo, e si rivolta. Se poi si obbedisce alla sua volontà, non appena qualche cosa gli resiste, vi scorge un atto di ribellione, una resistenza intenzionale: percuote così la sedia o il tavolo per avergli disobbedito. L’amore di sé, che prende in considerazione esclusivamente noi stessi, è contento quando i nostri veri bisogni sono soddisfatti; ma l’amor proprio, che implica il confronto, non è mai contento né potrebbe esserlo, perché questo sentimento, portandoci a preferire noi stessi agli altri, esige anche che gli altri ci preferiscano a loro, e questo è impossibile. Ecco perché le passioni dolci e affettuose nascono dall’amore di sé, le passioni dell’odio e dell’ira dall’amor proprio.85 Così, ciò che rende l’uomo essenzialmente buono è l’aver pochi bisogni e il confrontarsi poco con gli altri; ciò che lo rende essenzialmente cattivo è l’aver molti bisogni e il tener molto all’opinione altrui. In base a questo principio è facile vedere come sia possibile volgere al bene o al male tutte le passioni dei fanciulli e degli uomini. Vero è però che, non potendo vivere sempre soli, difficilmente vivranno sempre buoni: anzi, questa difficoltà aumenterà necessariamente con l’estendersi delle loro relazioni ed è soprattutto per questo che i pericoli della società rendono più indispensabile ogni genere di espedienti e di cure per prevenire nel cuore umano la depravazione che nasce dai suoi nuovi bisogni.
Lo studio più adatto all’uomo è quello dei suoi rapporti. Finché non conosce se stesso che come essere fisico, deve studiarsi nei suoi rapporti con le cose: tale è il compito della fanciullezza. Quando comincia ad avvertire il proprio essere morale, deve studiarsi nei suoi rapporti con gli uomini: è il compito di tutta la sua vita, a cominciare dal punto cui siamo giunti.
Non appena l’uomo ha bisogno di una compagna, non è più un essere isolato, il suo cuore non è più solo. Tutte le relazioni con í suoi simili, tutti gli affetti della sua anima nascono con questo. La sua prima passione fa ben presto fermentare le altre.
L’inclinazione dell’istinto è indeterminata. Un sesso si sente attirato verso l’altro: tale è l’impulso dato dalla natura. La scelta, le preferenze, l’affezione personale sono frutto del sapere, dei pregiudizi, dell’abitudine: occorrono tempo e cognizioni per renderci capaci d’amore; l’uomo ama dopo aver giudicato, preferisce dopo aver confrontato. Questi giudizi sono da lui formulati senza che se ne accorga, ma non per questo sono meno reali. Il vero amore, qualunque cosa se ne dica, sarà sempre onorato dagli uomini: benché i suoi impeti ci sconvolgano, benché non escluda e addirittura generi qualità odiose nel cuore che lo sente, sempre però ne presuppone altre degne di stima, senza le quali non saremmo neppure in grado di sentirlo. Le sue scelte, che si sogliono considerare in contrasto con la ragione, è proprio la ragione a dettarle. Vogliamo credere che l’amore sia cieco, perché ha occhi migliori dei nostri e vede rapporti che noi non possiamo scorgere. A chi non avesse alcuna idea di merito e di bellezza, ogni donna riuscirebbe egualmente gradita e la prima venuta sarebbe la più amabile. Ma l’amore, lungi dall’essere opera della natura, è regola e freno delle sue inclinazioni: è per opera sua che, tranne la persona amata, l’un sesso perde ogni fascino agli occhi dell’altro.
La preferenza che si accorda vuol essere contraccambiata: l’amore deve essere reciproco. Per essere amati, bisogna diventare amabili; per essere preferiti, bisogna diventare più amabili di un altro, più amabili di ogni altro, almeno agli occhi della persona amata. Di qui hanno origine i primi sguardi gettati sui propri simili, di qui i primi confronti con loro, e l’emulazione, la rivalità, la gelosia. Un cuore che trabocca di sentimento desidera trovare sfogo: dal bisogno di un’amante nasce quello di un amico. Colui che sente quanto sia dolce essere amato, vorrebbe che tutti lo amassero, ed è impossibile che tutti vogliano essere preferiti senza che molti tra loro restino insoddisfatti. Con l’amore e l’amicizia nascono i dissensi, l’inimicizia, l’odio. Su tante e così diverse passioni vedo l’opinione costruirsi un trono incrollabile e gli sciocchi mortali, asserviti al suo potere, fondare la propria esistenza unicamente sui giudizi altrui.
Svolgete fino in fondo queste idee e vedrete donde il nostro amor proprio tragga quella forma che crediamo naturale, vedrete come l’amore di sé, cessando di essere un sentimento assoluto, diventi orgoglio nelle anime grandi, vanità in quelle meschine, e in tutte senza posa si alimenti a spese del prossimo. Questa specie di passioni, poiché non ha il suo germe nel cuore dei fanciulli, non può nascervi spontaneamente; siamo noi soli ad introdurvele, né mai vi mettono radice se non per colpa nostra. Ma ben diverso è il cuore del giovane: qualunque cosa si faccia, vi nasceranno nostro malgrado. È dunque tempo di cambiare metodo.
Cominciamo con alcune importanti riflessioni sullo stato critico che ora stiamo esaminando. Il passaggio dalla fanciullezza alla pubertà non è così stabilmente determinato dalla natura da non variare negli individui a seconda del temperamento e nei popoli a seconda del clima. Tutti sanno quali differenze siano state rilevate a questo proposito tra paesi caldi e paesi freddi e ciascuno vede come gli individui dal temperamento ardente si sviluppino più rapidamente degli altri. Ma è possibile ingannarsi sulle cause e spesso si attribuisce ai fattori fisici ciò che dipende dai fattori morali: è uno degli equivoci più frequenti nella filosofia del nostro secolo. Gli insegnamenti della natura sono tardivi e lenti, quelli degli uomini quasi sempre prematuri. Nel primo caso, i sensi svegliano l’immaginazione; nel secondo, l’immaginazione sveglia i sensi e li eccita a un’attività precoce che inevitabilmente indebolisce e snerva dapprima gli individui, poi, alla lunga, la stessa specie umana. Un’osservazione più generale e più sicura di quella condotta sugli effetti del clima è che la pubertà e la maturità sessuale sono sempre più precoci presso i popoli colti e civili che presso quelli barbari e rozzi.a I fanciulli hanno una singolare sagacia per scoprire i cattivi costumi dietro tutte le ipocrisie di cui la decenza li ammanta. L’imposizione di un linguaggio castigato, le varie lezioni di onestà, il velo di mistero che palesemente viene teso dinanzi ai loro occhi sono altrettanti pungoli alla loro curiosità. È chiaro che questo modo di fare ha l’unico effetto di insegnare ai fanciulli proprio ciò che si finge di voler nascondere, e tra tutti gli insegnamenti che ricevono è questo che si rivela di gran lunga il più efficace.
Consultate l’esperienza e comprenderete fino a qual punto questo metodo insensato acceleri l’opera della natura e rovini il temperamento. È qui una delle cause principali della degenerazione delle razze nelle città. I giovani, svigoriti anzi tempo, restano piccoli, deboli, malfatti, invecchiano anziché crescere, come la vite costretta a dar frutti in primavera languisce e muore prima dell’autunno.
Bisogna aver vissuto presso popoli semplici e rozzi per conoscere fino a quale età una felice ignoranza possa prolungare l’innocenza della fanciullezza. È uno spettacolo che induce alla commozione e insieme al sorriso vedere giovanetti dei due sessi, abbandonati alla serena tranquillità dei loro cuori, continuare nel fiore dell’età e della bellezza i giuochi ingenui dell’infanzia e mostrare proprio mediante la loro familiarità la purezza dei loro piaceri. Quando infine questa amabile gioventù giunge al matrimonio, i due sposi, donandosi reciprocamente le primizie della loro persona, si stringono l’un l’altro di più dolci vincoli d’affetto e i numerosi figlioli, sani e robusti, divengono il pegno di un’unione che nulla altera, il frutto della saggezza dei loro primi anni.
Se l’età in cui l’uomo acquista coscienza del proprio sesso varia sia per effetto dell’educazione che per opera della natura, ne consegue che è possibile anticipare o ritardare questa età a seconda della maniera in cui si allevano i fanciulli; e se il corpo guadagna o perde di robustezza per la minore o maggiore rapidità di questo processo, è chiaro che, quanto più ci sforziamo di ritardarlo, tanto più il giovane acquista di vigore e di forza. Non parlo per ora che degli effetti puramente fisici, ma presto vedremo come tali effetti siano ben più vasti.
Educazione sessuale
Da queste riflessioni traggo la soluzione del problema tanto dibattuto, se convenga informare subito i fanciulli intorno agli oggetti della loro curiosità o se sia meglio trarli in inganno inducendoli in modesti errori. Penso che non si debba fare né l’una cosa né l’altra. In primo luogo, questa curiosità non nasce in loro senza che se ne sia offerta l’occasione. Bisogna dunque evitare che l’occasione si offra. In secondo luogo, le domande cui non è indispensabile rispondere non esigono affatto che s’inganni colui che le pone: è meglio imporgli il silenzio che rispondere con la menzogna. Né questa legge gli sembrerà strana, se si è avuto cura di applicarla in cose per lui indifferenti. Infine, se si decide di rispondere, si parli con la più grande semplicità, senza mistero, senza imbarazzo, senza sorrisi. È molto meno pericoloso soddisfare la curiosità del fanciullo che eccitarla.
Le vostre risposte siano serie, brevi, decise, senza ombra di esitazione. Non ho bisogno di aggiungere che debbono essere vere. Non si può far capire ai fanciulli il pericolo di mentire agli uomini, senza che si avverta da parte degli uomini il pericolo ancora più grande di mentire ai fanciulli. Una sola menzogna del maestro scoperta dall’allievo rovinerebbe per sempre tutto il frutto dell’educazione.
Un’ignoranza assolu...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Premessa del traduttore. di Paolo Massimi
- Introduzione. di François e Pierre Richard
- Bibliografia
- Emilio. o Dell’educazione
- Prefazione
- Libro primo
- Libro secondo
- Libro terzo
- Libro quarto
- Libro quinto
- Note al testo di François e Pierre Richard. (dall’edizione Garnier Frères)
- Postfazione. di Claude Lévi-Strauss
- Copyright