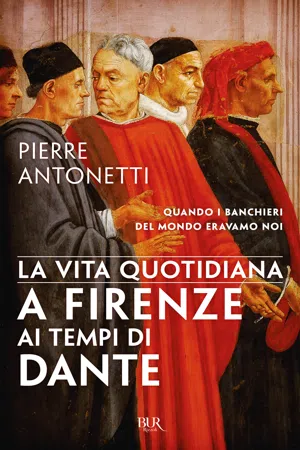![]()
PARTE QUINTA
La vita culturale
![]()
I
La scuola
Nella sua descrizione della Firenze del 1338 il cronista Villani si sofferma un momento sull’educazione pubblica e privata. «Troviamo ch’ e’ fanciulli e fanciulle che stanno a leggere, da otto a dieci mila. I fanciulli che stanno a imparare l’abbaco e algorismo in sei scuole, da mille in milleduecento. E questi che stanno ad apprendere la grammatica e loica in quattro grandi scuole, da cinquecentocinquanta in seicento.» (Cronica, XI, 94). Questo quadro necessita di alcune spiegazioni.
La nostra concezione di scuola dell’obbligo, laica e gratuita, non ha alcun riscontro nel Medioevo dove la scuola è facoltativa, clericale e a pagamento. Tuttavia l’istruzione viene avvertita, nella Firenze di Dante, come una necessità da parte dei borghesi e dei chierici, come un che di utile, se non indispensabile, dall’aristocrazia, come un lusso inaccessibile dal popolo minuto e dai contadini. Stando così le cose l’istruzione era assai diffusa e le cifre del Villani sono significative. Il fatto che da otto a diecimila ragazzi imparavano a leggere (cioè frequentavano la scuola elementare) costituisce una percentuale notevole (il decimo della popolazione complessiva).
Una seconda spiegazione necessaria si riferisce all’organizzazione degli studi. L’orizzonte culturale era allora abbastanza ristretto. La tendenza all’enciclopedismo, che caratterizza il nostro sistema educativo, era allora riservata all’insegnamento superiore e dunque non era presente nella scuola elementare e secondaria. Questa ristrettezza dell’orizzonte culturale si giustifica con la finalità che si proponevano l’insegnamento elementare e quello secondario che consisteva nel preparare alla vita attiva. Saper leggere e far di conto, ecco cos’è essenziale per i futuri commercianti. Lo studio speculativo è riservato ai chierici e agli studenti universitari. Per quanto concerne le arti d’ornamento (danza, canto, poesia, musica, disegno ecc.), esse sono utili soltanto alle ragazze dell’aristocrazia e della grande borghesia affaristica. Nonostante ciò sono incluse spessissimo nelle scuole superiori e seguiti da tutti coloro che si interessano di lettere. Dante le ha imparate tutte nella sua giovinezza.
La terza spiegazione riguarda la piramide degli studi. Contrariamente a quanto avviene nelle società contemporanee l’accesso alle scuole secondarie, e con maggior ragione a quelle superiori, era più limitato che non oggi. A questo riguardo le cifre del Villani, impressionanti per la scuola elementare, sono modeste per la secondaria e quasi inconsistenti per la superiore: da cinque a seicento studenti su una popolazione complessiva di più di centomila abitanti rappresentano solo lo 0,5 o lo 0,6%.
Una quarta spiegazione concerne la gerarchia degli studi. Se la distinzione fra elementari e medie è abbastanza facile a farsi, quella fra medie e università è assai sfumata: «Le università medioevali non sono soltanto istituti di insegnamento superiore. I nostri insegnamenti elementari e secondari vi erano solo in parte elargiti o erano da esse controllati. Il sistema dei collegi inoltre [...] aumentò maggiormente questa confusione offrendo, sin dall’età di 8 anni, l’insegnamento ai suoi membri».1
La quinta spiegazione verte sul posto che in esso occupava il latino. Il latino è, infatti, il pane quotidiano di ogni allievo delle scuole confessionali cioè delle scuole episcopali e di quelle conventuali. Ma esso occupa anche un posto importante nell’insegnamento laico in quanto era necessario alla comprensione degli atti ufficiali o privati, redatti in latino, ed era la base per ogni tipo di cultura letteraria e scientifica.
Una sesta spiegazione riguarda le tecniche dell’insegnamento. L’apprendimento a memoria è essenziale. Si impara tutto mnemonicamente e la bacchetta punisce i vuoti di memoria. Si impara a memoria anche per la rarità dei libri e per il loro prezzo eccessivo. Lo stesso insegnante ne possiede soltanto alcuni, i privati ancor meno: «Una biblioteca di dodici volumi era per il privato un fatto considerevole».2 Certo, in quel periodo i libri non erano più opere di lusso che «non sono fatti per essere letti... ma per accrescere i tesori delle chiese, dei ricchi privati».3 La loro estrema rarità, dovuta al fatto che essi sono tutti manoscritti e che la loro riproduzione manuale è lunga e costosa, rende necessario l’apprendimento mnemonico.
Un’ultima spiegazione. L’insegnamento è basato sull’autorità del maestro. L’allievo impara a memoria e ripete ciò che il maestro ha detto: cosa che non si può contestare né che può essere contestata. Magister dixit è la sentenza conclusiva di ogni disputano. Del resto, il magister si distingue anche per il suo vestiario e si fa rispettare usando la punizione corporale (soltanto nella scuola primaria e secondaria) talvolta in maniera così violenta che alcuni allievi fuggivano dalla scuola; perciò gli statuti comunali regolamentavano la gravità delle punizioni.
L’insegnamento elementare
L’insegnamento elementare è rimasto per molto tempo appannaggio dei chierici. Ma sin dal XII secolo vi si dedicarono anche alcuni laici. Si contano quattro o cinque doctores puerorum a Firenze prima del 1300, fra i quali un tale Romanus che figura in un documento del 1277 della famiglia Alighieri e che è stato forse il primo maestro di Dante.4 Sembra anche che questi doctores puerorum formassero un’Arte nel 1316 insieme ai maestri d’abaco e di grammatica (vedere in seguito).
Come tutti i ragazzi del suo tempo Dante dovette andare alla scuola primaria a sei o sette anni per restarvi sino a undici anni circa. Imparò a leggere, a scrivere, a far di conto e anche a redigere gli atti notarili. L’anno scolastico aveva inizio intorno al 29 settembre. La giornata scolastica comportava un numero di ore che noi non conosciamo. Il locale era situato in una parte del domicilio personale del maestro, assistito o meno da un collega. L’insegnamento era retribuito ma il salario (fissato di volta in volta con la famiglia) era così modesto che, all’inizio del XIV secolo, i maestri della scuola primaria vengono esentati dal pagare le imposte. Questi doctores o magistri puerorum avevano diritto al titolo di ser che condividevano con i notai e medici. Essi ricevevano dei regali o dei doni in natura in occasione delle festività e degli esami.
Per le ragazze l’insegnamento, impartito da donne, comprendeva anche le arti domestiche così come la danza e la musica, in quanto il fine dell’educazione era quello di formare delle buone donne di casa addottrinate in tutto ciò che riguardava la conduzione di una famiglia: la masserizia. È superfluo aggiungere che le grandi famiglie aristocratiche e quelle della borghesia affaristica ricorrevano a precettori privati, sia uomini che donne.
La scuola media
All’insegnamento elementare, detto dei non facientes latinum o dei pueri a tabula usque ad Donatum, seguiva l’insegnamento secondario5 che iniziava intorno agli undici anni. Riservato appena a mille-mille e duecento allievi invece degli otto-diecimila allievi della scuola primaria, era rivolto precipuamente ai ragazzi delle famiglie dei commercianti e degli industriali in quanto li si preparava al loro futuro mestiere di dirigenti. Esso comprendeva dapprima la scuola di abbaco o algorismo in cui venivano insegnati principalmente il calcolo, l’astronomia, la geometria, l’algebra ma anche il calcolo finanziario come l’ammortamento di un prestito a interesse composto.6 Questi due o tre anni d’abbaco o algorismo, che erano talvolta integrati nelle aziende bancarie o industriali, costituivano dunque l’apprendistato teorico di un dirigente che veniva completato con lo studio di una pratica di mercatura, volume in cui si apprendevano i sistemi di misura delle diverse piazze mercantili e bancarie d’Europa, e dallo studio dei «portolani»: mappe delle coste del mondo allora conosciuto. Impartito in sei scuole, questo insegnamento era il più ricercato di Firenze. Gli studi prettamente umanistici o letterari (la grammatica) erano meno diffusi: nel 1339 v’erano soltanto quattro scuole (quante nella Firenze di Dante?). Un allievo assai dotato poteva seguire contemporaneamente l’abbaco e la grammatica. Quest’ultima richiedeva due anni e mezzo o tre e si divideva in due cicli. Il primo veniva svolto secondo l’insegnamento di Donato, grammatico romano della metà del IV secolo che era stato il maestro di San Girolamo e che Dante colloca nel Paradiso (XII, 137-138).7 Era l’autore di una Ars grammatica divisa in Ars minor e Ars major che era il manuale per così dire ufficiale della scuola del primo ciclo. Il secondo ciclo veniva svolto secondo l’insegnamento di Prisciano: grammatico latino della seconda metà del V secolo,8 che Dante colloca nell’Inferno (XV, 109) accusandolo di sodomia. Autore d’Institutiones grammaticae divise in due libri (Priscianus minor e Priscianus major) Prisciano introduceva anche alla letteratura latina (Virgilio, Plauto, Lucano, Orazio, Giovenale, Ovidio, Sallustio, Persio, Lucrezio e altri). Così Donato e Prisciano servivano quale iniziazione per una buona conoscenza del latino e della letteratura romana. Dante apprese le prime nozioni dall’uno e dall’altro. Altri volumi recavano un indispensabile complemento per la storia e la mitologia classica. Così i Disticha Catonis di un tale Catone del III o V secolo, che non aveva nulla a che vedere con l’Uticense, nei quali Dante si iniziò allo stoicismo e imparò alcuni aforismi che si confacevano alla vita interiore, domestica e sociale.9 Aggiungiamo le finzioni d’Esopo: una raccolta di favole di Fedro che ha quale autore un Romulus del X secolo. È in quest’Isopo o Isopetto, come veniva chiamato, che Dante ha letto alcune favole che ha poi collocate nella sua opera.10 Aggiungiamo anche un Theodolus o Ecloga Theoduli: opera del VI o VII secolo in cui, attraverso una allegoria, si dimostra la superiorità della fede cristiana sulle altre. Dante ne trae diversi spunti per il suo Purgatorio (canti XII e XIV) e a essa deve parte della sua conoscenza della mitologia antica e della storia sacra. Se vi si aggiungono altre due o tre opere minori, fra cui un manuale civico, si ha allora l’intera biblioteca di un contemporaneo di Dante. Ora «se tutto ciò venisse stampato non supererebbe le cento pagine».11
Ed è con quest’insieme di conoscenze, invero assai modeste, che Dante abbandonò la scuola secondaria in una data che ignoriamo, ma presumibilmente intorno ai quindici o, al massimo, diciassette anni. Egli sapeva dunque il latino, un po’ di storia e di mitologia classica, un po’ di storia sacra e poteva scrivere bellissimi sonetti; il primo è del 1283 quando aveva 18 anni.
L’università12
La Firenze di Dante non aveva una università mentre Arezzo ne ebbe una a partire dal 1215 e Siena dal 1246, per non parlare di Bologna: una delle più antiche e più prestigiose insieme a Oxford, Parigi e Salamanca. Ciò nonostante sin dal XII secolo esisteva un embrionale insegnamento superiore so...