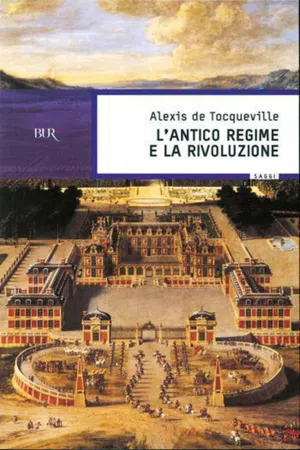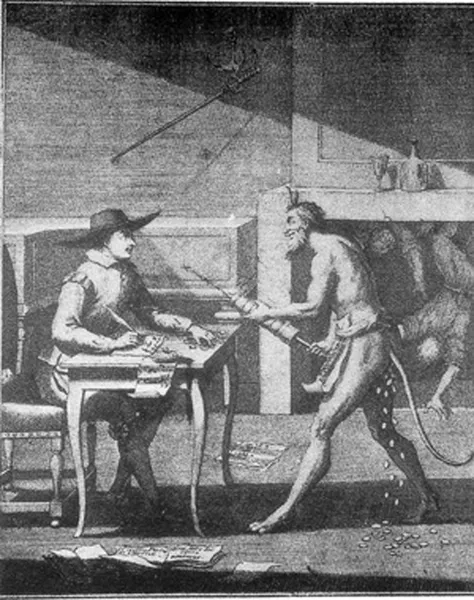PREFAZIONE
Il libro che oggi pubblico non è una storia della rivoluzione, storia già stata fatta con troppo splendore perché io pensi di rifarla; ma uno studio su questa rivoluzione.
Nel 1789 i francesi hanno compiuto il più grande sforzo che mai popolo abbia affrontato per tagliare in due, per così dire, il loro destino e separare con un abisso quello che erano stati fino allora da quello che ormai volevano essere. A questo scopo hanno preso ogni genere di precauzioni per non portare nulla del passato nella loro nuova condizione; si sono imposti ogni genere di costrizioni per farsi diversi dai loro padri; non dimenticando nulla infine per rendersi irriconoscibili.
Avevo sempre pensato che in questo strano compito fossero riusciti meno di quanto era stato creduto all’estero e di quanto essi stessi avevano creduto in un primo tempo. Ero convinto che, senza rendersene conto, avessero conservato per lo più i sentimenti, abitudini dell’antico regime e perfino le idee con le quali avevano guidato la rivoluzione che doveva distruggerlo, e che senza volerlo si erano serviti dei suoi frammenti per costruire l’edificio della nuova società. Così, per ben capire la rivoluzione e l’opera sua, bisogna dimenticare la Francia quale la vediamo e interrogare nella sua tomba la Francia che non è più. Questo io ho cercato di fare, ma mi è stato più difficile di quanto non avessi creduto.
I primi secoli della monarchia, il Medio Evo, il Rinascimento, sono stati oggetto di immenso lavoro, di ricerche molto approfondite le quali ci hanno fatto conoscere non soltanto gli avvenimenti di allora ma le leggi, gli usi, lo spirito del governo e della nazione in tali epoche. Nessuno finora si è dato pensiero di considerare in questo modo e così da vicino il diciottesimo secolo. Crediamo di conoscere molto bene la società francese di quel tempo perché vediamo chiaramente quanto brillava alla sua superficie, perché possediamo fin nei particolari la storia dei suoi più celebri personaggi e perché critici geniali ed eloquenti ci hanno reso completamente familiari le opere dei grandi scrittori che lo illustrarono. Ma, sul come venivano condotti gli affari, sulla vera pratica delle istituzioni, sulla posizione esatta delle varie classi l’una di fronte all’altra, sulla condizione e i sentimenti di quelle che ancora non riuscivano a farsi né sentire né vedere, sul fondo stesso delle opinioni e dei costumi, abbiamo soltanto idee confuse e spesso piene di errori.
Io mi sono proposto di penetrare fino al cuore di questo antico regime, tanto vicino a noi nel tempo e che la Rivoluzione ci nasconde.
Per riuscirvi non ho riletto soltanto i grandi libri del diciottesimo secolo, ma ho voluto studiare molti lavori meno conosciuti e meno degni di esserlo. Composti senza soverchia arte rivelano forse meglio i veri istinti del tempo. Ho voluto conoscere bene tutti gli atti pubblici in cui i francesi han potuto, all’avvicinarsi della rivoluzione, rivelare le loro opinioni e le loro inclinazioni. I verbali delle assemblee di Stati e poi delle assemblee provinciali hanno chiarito molto questo punto. Mi attenni soprattutto ai cahiers redatti dai tre Stati nel 1789. Questi cahiers, i cui originali formano una lunga serie di volumi manoscritti, rimarranno come il testamento dell’antica società francese, la suprema espressione dei suoi desideri, l’autentica manifestazione delle sue ultime volontà; documento unico nella storia.
Tuttavia questo non mi è bastato.
Nei paesi in cui l’amministrazione pubblica è già potente, nascono poche idee, desideri, dolori; si incontrano pochi interessi e passioni che presto o tardi non si mostrino a nudo davanti ad essa. La visita ai suoi archivi non dà soltanto l’esattissima nozione dei suoi procedimenti, ma ci rivela interamente il paese. Uno straniero al quale oggi si abbandonassero tutte le corrispondenze riservate che empiono i fascicoli del Ministero dell’Interno e delle prefetture ne saprebbe presto su noi più di noi stessi. Nel diciottesimo secolo l’amministrazione pubblica, come si vedrà leggendo questo libro, era già molto accentrata e potente, prodigiosamente attiva. Aiutava, impediva, permetteva instancabilmente. Aveva molto da promettere e molto da dare. Già in mille modi influiva non soltanto sul corso generale degli affari, ma sulla sorte delle famiglie e sulla vita privata di ognuno. Inoltre non aveva pubblicità, perciò non si temeva di esporre ai suoi occhi le infermità più segrete. Ho passato molto tempo a studiare quanto ci resta di essa, sia a Parigi, sia in parecchie provincie1. Là, come mi aspettavo, ho trovato veramente vivo l’antico regime, le sue idee, i suoi pregiudizi, la sua pratica. Ognuno vi parlava liberamente il proprio linguaggio e lasciava intendere i suoi più intimi pensieri. Così ho pienamente acquistato sull’antica società molte nozioni che mancavano ai contemporanei perché a loro non era mai stato permesso di vedere quanto io avevo sotto gli occhi.
A mano a mano che mi inoltravo in questo studio, mi stupivo riconoscendo ad ogni passo nella Francia di quel tempo molti di quelli che sono i segni più evidenti della Francia odierna. Vi ritrovavo una folla di sentimenti che credevo nati dalla rivoluzione, una folla di idee che fino allora avevo creduto ci venissero da essa; mille abitudini che essa sola sembra averci dato; ovunque trovavo le radici della società presente profondamente piantate in questo vecchio suolo. Più mi avvicinavo al 1789, più scorgevo distintamente formarsi, nascere e crescere lo spirito che ha fatto la rivoluzione. A poco a poco si rivelava ai miei occhi tutta la fisionomia di questa Rivoluzione. Già si annunziavano il suo carattere, il suo genio; già era lei. Vi trovai non soltanto la ragione di quanto avrebbe fatto nel suo primo sforzo, ma più ancora, forse, il presentimento di quanto avrebbe fatto in seguito. Infatti la rivoluzione ha avuto due fasi ben distinte: la prima, durante la quale i francesi sembrano voler abolire tutto il passato; la seconda, in cui avrebbero ripreso una parte di quello che avevano lasciato. Gran numero di leggi e di abitudini politiche dell’antico regime spariscono bruscamente nel 1789 per riapparire qualche anno dopo, come certi fiumi sprofondano nella terra per riaffiorare poco distante, portando fra nuove rive le medesime acque.
Il vero scopo del lavoro che presento al pubblico è quello di far comprendere perché questa grande rivoluzione, la quale si preparava nello stesso tempo su quasi tutto il continente europeo, scoppiasse da noi invece che altrove, perché uscisse quasi spontaneamente dalla società che avrebbe distrutto, e come infine l’antica monarchia sia caduta in modo così completo ed improvviso.
Nel mio pensiero l’opera che ho cominciato non deve limitarsi a questo. È mia intenzione, se il tempo e le forze non mi mancheranno, seguire, attraverso le vicissitudini di questa lunga rivoluzione, quegli stessi francesi con i quali ho vissuto tanto intimamente sotto l’antico regime, quel regime che li aveva formati, per vederli modificarsi secondo gli avvenimenti, senza tuttavia mutar natura e riapparire di continuo davanti a noi con una fisonomia un poco diversa, ma sempre riconoscibile.
Dapprima percorrerò con loro quel primo tempo dell’89, in cui i loro cuori sono divisi tra l’amore dell’eguaglianza e quello della libertà e in cui essi vogliono fondare non soltanto istituzioni democratiche, ma istituzioni libere, non soltanto distruggere i privilegi, ma riconoscere e consacrare i diritti; tempo di giovinezza, di entusiasmo, di orgoglio, di passioni generose e sincere, e di cui gli uomini, ad onta dei suoi errori, serberanno eterno ricordo; tempo che turberà ancora a lungo il sonno di quanti vorranno corromperli o asservirli.
Seguendo rapidamente il corso di questa medesima rivoluzione, tenterò di mostrare attraverso quali avvenimenti, quali errori e quali delusioni quegli stessi francesi siano giunti ad abbandonare i loro primi scopi e, dimenticando la libertà, abbiano voluto soltanto divenire i servi tutti eguali del padrone del mondo; e come un governo più forte e molto più assoluto di quello rovesciato dalla rivoluzione abbia riafferrato allora e accentrato in sé tutti i poteri, soppresso tutte le libertà tanto duramente pagate, sostituendole con vane immagini; chiamando sovranità popolare i suffragi di elettori che non possono né informarsi, né concertarsi, né scegliere; voto libero dalle imposte l’assenso di assemblee mute, o asservite; e, mentre toglie alla nazione la facoltà di governarsi, le principali garanzie del diritto, la libertà di pensare, di parlare, di scrivere, vale a dire quanto v’era stato di più prezioso e nobile nelle conquiste dell’89, si adorna ancora di quel gran nome.
Mi fermerò al momento in cui la rivoluzione mi sembrerà aver quasi compiuta l’opera sua e partorito la società nuova. Osserverò allora questa società, tenterò di discernere in che cosa essa assomiglia a quella che l’ha preceduta, in che cosa ne differisce, quanto abbiamo perduto in questo immenso sconvolgimento di cose e quanto abbiamo guadagnato. Mi proverò infine a intravedere il nostro avvenire.
Una parte di questo secondo lavoro è abbozzata, ma non degna ancora di esser presentata al pubblico. Mi sarà dato di terminarla? Chi può dirlo? Il destino degli individui è anche molto più oscuro di quello dei popoli.
Spero di avere scritto questo libro senza preconcetti, ma non pretendo di averlo scritto senza passione. Sarebbe appena permesso a un francese di non sentirne quando parla del proprio paese e pensa al proprio tempo. Confesso dunque che studiando in ogni sua parte la nostra vecchia società non ho mai perso interamente di vista la nuova. Non ho voluto soltanto conoscere il male che aveva ucciso il malato, ma anche come avrebbe potuto non morire. Ho fatto come quei medici che in ogni organo morto tentano di sorprendere le leggi della vita. Il mio scopo è stato di fare un quadro strettamente esatto che potesse anche ammaestrare. Ogni volta dunque che ho incontrato nei nostri padri qualcuna di quelle maschie virtù che più sarebbero necessarie e che quasi non abbiamo più, un vero spirito di indipendenza, l’amore delle cose grandi, la fede in sé stessi e in una causa, le ho poste in rilievo; così quando ho incontrato nelle leggi, nelle idee, nei costumi di quel tempo, la traccia di qualche vizio che dopo aver divorato la vecchia società ci tormenta ancora, ho avuto cura di illuminarlo, perché vedendo chiaramente il male che ci ha fatto si capisse meglio quello che potrebbe ancora farci.
Per questo scopo non ho temuto, lo confesso, di ferire alcuno, né individui né classi né opinioni né ricordi, per quanto rispettabili fossero. Quelli a cui ho potuto dispiacere in questo modo mi scusino, tenendo conto del fine disinteressato e onesto al quale tendo.
Parecchi mi accuseranno forse di palesare in questo libro un amore intempestivo per la libertà, di cui, mi si assicura, nessuno in Francia si cura più.
Pregherò quelli che mi rivolgeranno questo rimprovero di voler almeno considerare come quell’amore sia molto antico in me. Più di vent’anni fa, parlando di un’altra società, scrivevo quasi testualmente quanto segue.
Fra le tenebre dell’avvenire tre verità si possono già...