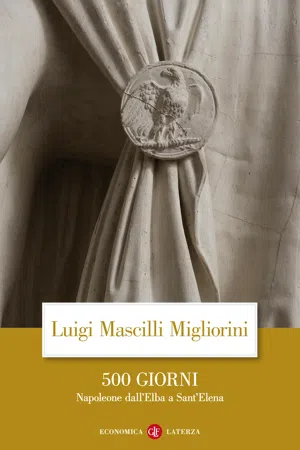V.
Waterloo
La diplomazia della disperazione: così viene definita dagli storici quella breve stagione nella quale penosamente e ostinatamente la Francia dei Cento Giorni cerca di convincere le potenze europee della sincera volontà di Napoleone di abbandonare ogni ipotetico disegno di conquista per esercitare con misura una sovranità riconquistata in maniera inattesa, quasi miracolosa; quel tempo, cioè, adoperato per spiegare agli uomini ancora riuniti nelle sale dell’Hofburg viennese o intorno ai tavoli della Ballplatz, che quel progetto, che da mesi essi inseguono, di una Francia “contenuta, pacifica e pacificata” è anche il progetto di un Imperatore profondamente cambiato e denudato di ogni irrequietudine. Tale diplomazia della disperazione ha un suo punto di arrivo, un suo atto finale1; che è la lettera con la quale Caulaincourt, protagonista infaticabile e riluttante di questa diplomazia, l’uomo che non crede alla possibilità che essa abbia successo e, forse, non crede neppure fino in fondo che il suo sovrano sia, o voglia, o possa essere davvero altro da quello che è sempre stato, annuncia il fallimento della propria azione: “La guerra – scrive a Napoleone il 7 giugno – è dappertutto”2.
Non sarebbe giusto affermare che quell’annuncio giungesse improvviso o, peggio, inaspettato. Sarebbe meglio dire che tutti, dal momento in cui Napoleone aveva rimesso piede alle Tuileries avevano avuto la certezza che, in uno spazio di tempo più o meno breve, sarebbe scoppiata una nuova guerra tra la Francia della Rivoluzione, di Napoleone, e l’Europa della conservazione. Nessuno sapeva, ovviamente, dire né quando, né in che forma, e soprattutto nessuno sapeva prevederne l’esito, dal momento che la sproporzione evidente delle forze in campo a vantaggio del fronte delle antiche dinastie sembrava, nell’opinione dei più anche fuori della Francia, sufficientemente equilibrata dal genio militare di Napoleone e dalla passione con la quale fino a quel momento la nazione francese aveva seguito il suo vittorioso condottiero.
Nonostante questo, molti, se non tutti, preferiscono illudersi, o, più esattamente, preferiscono fare del silenzio lo strumento per esorcizzare i loro timori, via via che lo svolgersi degli avvenimenti – nell’apparente stabilità di una nazione che si ritrova a discutere con veemenza le nuove fondamenta del suo patto costituzionale – corre verso una conclusione abbondantemente prevista. È già il 19 maggio quando Prosper de Barante, futuro pari della Francia borbonica e futuro ambasciatore della Francia orléanista – confida alla moglie che da due giorni ormai “ci si confessa – così egli scrive – la triste necessità della guerra”3. Ed è il 2 giugno quando il liberale Charles Sismondi, sedotto da Napoleone al punto da credere a lungo che sarà possibile conservare la pace, deve arrendersi e scrivere alla madre ansiosa, ma assai più lucida di lui nella percezione del pericolo: “scoppierà la guerra”4.
Ci vuole tempo, insomma, perché una percezione largamente condivisa riconosca se stessa come una certezza priva di alternative; e questo tempo trascorre esorcizzando, tacendola, la parola che darebbe a un tale percorso collettivo un’accelerazione indesiderata. Non che si possa dire che la Francia, e forse neppure il suo Imperatore, siano preparati, maturi, nel momento in cui – ai primi giorni di giugno – la guerra (come dice Caulaincourt) è ormai così universalmente visibile da non poter più essere negata5. Tuttavia si è arrivati, in quei giorni, a una sorta di ineluttabilità di ciò che dovrà succedere che ne rende – come accade spesso in questi casi – più morbida, quasi più dolce l’accettazione, al punto che la parola interdetta può essere pronunciata e riesce, finalmente, a restituire al contesto una verità che esso si è negato e che gli è stata negata.
Il velo, squarciato il 1° giugno dallo slancio con il quale Napoleone abbandona il trono posticcio del Campo di Maggio e ritrova la sua verità tra i soldati che lo acclamano e che si dichiarano pronti – come assai presto accadrà – a morire per lui, torna, solo dopo poche ore, a mascherare cose e uomini. Già il giorno successivo, il 2 giugno, l’Imperatore è di nuovo alle prese con una singolare, quanto poco credibile quotidianità. Si tratta, in quel giorno, di scegliere tra le varie liste che gli erano state preparate dai suoi ministri, i membri di quella Camera dei Pari, alla quale, dopo lo scacco subito nelle elezioni per la Camera dei rappresentanti e dopo il fallimento del Campo di Maggio, egli è sollecitato, costretto quasi, ad affidarsi per mantenere autorità ed equilibrio nel rinnovato sistema istituzionale. L’uomo che ha appena smesso di eccitare i sentimenti popolari, chiamando tutti alla difesa della nazione, adesso esamina candidature, soppesa proposte, giudica nomi come se nulla di quello che il giorno precedente era stato mostrato come il pericolo grave per la patria fosse in realtà imminente.
L’elenco dei prescelti suscita – come racconta un testimone anche abbastanza benevolo – indifferenza o, peggio, ilarità. “Si sorride, si alzano le spalle”, annota John Hobhouse, costretto, tuttavia, egli pure a riconoscere che trovare un equilibrio plausibile non era facile dovendo mediare tra ceti, interessi, vanità, ambizioni diversi e contrastanti, avendo un obiettivo chiaro da raggiungere, fare della Camera dei Pari l’opportuno contrappeso alla Camera elettiva visibilmente ostile all’Imperatore, in un contesto che la riflessione conclusiva di Hobhouse, allorché allude alla preponderanza della componente militare e allo scontento degli esclusi, riassume con sbrigativa crudezza: “Una gran parte della attuale Camera dei Pari può perire assai presto sul campo di battaglia, e ci sarà bisogno di completarla”6.
Gli abiti scuri di seta nera, con i quali è vestita la maggior parte dei membri delle due Camere (fa eccezione solo qualche isolata uniforme militare) che si riuniscono il giorno successivo, la prima – quella dei Pari – al Palazzo del Lussemburgo, la seconda – quella dei rappresentanti – nel vecchio palazzo del Corpo Legislativo, non promettono, tuttavia, niente di buono. Scelti ostentatamente per differenziarsi dalla livrea punteggiata di fiordalisi, obbligata tenuta dei loro predecessori nella Camera borbonica, quegli abiti proclamano un’indipendenza rispetto al sovrano che non si rivolge certo all’ormai esule Luigi XVIII. Le prime battute della seduta dell’Assemblea elettiva confermano uno stato d’animo che nelle ore e nei giorni successivi non farà che crescere, così tra i deputati come nella stampa parigina.
Era stata quest’ultima, del resto, che nei giorni precedenti (sotto l’abile regia di Fouché) aveva stroncato la candidatura di Luciano Bonaparte alla presidenza della Camera. Se è difficile dire quanto Napoleone avesse realmente sostenuto la scelta oggettivamente imbarazzante di un fratello con il quale aveva, dai tempi di Brumaio, mantenuto rapporti difficili e in alcuni momenti tempestosi, non c’è dubbio che la soluzione che si determina nel voto del 3 giugno gli è particolarmente sgradita. L’elezione di Jean-Denis Lanjuinais, repubblicano, liberale, oppositore del Napoleone imperiale così come lo era stato del Robespierre montagnardo, uomo che nel marzo del 1814 aveva votato la decadenza di Napoleone, fu un segnale inequivocabile. Per qualche ora sembrò perfino possibile che l’Imperatore rifiutasse di approvare quella designazione come un articolo dell’Atto addizionale gli avrebbe consentito. Un incontro tra i due, che ci viene raccontato secondo l’immancabile schema dell’immaginario napoleonico – “È vero che mi odiate?”, gli avrebbe chiesto sbrigativamente Napoleone, ricevendone un altrettanto sbrigativo “No” – e che si conclude con un non meno immancabile abbraccio, mette fine, in serata, alla disputa7.
Siamo, però, solo alle prime schermaglie della battaglia tra un’Assemblea che non perde occasione di rivendicare la propria indipendenza nei confronti di un sovrano che, a sua volta, immagina che la costituzionalizzazione del proprio potere non dovrà mai spingersi fino al punto di metterlo ai margini dell’equilibrio tra le istituzioni, fino a diventare – come dice a voce alta al fedelissimo Fleury de Chaboulon – “un nuovo Luigi XVI”8.
È una battaglia che persino Napoleone è obbligato a giocare a colpi di fioretto, ben consapevole che il difficilissimo contesto nel quale, appunto, egli agisce – tra pochi giorni, la guerra – non gli permette di provocare una crisi istituzionale. Nel suo discorso di apertura delle Camere, il 7 giugno, i termini non potrebbero, quindi, essere scelti con maggiore attenzione. Il ricordo, che è nelle battute d’avvio, al “potere illimitato” di cui è stato investito negli ultimi tre mesi dalle circostanze e dalla fiducia del popolo, è immediatamente corretto da una frase che tempera, senza tuttavia mascherare, l’esordio così esplicito nel rivendicare la natura personale ed emergenziale della sua autorità: “Oggi – annuncia quasi di slancio l’Imperatore – si compie il desiderio più vivo nel mio cuore: ho dato inizio alla monarchia costituzionale”.
Cominciata così, con queste note almeno all’apparenza ben assortite, la musica della retorica napoleonica procede poi per studiati contrappunti. L’ambizione a vedere la Francia godere di “tutte le libertà possibili” precede di qualche istante il richiamo alla “formidabile coalizione di sovrani” che minaccia l’indipendenza della patria e agli eserciti che sono già schierati sulle frontiere francesi. All’elogio della libertà della stampa, “elemento costitutivo della costituzione attuale” segue l’annuncio di misure limitative rese necessarie per evitare “nello stato attuale della nazione” ogni pericolosa “divisione intestina”. La promessa carica di solennità con la quale il discorso si conclude – “L’esercito e io faremo il nostro dovere” – sembra anche alludere alla opportunità che le Assemblee rappresentative facciano altrettanto: un invito, un’esortazione, che posti in questi termini esprimono anche un dubbio9.
Non possediamo – ovviamente – il suono della voce con cui venne pronunciato il discorso e, soprattutto, la sua conclusione. Qualcuno tra i presenti ci assicura, nelle sue memorie, che la voce non ebbe nulla di minaccioso, al contrario fu ben distinta e chiara, solo “un po’ debole verso la fine del discorso”10. Sempre tra i presenti, tuttavia, non manca chi ricorda i tratti appesantiti, affaticati, i muscoli del volto visibilmente tirati. Nel corso di tutta la cerimonia Napoleone scambia solo qualche parola con chi gli sta accanto, prende continuamente, da una scatolina che ha tra le mani, delle pastiglie; “doveva – aggiunge chi narra – soffrire di petto, era sicuramente malato”11. Se non indisposto, Napoleone non si sente di certo a proprio agio. Come nella giornata del Campo di Maggio, il suo vestito appare inappropriato, come quelli – ancora in satin bianco – indossati dagli uomini che gli sono più vicini. Al ...