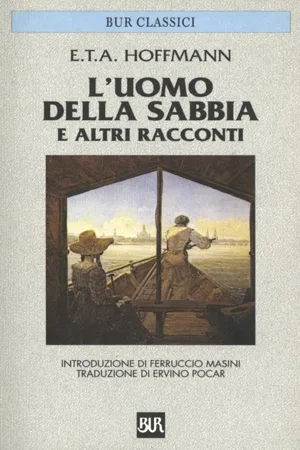
- 208 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
L'uomo della sabbia e altri racconti
Informazioni su questo libro
Come scriveva il poeta Alfred Klabund, non conviene leggere questi racconti prima di andare a dormire, perché si rischia di passare una notte insonne e di sentire fantasmi e demoni 'premere come incubi sulla coperta e sui guanciali finché i primi bagliori dell'alba non vengano a metterli in fuga'. La potenza di Hoffmann sta nel saper penetrare il reale e scoprire cosi quell'abisso abitato da demoni e spettri che non e diverso dal mondo in cui gli uomini trattano i loro affari, ma che ad esso si mescola e si sovrappone. In questo volume sono riuniti i racconti che hanno ispirato la musica di Offenbach, insieme ad alcuni capolavori della letteratura fantastica e 'demoniaca'.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a L'uomo della sabbia e altri racconti di E.T.A. Hoffman in formato PDF e/o ePub. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Print ISBN
9788817124072eBook ISBN
9788858631904Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
L’uomo della sabbia
e altri racconti
introduzione di FERRUCCIO MASINI
traduzione di ERVINO POCAR
traduzione di ERVINO POCAR
Biblioteca Universale Rizzoli
Proprietà letteraria riservata
© 1950, 1983 RCS Rizzoli Libri S.p.A., Milano
© R.C.S. Libri & Grandi Opere S.p.A., Milano
© 2006 RCS LIBRI S.p.A., Milano
ISBN 978-88-58-63190-4
Prima edizione digitale 2013 da quarta edizione febbraio 2003
In copertina: Carl Gustav Carus, passeggiata in barca (1827)
Per conoscere il mondo BUR visita il sito www.bur.eu
Quest’opera è protetta dalla Legge sul diritto d’autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.
NOTA BIOBIBLIOGRAFICA
1776-1792 Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann, che in omaggio a Mozart muterà il terzo nome in Amadeus, nasce il 24 gennaio 1776 a Königsberg. In seguito alla separazione dei genitori, il giurista Christoph Ludwig Hoffmann e Luise Albertine Doerffer, viene affidato alla madre e cresce presso la famiglia di lei, nella casa dei Doerffer. Frequenta la scuola riformata di Königsberg. Compagno di quegli anni è già Theodor Gottlieb Hippel, che gli resterà amico inseparabile per tutta la vita. Riceve lezioni di musica e pittura.
1792-1795 Frequenta la facoltà giuridica dell’università di Königsberg, ma contemporaneamente studia composizione musicale, violino e pianoforte. Diciottenne, impartisce egli stesso lezioni di musica. Amore appassionato per Dora («Cora») Hatt, sua allieva, infelicemente sposata ad un commerciante di vini di Königsberg. Fra le letture di quegli anni: il Werther, il Geisterseher di Schiller, Rousseau, e poi Sterne, Smollett, Swift, Lichtenberg, Jean Paul, Rabener.
1795 Intraprende la carriera di magistrato a Königsberg.
1796-1798 Morte della madre il 13 marzo 1796. La relazione di Hoffmann con Cora Hatt nuoce all’onorabilità borghese della famiglia Doerffer così che lo zio, Johann Ludwig Doerffer, consigliere al tribunale di Glogau, ottiene il trasferimento del nipote in quella città della Slesia. Qui conosce il pittore Molinari, il musicista Hampe, lo scrittore Julius von Voss. Lettura dell’opera di Shakespeare nella traduzione di A.W. Schlegel. Fidanzamento con la cugina Minna Doerffer. Viaggio a Dresda e prima visita alla pinacoteca.
1798-1800 Trasferimento a Berlino. Partecipa alla vita culturale e di società. Prende lezioni di musica dal compositore J.F. Reichhardt. Rapporti di amicizia con il chitarrista e poi scrittore di teatro Franz von Holbein. Il 27 marzo 1800 è nominato assessore al tribunale di Posen.
1800-1802 A Posen, divide il proprio tempo tra l’impegno professionale, l’attività musicale, gli amori e la vita spensierata di un gruppo di giovani magistrati. Nel conflitto fra autorità civili e militari del luogo Hoffmann si schiera a fianco della cittadinanza, contro quest’ultime. Riconosciuto come l’autore di alcune caricature, con cui venivano sbeffeggiati gli ufficiali della guarnigione di Posen, viene trasferito nella cittadina polacca di Plock. Scioglie il fidanzamento con la cugina Minna e sposa la giovane polacca di religione cattolica, Michalina Rohrer Trzynska (« Mischa »).
1802-1804 In « esilio » a Plock, attraversa un periodo di coscienziosa e quieta dedizione al lavoro. Nel tempo libero continua l’attività artistica.
1804 Trasferimento a Varsavia per i buoni uffici dell’amico Hippel. Amicizia con Julius Eduard Hitzig, assessore presso il tribunale di quella città, che gli fa conoscere le opere della poesia romantica. Legge i fratelli Schlegel, Tieck, Novalis, Brentano, e poi Calderón nella traduzione di A.W. Schlegel. Conosce il musicista Morgenroth e Zacharias Werner. Prosegue la sua formazione di musicista.
1805 Nasce la figlioletta Caecilia. Hoffmann ha parte rilevante nella fondazione della Musikalische Gesellschaft di Varsavia nella quale si esibirà come direttore d’orchestra.
1806 Il 28 novembre Varsavia è invasa dai Francesi. Rifiuta il giuramento di fedeltà agli invasori ed è privato dell’impiego.
1807 È colpito da una violenta febbre nervosa. Parte per Berlino alla ricerca di un nuovo lavoro. Falliscono le trattative per la pubblicazione delle sue opere musicali. Vani tentativi di ottenere un impiego come correttore presso una casa editrice musicale. Morte della figlioletta Caecilia. Nei Salons berlinesi conosce, fra gli altri, Varnhagen von Ense, Chamisso, Fichte, Schleiermacher. Primi contatti epistolari con Rochlitz, editore della Allgemeine Musikalische Zeitung di Lipsia.
1808 È direttore d’orchestra presso il teatro di Bamberga. Dopo il fallimento di quell’esperienza scrive recensioni musicali e successivamente si occupa di scenografia e regia teatrale.
1809 La Allgemeine Musikalische Zeitung pubblica la sua prima novella, Il cavaliere Gluck (Ritter Gluck).
1810 Dà lezioni di musica a Julia Marc, con la quale vivrà un amore tempestoso sino al forzato matrimonio di lei con un commerciante (3 dicembre 1812).
1811 Incontra Jean Paul a Bayreuth. Al teatro di Bamberga allestisce, con successo, alcuni drammi di Calderón e Shakespeare e la Kätchen von Heilbronn di Kleist. Frequenta il libraio Kunz e i medici Marcus e Speyer, dai quali apprende le teorie sul magnetismo e mesmerismo.
1812 Viaggio a Norimberga. Si dimette dal teatro di Bamberga nella speranza di guadagnarsi da vivere con lezioni di musica e recensioni.
1813-1814 Dall’aprile 1813 è a Dresda e Lipsia dove è impegnato come direttore d’orchestra nella compagnia teatrale di Joseph Seconda. Intensa attività letteraria. Contratto editoriale con Kunz per la pubblicazione dei Pezzi fantastici alla maniera di Callot (Phantasiestücke auf Callots Manier). Studi approfonditi nella pinacoteca di Dresda. È testimone diretto delle campagne napoleoniche di quegli anni. In seguito ai dissapori con Seconda, il 26 febbraio 1814, Hoffmann è licenziato.
1814 Grazie all’intervento dell’amico Hippel, divenuto nel frattempo consigliere di stato, ottiene il reinserimento nella magistratura. Nel settembre di quello stesso anno fa ritorno a Berlino. Negli ultimi anni di vita è preminente l’attività letteraria. Stringe amicizia con l’attore Ludwig Devrient. Frequenta Fouqué, Chamisso e inoltre l’amico Hitzig, il medico e poeta Johann Ferdinand Koreff, il poeta Salice-Contessa, con i quali si incontra per le discussioni e le riunioni serali, i Seraphinenabende (poi Serapionsabende), che avranno luogo a partire dal 1816. Contatti occasionali con Armin, Brentano, Eichendorff, Tieck, Hegel, Schleiermacher, il filologo Bernhardi, lo scienziato naturalista Lichtenstein e molti altri rappresentanti della vita artistica e culturale dell’epoca.
1814-1815 Pubblicazione dei Pezzi fantastici alla maniera di Callot.
1816 Rappresentazione dell’opera Undine al Königliches Schauspielhaus di Berlino, con scenari disegnati da Schinkel. Escono Gli elisir del diavolo (Die Elixiere des Teufels) e L’uomo della sabbia (Der Sandmann), pubblicato nella prima parte dei Racconti notturni (Nachtstücke).
1817 Racconti notturni, seconda parte.
1819 Si ammala gravemente. Con la moglie compie un viaggio di cura in Slesia. Nell’attività di magistrato dimostra fermezza e dignità nei confronti del regime restauratore prussiano. Contrasto con il capo della polizia Kaptz, cui si riferirà l’episodio di Knarrpanti in Mastro Pulce. Pubblicazione delle Singolari pene di un direttore di teatro (Seltsame Leiden eines Theaterdirektors) e del Piccolo Zaches detto Cinabro (Klein Zaches genannt Zinnober). Appaiono i primi due volumi della raccolta di racconti e fiabe, I fratelli di Serapione (Die Serapionsbrüder).
1820-1821 I fratelli di Serapione, terzo e quarto volume. Considerazioni del gatto Murr sulla vita e biografia frammentaria del direttore d’orchestra Kreisler su fogli di minuta casualmente inseriti (Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern). La principessa Brambilla (Prinzessin Brambilla). Per il fermo atteggiamento nei confronti del regime prussiano Hoffmann è considerato un esponente di rilievo dell’opposizione borghese-liberale. Il suo Mastro Pulce (Meister Floh), scritto nel ’21, verrà pubblicato nel ’22 in edizione censurata.
1822 Pubblica gli ultimi racconti, fra cui La finestra d’angolo del cugino (Des Vetters Eckfenster) e La guarigione (Die Genesung). Muore per tabe dorsale il 25 giugno.
(a cura di Fernanda Rosso Chioso)
«L’UOMO DELLA SABBIA » OVVERO LA PREVARICAZIONE DELLO SGUARDO
Nel contesto storico-culturale della Germania all’indomani delle guerre di liberazione e del Congresso di Vienna (1814-1815), e quindi nel clima di restaurazione dinastico-assolutista, l’opera di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann (qualcuno ha fatto risalire al 1814, con i Phantasiestücke, il suo ingresso ufficiale nella letteratura) rappresenta un punto di trapasso e di crisi profonda, nel quale la concentrazione del romantico sentimento della vita sembra paradossalmente dissolversi nel suo opposto. La saturazione degli ideali romantici, in questo lento ma inesorabile declino meridiano della loro grande stagione — un declino dai toni ora realistico-piccolo-borghesi, ora lirico-fiabeschi (basti pensare a un Chamisso, a un La Motte-Fouqué e, infine, a un Eichendorff) — diventa una saturazione micidiale proprio nel « demoniaco » Hoffmann. In lui l’alchimia romantica si svela come fabbrica delle aberrazioni dell’immaginario e lo smarrimento prenderà trionfalmente il posto di quell’eterno «struggersi» dell’anima, esiliata dalla sua vera patria, che i romantici chiamavano Sehnsucht.
Lo stesso « volto notturno » di un microcosmo interiore alterato da oscillazioni repentine quanto rovinose non ha, nelle sue stesse inquietudini metafisiche, la coloritura stravagante ed eccentrica che troviamo, per esempio, nelle nichilistiche Veglie di Bonaventura, bensì lascia affiorare la cupa incandescenza di uno sguardo che non si distacca dal reale, ma lo attraversa. Si stringono così quelle complicità con l’abisso che nessun esorcismo poetico-intellettuale riuscirà mai ad estinguere.
C’è un’infrarealtà abitata dai demoni che, a ben vedere, non è diversa da quella realtà dove i borghesi trattano pacificamente i loro affari, stipulano contratti e contraggono matrimoni. È facile comprendere che l’anima del Kammergerichtsrat Hoffmann non può convivere con quella del direttore d’orchestra o dello scrittore visionario senza incrinare il dogma dell’armonia sociale vagheggiata dalla cultura grande-borghese di un Wilhelm von Humboldt e di un Goethe e senza far cadere sull’attivismo delle nuove classi politiche e sui miraggi di perfettibilità umana, sollecitati dal progresso industriale, un’ombra sinistra. Forse proprio per questo l’autore degli Elisir del diavolo non poteva trovare che diffidenza o scetticismo nella società letteraria del suo tempo e dovranno passare molti anni, almeno sino al 1840, perché si cominciasse a comprendere il peso di quelle « dissonanze » che Hegel giudicava semplicemente ripugnanti.
Nelle pagine di quel piccolo capolavoro che è Der Sandmann (L’uomo della sabbia), scritto tra il 16 e il 24 novembre del 1815, il mondo narrativo di Hoffmann si rivela in quella che ne costituisce una connotazione poetico-realistica costante. È un mondo del fra, un mondo intermedio, oscillante tra la dimensione falsamente rassicurante del quotidiano e gli stati visionari o translucidi destinati ad aprire, dietro quel quotidiano, uno sfondo insospettabile che ne sconvolge i segni e gli effimeri equilibri. Per afferrare l’enigma di quest’altra logica allucinata, occorre avere una sorta di «sesto senso » e non atteggiarsi come il conte Nepomuk e il principe Boleslao, che nel Voto scrollano scetticamente il capo, anzi prorompono in una sonora risata quando la principessa rimprovera loro questa fredda insensibilità. «C’è ancora — ella dice — tanto mistero al mondo che non siamo assolutamente all’altezza di comprendere. »
Anche nel Sandmann è possibile intravedere una voragine e, al tempo stesso, il suo opposto: la cima di una beatitudine inconcepibile, lungamente desiderata, che ci strappa via dall’equilibrio del buon senso e dal conforto delle certezze, dalle care consuetudini e dalla stabilità degli affetti. Si direbbe che mundus mirabilis, la hoffmanniana isola della musica, e mundus subterraneus, per quanto da versanti opposti, esercitano una identica magia, tanto che i contorni dell’uno sembrano confondersi con quelli dell’altro. Nel fondo del primo sembra spalancarsi all’improvviso il secondo, come per un gioco di specchi stregati che rimandano, alla fine, l’immagine medusea della follia. Lo specchio — allo stesso modo delle lenti ottiche, del cannocchiale di Coppola — costituisce un tema simbolico ricorrente nell’opera hoffmanniana (si pensi alla Storia dell’immagine perduta nelle Avventure della notte di San Silvestro). Il personaggio che guarda il reale attraverso uno specchio, lo riflette in una sorta di miroir magique nel quale l’ordine intellegibile delle cose si decompone, si sfalda, si trasfigura. Il fantoccio meccanico di Spallanzani diventa così l’apparizione infinitamente tentatrice del lungamente desiderato. Nel cuore stesso della quotidianità si apre l’abisso e insieme la beatitudine di un mondo immaginario le cui forze di gravità risultano distruttive proprio perché è distruttivo l’Io che si sente irretito in esse e con esse inesplicabilmente e ciecamente solidale.
L’uomo romantico ha «un’orribile confidenza e un confidente orrore per l’infinito» — osservava acutamente L. Mittner, ma Hoffmann è già un «romantico » al di là di se stesso, l’uomo di un’età di transizione che ha avvicinato smisuratamente a sé l’infinito e ne ha, per così dire, varcato la soglia. Si è accorto così che quell’infinito altro non è se non il fondo di una realtà alla quale è venuta meno la superficie che costituiva la sua protezione e la sua salvezza. Quell’infinito, ormai troppo paurosamente vicino, ha spezzato le formule di ogni esorcismo e ha ecceduto il gioco stesso dell’immaginazione. Per questo si è da sempre prigionieri di un cerchio infernale, perché si è varcata la soglia che ci avvicinava, ma anche ci invitava a restare al di qua, ci proteggeva dall’infinito. È questo il destino di Peter Schlehmil nelle Avventure della notte di San Silvestro, il quale, non diversamente dal Nataniele del Sandmann, è un «posseduto» dalla virtualità metafisica dell’immaginario e non sa districarsene. Erasmo Spikher, che per amore dona alla sua Giulietta la propria immagine dello specchio, è, al pari di Nataniele, consegnato all’ingannevole seduzione di una felicità sconfinata o meglio alla possibilità di un’esistenza sovrumana a cui sia concessa quella beatitudine perduta e irrevocabile, goduta forse nell’intimità prenatale del figlio con la madre. Giulietta ed Olimpia sono i fantasmi di questa seduzione; in loro sembra rendersi visibile, quasi per prodigio, una sorta di attingimento ultimo. La genesi della follia sta qui: essa è solo un’altra parola per indicare una metamorfosi infernale che si costruisce pezzo su pezzo, insensibilmente, all’interno della realtà dell’Io, nelle pieghe di una memoria dove si occultano oscuri avvertimenti premonitori (l’esperienza infantile di Nataniele). Anche Nataniele, come Erasmo Spikher, come lo stesso don Juan nel racconto Favolosa avventura di un viaggiatore entusiastico, aspira a potenziare la propria esistenza fino a toccare un cerchio assoluto di possibilità, esige l’appagamento definitivo, i ritmi di una vita ascendente che lo sommerga in un « tormento celeste ». L’amore è il laccio magico con cui li cattura la fascinatio del desiderio: esso è una frode operata dal maligno a danno di chi, come don Juan, riteneva che « attraverso il godimento della donna già qui sulla terra potesse realizzarsi ciò che solo come celeste promessa abita nel nostro cuore ». Quel laccio magico gli viene gettato dall’Avversario, perché la seduzione del male e della catastrofe si annida nella stessa nostra aspirazione alle «cose supreme », là dove l’uomo esprime la sua « divina natura ».
Ma proprio chi è vittima di una siffatta seduzione è un eletto. Alla «gente fredda e prosaica » non è concesso quello che per Nataniele costituisce la destinazione superiore della sua vita. Dirà apertamente allo amico Sigismondo: «Soltanto alle anime poetiche si dischiude l’anima gemella », volendo significare, con queste parole, che solo un «poetico sentire » può dialogare con un altro e che in ciò sta il compimento di un’altrimenti impossibile comunicazione. Olimpia è infatti, per lui, quella voce segreta a cui non sono necessarie parole: la voce che parla a Nataniele dal suo stesso intimo: «gli pareva [...] che Olimpia avesse parlato dal profondo del cuore di lui su quelle opere, sulle sue doti poetiche, anzi che la sua voce stessa fosse uscita dal proprio cuore ». A questo punto, poco davvero importa che Olimpia resti sempre muta o quasi. «Che cosa sono le parole? Parole? Lo sguardo del suo occhio divino dice più che qualsiasi linguaggio. Può forse una creatura celeste costringersi nella cerchia ristretta che i miseri bisogni umani hanno tracciato? »
Che significa innamorarsi di una «pupattola di legno »? Holzpüppchen —come Nataniele chiamerà Olimpia, nel momento in cui viene assalito dal delirio dopo aver assistito, impotente, allo scempio dell’essere amato. Che significa innamorarsi di un’immagine? Poiché non c’è dubbio che tra la pupattola di legno inanimata e fatta a brandelli da Spallanzani e Coppelius nella loro rissa furibonda e Olimpia, quest’immagine suprema della bellezza e del desiderio, corre una differenza. Quella stessa che divide, per Hoffmann, la Realittät (realitas) dalla Wirklichkeit (realtà che si costituisce come risultato di un agire, di un produrre, di un wirken). La Realität è una realtà inerte, già data, immodificabile, subita. La Wirklichkeit è quella realtà che noi stessi siamo, identificata nel nostro agire e quindi nella libertà dell’Io, una realtà plasmata perché ha in noi le sue radici. Olimpia, come immagine, è una realtà offerta e creata dall’occhio, è il pro dotto di un’eccessiva attenzione dello sguardo. Il piccolo cannocchiale tascabile con cui Nataniele guarda per la prima volta Olimpia nell’intimità della sua camera è la materializzazione magica di questa attenzione. « Non gli era mai capitato di avere un cannocchiale che avvicinasse gli oggetti con tanta chiarezza e precisione. Involontariamente guardò nella stanza di Spallanzani: come al solito Olimpia era seduta davanti al tavolino sul quale appoggiava le braccia e le mani giunte. Soltanto ora Nataniele vide il viso meraviglioso di Olimpia. Solamente gli occhi gli parvero stranamente fissi e morti. Ma aguzzando lo sguardo attraverso il cannocchiale gli parve che quegli occhi si illuminassero di umidi raggi di luna. Pareva che solo in quel momento vi si accendesse la forza visiva; e gli sguardi fiammeggiavano sempre più vivi. »
La dimensione infernale dell’ambigous risulta perfettamente centrata nella mobilità realistico-fantastica e forse proprio in virtù dei piani insensibilmente sfuggenti di una quotidianità oscuramente insondabile. Il fanciullo Nataniele, quasi ipnotizzato da Coppelius, al punto da nascondersi dietro la tenda per osservarne le operazioni diaboliche, è attratto dall’orrore, vorrebbe fuggirlo e tuttavia si abbandona ad esso. La trappola sta nel pervertirsi del sentimento e per questo è possibile al giovane Nataniele stabilire un rapporto con l’automa. Le figure dei morti-viventi che come nell’altro racconto hoffmanniano, Die Automate , si stringono agli esseri umani nella danza, sono già dentro di noi. Per questo il sortilegio di Olimpia...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio