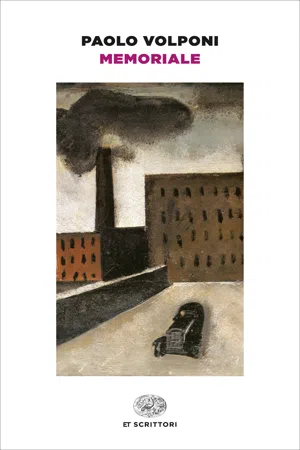![]()
Paolo Volponi
Memoriale
![]()
I miei mali sono cominciati tutti alcuni mesi dopo il mio ritorno dalla prigionia in Germania, quasi che la terra materna, dopo tanto e cosí crudele distacco, mi rigettasse. Io sono nato il 12 marzo 1919 ad Avignone, in Francia; ma sono italiano e di genitori italiani, padre piemontese e madre veneta, nata nella campagna fra Padova e Treviso, in luoghi assai belli, ella mi ha sempre detto, che io non conosco. Oggi che scrivo ho già compiuto trentasei anni e i miei mali sono arrivati a un punto tale che non posso fare a meno di denunciarli. Scrivo, stando a casa mia, a Candia, nel Canavese, in provincia di Torino. Questa casa è fuori del paese, verso il piccolo lago di Candia; ma un poco spostata a sinistra, tra paese e lago, verso la collina; è una casa di campagna con un poco di orto, la sua loggia di mattoni rossi, il fienile e la stalla abbandonati, dove vivono in disordine alcune galline, due galli e una famiglia di conigli, quasi selvatici. Io non curo la terra né gli animali da cortile, perché sono un operaio di una fabbrica in città; di una fabbrica grande piú della stessa città.
I miei mali sono cominciati alla fine del 1945, poco prima di Natale, negli ultimi giorni di dicembre, i primi nevosi di quell’anno. Aspettavo la neve e Natale per sentirmi con piú agio finalmente a casa mia; per sentirmi confortato dalla nascita del bambino Gesú e di nuovo accolto nella famiglia cristiana, avuti i sacramenti e cominciato l’inverno in pace, con qualche soldo del Distretto militare, qualche provvista in casa e la speranza di tutto l’avvenire. Era un tempo in cui avevo molta speranza. Pensavo anche che la neve, bella e pura sui boschetti intorno al lago e bianca anche intorno a casa mia, mi avrebbe dato serenità, cancellando dalla mia terra ogni cattivo ricordo.
La sera in cui nevicò stavo proprio rientrando a casa e non volli ripararmi, né volli togliere la neve davanti alla porta; mi scrollai soltanto il cappotto ed, entrato, aprii le imposte della mia finestra, lasciando chiusi i vetri, per dormire nel chiarore. Dormii bene e, proprio come volevo, mi svegliai presto ma a giorno fatto. La notte era trascorsa come nei campi di concentramento e come in Francia, nella mia infanzia, in un grande silenzio; in un silenzio che però era soltanto per me e che finiva appena fuori del mio sonno, come io avvertivo, nel mormorio dei compagni o dei genitori o della strada; un mormorio bianco perché anche da bambino tenevo le imposte aperte, non tanto per paura quanto per non isolarmi del tutto e avere argini al sonno, quasi uno spazio dove rigirarmi e tentare qualcosa con una mano.
Non avrei mai creduto, vedendola, che quella fosse la mattina dei miei dolori; la prima mattina del mio travaglio. Non era caduta molta neve ma mi bastava, anche se non mi commuoveva come avevo pensato. La neve stava sui boschetti e quasi entrava nell’acqua del lago, che era ferma; ma toccava appena la mia casa e la piccola salita. Salutai mia madre e le accostai la sedia con i suoi panni; presi una sciarpa dal cassettone e scesi a lavarmi, dal rubinetto in cucina. La mia è una delle poche case in campagna con l’impianto dell’acqua. Lo fece fare mio padre tornato dalla Francia, e in parte lo sistemò con le sue mani di bravo muratore. L’acqua, come tutte le acque quando fuori è nevicato, era meno fredda del solito ed aveva un sapore di radice. Questo sapore da principio m’ingannò; credetti cioè che fosse un sapore dell’acqua anche quello che invece era della mia bocca e che sentii poi meglio crescere a poco a poco nella sua dolce consistenza. Quando mi rialzai dall’acquaio per asciugarmi sentii un dolore al petto, come una piega difficile da distendere, ed anche una forte infiammazione alla gola ed allo stomaco. Non feci grande caso a questi sintomi e li misi in conto alla prigionia; in buon conto alla prigionia, madre di tante disgrazie, e in nessun conto alla mia vita futura, che invece sarebbe dovuta diventare, per colpa di questi mali e di altri e delle insidie di uomini malvagi, un’altra prigionia o agonia.
Non mi ricordo bene come passai le giornate successive dopo il tradimento della neve e i primi dolori; soprattutto da solo o con mia madre e a casa mia, dove riverniciai le porte e le finestre. Mia madre parlava poco, e insisteva solo a dirmi di non prendere moglie, cosa della quale non avevo alcuna voglia, perché ero solo e incerto e la mia vita ancora avrebbe dovuto sistemarsi. Leggevo molti giornali, pieni allora di fatti di sangue, di rivolte e di lotte politiche. Io ho sempre votato per la Democrazia cristiana, per rispetto della Chiesa, che non mi aveva mai abbandonato nemmeno in prigionia, e per venerare la croce di luce che splende la notte sulla chiesa di Candia e che mi ha sempre tenuto compagnia, anche ora quando non dormo. Non credevo agli uomini della mia condizione, o ancora peggiore, che si davano le arie negli altri partiti. Pensavo che l’uomo dovesse acquistare autorità, migliorando serenamente e cancellando i propri mali contro l’avversità dei maligni con le buone ragioni e la virtú; altrimenti i paesi si riducono come la Germania, che ci tenne prigionieri uccidendoci a milioni, o come la Russia che aveva i soldati piú ignoranti e le terre senza strade. I miei mali fisici andavano e venivano sovente o a distanza di tempo, proprio come un cambiare e rimettersi del tempo che dobbiamo subire e che non possiamo modificare. Ogni tanto mi davano pensiero, anche perché il mangiare che mia madre mi preparava mi piaceva sempre meno e non piú come una volta che i suoi pranzi erano la mia festa, in Francia e in Italia. Ma mia madre mangiava volentieri ed io la guardavo e la seguivo; anche se ero disturbato dalla sua voracità. Avevo detto a mia madre dei miei dolori e lei mi aveva detto di pregare e di andare dal medico, o di dormire dopo mangiato e di trovare un lavoro.
Dal medico ero stato al Distretto militare come tutti i reduci. Eravamo tutti in fila come sempre sotto l’esercito; ma senza ridere e scherzare e molto in fretta, con alcuni ex prigionieri assai malati ed altri assai fiacchi di spirito, che guardavano male ciascuno ed ogni cosa. Per principio, nella fila, non feci passare nessuno di questi davanti a me, anche perché dovevo tornare a Candia prima di sera. Il medico militare, al mio turno, mi bussò la schiena e le spalle e mi toccò il ventre. Allora io gli denunciai con chiarezza i miei mali, uno per uno con grande precisione, citando l’ora e la data, tutte le date, del loro manifestarsi dalla prima volta. Il capitano medico mi guardò con interesse e stupore, facendo un passo indietro, come per vedermi meglio in tutta la persona, e prima di parlare lasciò cadere piano piano il braccio con il quale mi aveva bussato, fino alla posizione di riposo. Io guardai il movimento di quel braccio bianco e militare come se stesse compiendo un’operazione magica su di me, mentre aspettavo le parole dalla bocca del medico. Le parole vennero frettolose e dettate da quel risentimento e disprezzo che ha sempre un medico militare nei confronti di un soldato malato. Il discorso fu che io mangiavo troppo, dopo i digiuni della prigionia, e che il mio stomaco, non essendo piú allenato, soffriva per digerire, dilatandosi e contraendosi fuori del normale. L’infiammazione alla gola era poi dovuta, secondo il medico militare, all’incontinenza nel fumare. Io non dissi al medico che non fumavo e che non avevo mai fumato in vita mia, nemmeno da soldato, giacché sapevo bene che quella visita, né per me né per lui, aveva lo scopo di accertare lo stato della mia salute; che la visita era soltanto un obbligo militare per entrambi. Io avevo denunciato i miei mali perché ero abituato a farlo mentalmente; perché il farlo costituiva ormai un fatto quotidiano o almeno frequente della mia vita; un’operazione che mi consentiva, allora, di sollevare i miei mali un momento dal mio corpo e dalla mia anima e di vederli distinti, lontani, come sopra un davanzale dal quale fosse poi possibile farli sparire o magari riprenderli, secondo la mia volontà.
Mi ricordo che rivestendomi ero contento che quel medico militare non li avesse scoperti; ma insieme avevo il timore che fossero improvvisamente scomparsi. I miei mali avrebbero dovuto essere riconosciuti e combattuti in altra sede e dopo che io stesso fossi stato ben sicuro di loro, di tutta la loro quantità, frequenza e qualità, in modo che, vincendoli, avrei potuto vincerli sino in fondo, sino a restituire al mio corpo una perfetta integrità.
Uscendo dal Distretto stavo bene e potevo andare in gran fretta per lasciare Torino, correndo alla stazione di Porta Nuova a prendere il treno per Candia. Mi toccava infatti prendere il treno, assai piú scomodo e lento dell’autobus, perché il Distretto riconosceva gratuito il viaggio di andata e ritorno soltanto in ferrovia. Il treno partiva verso sera ed era un treno operaio che fermava a tutte le stazioni. Era affollato come una tradotta militare, soprattutto da operai che lasciavano le fabbriche di Torino. Molti di quegli operai avevano l’aria di star bene, con le loro berrette, il giornale sottobraccio, il cestino o la borsa delle vivande, i loro discorsi ad alta voce; altri pareva sentissero freddo, in aprile e in mezzo a quella calca, mortificati per di piú dalla sporcizia dei loro indumenti. Alle stazioni scendevano a gruppi, ridendo e insultandosi. Mi sembrava che scendessero sempre quelli con l’aria allegra e ben portante e che restassero, per il viaggio piú lungo e per la notte, i piú tristi e sporchi. Non avevo cercato di sedermi, sbalordito dal chiasso e dalla frenesia dell’ambiente; ma quando si accese nello scompartimento la luce vidi alcuni posti liberi e mi accomodai. Sedetti vicino a un operaio che aveva un bel volto, con un naso affilato e ben fatto, acuto ed equilibrato come fosse il primo dei suoi strumenti di precisione. Egli mi disse che lavorava da diciassette anni alla Fiat, come aggiustatore alla «grandi motori». Il lavoro che gli era comandato era interessante e richiedeva impegno da parte sua. Suo padre era ancora un contadino con la terra a sud del fiume, vicino a Chivasso. Secondo lui la vita del contadino era bella ma difficile e ingrata; bella per conto suo ma non in rapporto agli altri, tanto che per questa sua famiglia contadina una ragazza di Torino non aveva voluto sposarlo. Quel giovane simpatico scese in silenzio a Chivasso e con due salti entrò nella stazione. Prima che il treno ripartisse mi sembrò nel buio di vederlo svoltare in bicicletta dietro la casa della stazione, curvo ma sicuro e senza quell’aria eretta e sbadata che hanno i contadini quando vanno in bicicletta e quel senso di grande pena come se sempre pensassero a come fanno le ruote a stare in equilibrio e a camminare sotto i pedali.
Allora accesi la sigaretta che mi aveva offerto a un certo punto del discorso e che io avevo preso per non disturbarlo con un rifiuto. Guardavo la campagna e fumavo; il fumo che usciva dal finestrino, tra la luce del treno e la notte azzurra, diventava una cosa viva, un animale che dovesse nascondersi tra i campi e le fratte. Io non potrei vivere in città, pensavo, dove mi sento solo e dove vedo benissimo che la gente è cattiva, troppo furba e interessata. In città c’è da stare attenti con chi si parla, perché può sempre capitare l’incontro con un ladro, un pazzo, un assassino, una donnaccia o con truffatori e maghi. L’aria stessa della città mi stanca e mi fa sudare, soprattutto la schiena, i piedi e le mani. In città possono vivere le ragazze che hanno da passeggiare e possono lavorare nei negozi, dietro i banchi e le vetrine, meglio che nelle fabbriche o nei campi; e poi, come dicevo, ladri e altri malvagi oltre agli studenti e agli operai condannati; oltre a carceri, ospedali e medici, caserme e carabinieri e molti caffè e cinema per i ladri, le loro donne e i poveri derelitti. Trovare una strada è una fatica e cosí sapere dove andare. Io amo la campagna che dice prima, con strade e viottoli, che cosa si deve fare e che si fa vedere tutta, onestamente. Amo la campagna piú ancora del mio stesso paese; ma non l’amo come un contadino perché il contadino ha, di fronte alla campagna, un formicolare interessato e zappa e taglia ogni giorno come certi animali che rovinano il legno. Se la campagna fosse lasciata rigogliosa e sola oltre ad essere piú bella darebbe anche piú frutti, da raccogliere con giudizio. Non vorrei, io, nemmeno possedere terra perché uno finisce per sentirla propria e vorrebbe poi custodirla e difenderla e tagliarla dal resto del paese e vorrebbe governare i mutamenti del tempo sui suoi alberi e campi e magari scacciare i corvi e gli altri animali. La terra è forte e non può essere dominata da nessuno e ripara da se stessa ai suoi mali. Cosí pensavo nel treno, mentre il viaggio finiva verso gli alberi del lago di Candia ed io fumavo la sigaretta dell’operaio, una delle prime della mia vita.
Sceso dal treno, m’incamminai dritto verso casa; andavo adagio per assaporare la campagna in rispetto dei discorsi e dei pensieri di poco prima. Mi fermai un attimo, colpito dal profumo di un ceppo di rosmarino, cosí buono e sottile da indurmi a guardare in alto il cielo stellato, che nelle sere d’aprile, quando la luna è ancora poca ma in crescenza, è molto luminoso, con strane strade di chiarore, che sono le occhiate che i santi si rivolgono da un capo all’altro del cielo. Ringraziai la divina Provvidenza, contento di essere di nuovo a casa, dopo la città e il viaggio, e soprattutto dopo il pericolo di essere inviato in un ospedale militare. Mi fermai in cucina a mangiare la frittata che mia madre mi aveva lasciato al caldo tra due piatti e a bere un bicchiere di vino, metà prima e metà dopo il pasto. Mentre salivo la scala per le stanze da letto e la soffitta, speravo che mia madre fosse ancora sveglia e mi chiamasse.
Nei giorni seguenti d’aprile e per tutto maggio e i primi di giugno, piovve sempre: poco o molto ma continuamente. Quelle piogge mi davano languore e mi rendevano silenzioso; sempre a casa mia, dove restavo molto volentieri, sotto la loggia o nella stanza da letto. Mi sdraiavo a pensare come sarebbe stata la mia vita quando in buona salute e pieno di tutte le mie forze avessi potuto veramente cominciare a fare qualche cosa. Prima della guerra io avevo frequentato una scuola di avviamento industriale, dai salesiani, senza arrivare al diploma di terza per pochi mesi a causa della morte di mio padre e anche di una pleurite. Sul letto, in quei giorni di pioggia, pensavo a che cosa avrei potuto fare; ma non trovavo nessun mestiere adatto a me, soprattutto alla mia nuova vita. L’acqua scendeva davanti alla finestra ed io la guardavo sferzare il lago con violenza e finivo sempre per distrarmi dai miei pensieri. Il lago cresceva a vista d’occhio, proprio al centro, dove l’acqua s’aggiungeva all’acqua, e poi s’allargava penetrando le rive, sommergendo a poco a poco le melme. Toccavo le mie spalle come da ragazzo durante la malattia e masticavo un sapore di me stesso, un filo della mia gioventú.
In quei giorni arrivò una lettera di mia cugina di Francia, che si era trasferita da Avignone a Parigi. Ci dava sue notizie e quelle dei suoi, spariti o morti durante la guerra, e ci chiedeva se sarebbe potuta, desiderando conoscere l’Italia e noi, unici suoi parenti che appena ricordava dall’infanzia, venire a casa nostra durante l’estate e un poco di settembre. Fui molto contento di quella lettera e in seguito, sedendo, specie le sere piú calde, sulla porta di casa, speravo che dalla strada di Candia arrivasse questa cugina di Francia.
Arrivò anche altra posta; una lettera dell’Associazione Reduci che mi diceva a che punto era la pratica per il riconoscimento della pensione e un’altra, dell’Ufficio di Collocamento, che m’invitava a presentarmi in città per vedere se potevo essere incluso negli elenchi dei reduci da avviare al lavoro nell’industria. Mi dispiacque che l’Associazione Reduci fosse a conoscenza del mio indirizzo, sembrandomi cosí che la prigionia m’avesse seguito dalla Germania per tutto il ritorno e ritrovato nella mia casa. Anche la proposta di pensione mi preoccupava, giacché se mi avessero dato una pensione sarei stato ancora una vittima della prigionia, con il segno di una malattia perenne. L’altra lettera, che veniva da un ufficio nuovo e sconosciuto, non poteva dispiacermi anche se mi metteva ancora con i prigionieri. Riguardava l’avvenire – «avviare a un lavoro nell’industria» – e poteva quindi essere un segno di liberazione e un passo avanti.
Mi presentai il 16 giugno del 1946 all’Ufficio municipale di Collocamento. Da pochi giorni la repubblica aveva vinto e anche se io avevo votato per la monarchia questa vittoria mi aiutava dando a tutte le cose un senso di novità. Gli uffici funzionavano lo stesso, anch’essi per aiutare. All’Ufficio di Collocamento, tutto veniva sistemato di qua o di là, sul tavolo o sul davanzale della finestra, dall’impiegato che si muoveva in fretta, azzeccando sempre la carta giusta, con molto buon umore sparso dappertutto come la cenere delle sue sigarette.
– Saluggia Albino fu Ernesto, da Candia, classe 1919, se vuole può presentarsi all’Ufficio di Collocamento di X, con questo foglio che io dato e timbro, – e fece, servendosi di ambedue le mani, queste operazioni in fretta tanto da non interrompere il discorso, – per essere incluso nella quota reduci del contingente di manodopera da avviare al lavoro nella grande industria di X –. Mi consegnò il piccolo foglio e aggiunse: – Il giorno 22 giugno prossimo e venturo... cioè fra sei giorni... e auguri.
Assentii in silenzio, convinto di tutto...