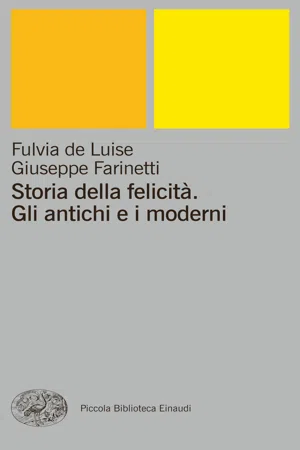![]()
![]()
1. Un preludio tutto italiano.
Quando comincia la modernità? Paradossalmente quando si riapre il confronto faccia a faccia con gli antichi. Quando accettare o respingere il valore di un’eredità culturale diventa occasione per misurarsi e per misurare le distanze. Quando le parole prese a prestito dal passato riacquistano, agli occhi di chi le studia, il significato di un’esperienza umana diversa e complessa, utile per pensare piú lucidamente quella del proprio tempo.
La consapevolezza di vivere un’esperienza di rinnovamento accompagna le scelte culturali di uomini che verranno piú tardi identificati come protagonisti dell’Umanesimo e del Rinascimento (due etichette storiografiche da maneggiare con cura). Il loro punto di vista, prima che la gratitudine dei posteri li investa trasfigurandoli, è quello di una ristrettissima, geniale minoranza, che si trova a disporre di strumenti e circostanze eccezionali per elaborare, nell’arco di poche generazioni, una molteplicità di temi culturali, metodologici, filosofici, scientifici, potenzialmente dirompenti. La società in grado di accoglierli e svilupparli sta nascendo lentamente nelle aree piú urbanizzate d’Europa; gli ambienti colti (accademici e cortesi) d’Italia, a partire dal XIV secolo ne sono i laboratori sperimentali, una coltura in vitro di idee che avranno altrove un grande futuro.
Se al centro dell’interesse sta la concezione dell’uomo, il tema della felicità è il luogo segnaletico di un rinnovamento culturale che segue diverse piste. La piú spregiudicata è quella che passa per Epicuro. Per tutto il medioevo Epicuro era stato un’eredità intoccabile, buona per rappresentare gli estremi di perversione raggiungibili dalla cultura filosofica pagana. Ora intellettuali insospettabili, per raffinatezza e senso morale, rivisitano le sue tesi, sospendendo i pregiudizi consolidati dalla tradizione.
Il cremonese Cosma Raimondi fa una precisa scelta di campo, ponendosi in primo luogo contro la piú dura filosofia della virtú, quella stoica, per valorizzare in Epicuro proprio ciò che aveva costituito motivo di condanna: aver posto «nel piacere il sommo bene». A differenza degli altri, Epicuro aveva capito che la natura dell’uomo è inscindibilmente costituita da anima e corpo e che la sua felicità è quella di un essere intero, non dimezzato, secondo le inumane pretese di rigore degli stoici, o ridotto a desiderare il piacere nella sola forma contemplativa, come propongono i peripatetici. Scrive Raimondi intorno al 1431:
Stando cosí le cose; scorgendosi che la figura e la costituzione dell’uomo è fatta in modo che possa soprattutto ottenere il piacere; essendo noi tratti ad esso per natura; essendo state moltissime e notevolissime cose generate per il piacere; dirigendosi tutte le nostre azioni a questo fine, al vivere cioè senza molestia; tutto essendovi cercato per il godimento; chi ci può essere cosí avverso a Epicuro che, essendo la sua dottrina provata e sostenuta da argomenti cosí veri e stringenti, non aderisca infine alle sue concezioni e non affermi che la piú grande felicità è nel piacere? (Lettera a Ambrogio Tignosi, pp. 147).
Il punto di forza del discorso sta evidentemente nella scelta di un ambito naturale per la ricerca della felicità; il che non ha di per sé nulla di irreligioso o anticristiano, ma certo pone la mortificazione ascetica e monastica del corpo tra le pratiche da ridiscutere seriamente.
Con strumenti teorici piú complessi e raffinati, Lorenzo Valla dà vita nel 1431 a un dialogo sul piacere (De voluptate), che diventerà, attraverso successive rielaborazioni, quasi il manifesto di un nuovo modello di felicità cristiana (De vero falsoque bono). L’eredità di Epicuro è rivisitata alla luce di una concezione della provvidenza divina che assegna alla natura il ruolo cruciale di predisporre secondo ordine, bellezza e utilità quanto è necessario alla vita (Del vero e del falso bene, I, pp. 29-30). Indifferente ai singoli desideri degli uomini e anche ai meriti della virtú, essa agisce indirettamente come guida, attraverso il movente della voluptas, in tutti i percorsi che essi intraprendono alla ricerca della felicità, esaltando la gioia di vivere, istillando criteri di utilità in politica, lasciando che ciascuno scelga e raccolga i frutti delle sue scelte (I, pp. 35-41; II, pp. 159-63).
Il dialogo vede l’affermazione delle ragioni naturali e buone del piacere da parte dell’epicureo (Matteo Vegio), contro il falso rigore degli stoici, che ignorano, o fingono di ignorare, come anche la piú eroica delle virtú tragga alimento dal piacere della gloria, dal desiderio di apparire grandi agli occhi degli altri o di sfuggire a qualche male (II, pp. 86-106).
Assumere il piacere come sommo bene non significa affatto appiattire il senso della vita sui desideri piú immediati, ma avere a disposizione un criterio di valutazione unitario per ogni tipo di scelta, privata o politica, che avrà tanto piú valore quanto maggiore sarà la quantità di piacere e di utilità che procura. Il criterio delimita il campo di ricerca della felicità al «solo bene umano» (II, p. 158), come l’epicureo precisa, attenendosi alla fisica atomistica del maestro, ma non chiude la porta all’ulteriorità della vita per l’anima, come non l’aveva chiusa all’idea di provvidenza. Una possibilità di conciliazione dell’edonismo con la morale cristiana si fa strada nello spazio lasciato aperto dal dubbio sull’immortalità. Sottolineando l’audacia dell’impresa (III, pp. 165-67), Valla dà la parola al sostenitore del punto di vista cristiano (Antonio da Rho), che dovrà sancire la superiorità della virtú epicurea rispetto a quella stoica, nella prospettiva del «vero bene», la beatitudine del paradiso. Tenendo ferma l’assoluta preminenza della speranza cristiana di felicità, sostenuta dalle tre virtú teologali (III, p. 195), gli epicurei risultano comunque piú vicini al significato gioioso del messaggio biblico ed evangelico: «Questa beatitudine chi dubiterebbe di chiamarla, o chi potrebbe chiamarla meglio che piacere? Con questo nome la trovo chiamata anche in Genesi, nell’espressione “paradiso del piacere”, e in Ezechiele, nell’espressione “frutti ed albero del piacere”, e con espressioni simili quando si parla di beni divini. E nei Salmi “li berrai dal torrente del piacere”» (III, p. 199).
Si tratta certo di riconvertire l’aspirazione naturale alla gioia, trasponendola sul piano soprannaturale della vita eterna, di istituire una precisa gerarchia tra i piaceri, accettando i sacrifici della virtú in nome del bene piú grande; ma epicurei e cristiani sembrano poter convergere in un immaginario comune della felicità, che può usare le stesse parole, prescrivere gli stessi criteri di analisi, contando sull’armonia della natura umana, benvoluta da Dio anche quando l’uomo non lo sa. Credendo di amare il piacere, ciascuno, infatti, ama Dio, che è fonte di ogni gioia: «il piacere stesso è amore, poiché Dio fa il piacere» (III, p. 206).
Il canto dell’epicureo e del cristiano, paragonati a una rondine e a un usignolo, possono insieme diffondersi nell’aria e invitare senza conflitti a due paradisi complementari: «Vegio ha cantato sotto i portici, secondo il costume della rondine, il Raudense ha modulato il suo canto dopo il tramonto del sole, il che è proprio del solo usignolo … Vegio ci introdusse col corpo nel paradiso (cosí infatti i Greci chiamano gli orti) e il Raudense, parlando in questo paradiso stesso, ci ha rapiti con l’animo verso un altro paradiso piú eccellente» (III, pp. 247-48).
Il destino individuale (di cui Valla si occupa nel Dialogo intorno al libero arbitrio), frutto di una scelta tra molti percorsi possibili, resta affidato alla natura specifica di ciascuno e, piú che all’astratta ragione dei filosofi, alla capacità di amare (p. 280), che non ha un vero ostacolo nel desiderio dei piaceri: «Affinché la grandezza delle rivelazioni non mi insuperbisca troppo mi è stato dato lo stimolo della carne», ricorda Valla, citando Paolo (2 Cor, 12.7). Aderire a se stessi, e alla natura dell’uomo tutta intera, è il cuore del suo messaggio, che troverà un attento estimatore in Leibniz.
Novità importanti si segnalano anche sul versante dell’aristotelismo, ripensato attraverso l’ideale di vita attiva proposto dall’Etica Nicomachea e dalla Politica.
Era stato Coluccio Salutati, cancelliere a Firenze per un lungo e difficile periodo (1374-1406), a rilanciare il valore civile dell’impegno nel lavoro sociale e politico rispetto alla scelta contemplativa, buona forse per il singolo, ma colpevolmente indifferente verso i vincoli naturali di solidarietà umana. Leonardo Bruni, come lui impegnato politicamente, tra la Curia papale e Firenze, sostiene il valore etico di questa scelta con un imponente lavoro filosofico, che comprende prima di tutto la traduzione di testi fondamentali di Platone (Fedone, Gorgia, Fedro, Apologia, Critone, Epistole, Simposio) e di Aristotele (Etica Nicomachea, Politica, Economici), oltre a Plutarco, Senofonte, Demostene e Eschine. L’ideale civile è il criterio che ispira la sua ricerca del sommo bene nel confronto tra le scuole filosofiche antiche. La definizione aristotelica del «compito specifico dell’uomo», che fissa il primato dell’agire sociale (Introduzione alla dottrina morale, pp. 209-11), è il nucleo di condensazione di una proposta etica che integra facilmente la concezione stoica della virtú, letta come «dottrina virile e forte» di impegno (p. 213), ma non disdegna il piacere epicureo «retto, regolato e prudente» (p. 217), che si compone in armonia con uno stile di vita onesto. La vita contemplativa avrà i suoi meriti ed «è certamente piú elevata e piú rara» la virtú di chi si dedica ad essa; ma la vita attiva, dove domina la virtú aristotelica della «prudenza», è «piú efficace nell’interesse comune» (p. 239).
Lo spostamento dell’attenzione sull’al di qua della felicità terrena poteva mettere in ombra il valore della morale cristiana, rivolta al pensiero dell’al di là, ma Bruni è convinto dell’assoluta continuità tra gli ideali etici professati dai filosofi antichi, ispiratori laici del suo impegno, e il pensiero sociale cristiano (Dedica a Papa Eugenio IV, pp. 113-17).
Anche Giannozzo Manetti (1396-1459) considerava l’Etica aristotelica suo testo di riferimento, accanto al De Civitate Dei di Agostino e alle Lettere di Paolo.
Esule a Napoli, mentre a Firenze si delineava il nuovo quadro politico della signoria medicea, Manetti compone, su invito del dotto re Alfonso, i quattro libri Sulla dignità e l’eccellenza dell’uomo (1451-52), in cui si delinea a tutto campo la nuova immagine antropologica. La perfezione del corpo umano (libro I), le straordinarie capacità costruttive dell’anima (libro II), l’armonia dell’insieme che ne deriva (libro III) sono i punti forti di un’analisi che intende ribaltare completamente l’immagine di sofferenza e di rinuncia tradizionalmente connessa alla virtú cristiana. Nei piani del creatore c’era ben altro che l’umiliazione ascetica nel dolore, secondo Manetti: confutando nel IV libro Innocenzo III, il suo scritto Sulla miseria della vita umana e, con lui, tutta una tradizione colpevolizzante e punitiva nei confronti dell’uomo, Manetti si appoggia a Paolo, ad Agostino, agli spunti profetici dei Vangeli, alle immagini del paradiso dell’Apocalisse di Giovanni, per prospettare un destino di felicità iscritto nella natura dell’uomo, nella sua eccezionale capacità di capire e di agire. La formula agere et intelligere è usata per definire, aristotelicamente, «il compito proprio soltanto dell’uomo», assai piú caratterizzante del ridere, che ha attirato l’attenzione dei filosofi antichi e moderni (III, p. 91). Quanto alla felicità, tutti gli argomenti addotti dai filosofi pagani per giustificare la sofferenza, per sostenere il vantaggio della morte e la necessaria infelicità della vita umana, fissati emblematicamente nella famosa sentenza del Sileno (IV, p. 109), riproposti e amplificati da testi autorevoli per i cristiani, come l’Ecclesiaste e il Libro di Giobbe (pp. 109-10), compongono un quadro assolutamente ingannevole delle intenzioni del Creatore. Confutando punto per punto le implicazioni che gli interpreti hanno creduto di trarne, Manetti esalta tutto ciò che nella natura dell’uomo appare predisposto perché egli tragga utilità e piacere dall’esercizio di ogni sua facoltà. E, citando il decimo libro dell’Etica Nicomachea, sostiene che il piacere «è assolutamente inseparabile dall’attività dell’uomo» (IV, p. 134), per accostare subito dopo questa convinzione alla promessa di eterna giovinezza del corpo e dell’anima, con cui tutti i testi sacri invitano ad immaginare lo stato dell’uomo in paradiso: bello e splendente di gioia, come il corpo glorioso di Cristo dopo la resurrezione (pp. 135-39).
Nello stesso spirito l’uomo poteva essere inteso come artefice del proprio destino, dominatore della Fortuna. In questo senso progettuale e costruttivo si esprimeva Leon Battista Alberti, forse la personalità piú emblematica, con le sue luci ed ombre, di una straordinaria stagione culturale. Letterato, artista, soprattutto architetto di eccezionale talento, Alberti propone nelle opere ispirate alla sua concezione dell’arte (De pictura, De re aedificatoria) un’idea prometeica dell’uomo, responsabile non solo del proprio destino, ma della bellezza del mondo in cui andrà ad abitare. Aggiungere armonia a ciò che dipinge, prendendo a modello l’opera creativa della natura, concepire un ordine compositivo per la città, che risponda ai due fini complementari di utilità e bellezza, è il compito nuovo, di grande importanza civile, che innalza l’artista a poietes, costruttore di una realtà umana che ancora non c’è: «La bellezza è dunque un fattore della massima importanza e dev’essere ricercata con grande impegno soprattutto da chi intende rendere piacevoli le cose proprie. Il posto preminente che ad essa attribuirono i nostri antenati, da uomini saggi quali erano, risulta tra l’altro dalla incredibile cura che essi impiegarono per adornare riccamente le manifestazioni dei piú vari campi della vita pubblica: diritto, vita militare, religione, ecc.; lasciando intendere, probabilmente, che queste attività, senza le quali la società civile cessa sostanzialmente di esistere, una volta private della magnificenza dell’ornamento si riducono ad un commercio insipido e insulso» (L’architettura, VI, 2, pp. 233-34). La minaccia dell’insignificanza è l’altra faccia dello slancio costruttivo e idealizzante: dove non agisce lo stimolo imperativo della bellezza, la degradazione non ha limiti; al lucido sguardo di Alberti appare una visione disperante del mondo degli uomini, del suo disordine, della cattiveria e della follia che vi regnano, esponendo ciascuno all’arbitrio di una Fortuna non solo causale, piú spesso malevola e persecutrice. È soprattutto l’inconsistenza a caratterizzare l’esistenza dell’uomo: «quasi umbra di un sogno», lo definisce, citando Pindaro, nato per piangere la sua miseria da «verminuccio», la sua dipendenza da ogni cosa, la fragilità della sua vita (Theogenius, pp. 89-90); eppure crudele piú di ogni altro animale verso i suoi simili, piú dei lupi, cui il poeta Plauto voleva avvicinare la sua ferocia (il riferimento è alla formula «lupus est homo homini», Asinaria, v. 495, poi ripresa da Erasmo e da Hobbes: Theogenius, p. 94).
La virtú, cui Alberti affida la possibilità di non soccombere al «gioco» della Fortuna (I libri della famiglia, «Prologo», p. 6), è quella del rigore, dell’autodominio stoico, capace di parare ogni colpo in anticipo, per il solo fatto di contare sulle proprie forze: nel fiume rapinoso della vita, che espone ai pericoli piú gravi chi crede di navigare sicuro sugli otri della ricchezza, «migliore è la sorte di quanti, fidando nelle proprie forze fin da principio, nuotano lungo tutto il corso della vita» (Il Fato e la Fortuna, p. 649); tra questi, in posizione eminente si trovano gli infaticabili costruttori, che, con quanto hanno a disposizione, approntano «zattere (tabulas)» per sé e per quelli «che ancora nuotano in mezzo al fiume» (p. 655).
Si tratta di uno stoicismo sui generis, che sembra recuperare sul piano espansivo della progettazione quanto perde dal lato della fiducia nell’armonia razionale del cosmo, nella provvidenza divina. In ogni caso, a questo eroismo d’artista restano affidate le scarse speranze di felicità dei pochi, tanto sensibili al bene della bellezza e della virtú, quanto consapevoli della sua fragilità. Se non fosse per la stoltezza degli uomini, la convinzione di Alberti è che «l’uomo da natura essere atto e fatto a usufruttare le cose, e nato per esser felice. Ma questa felicità da tutti non è conosciuta, anzi da diversi diversa stimata» (I libri della famiglia, I, p. 134). Alla follia dei molti corrisponde la solitaria operosità dei virtuosi, malinconicamente coscienti della difficoltà di fronteggiare il caos, ma attratti dalla grandezza dell’impresa: «Troppo mi piace la sentenza d’Aristotile, el quale costituí l’uomo essere quasi come un mortale Iddio felice, intendendo e faccendo con ragione e virtú» (p. 132).
Oltre le delusioni e le sconfitte, da mettere nel conto della Fortuna, esiste un’altra prospettiva per il virtuoso, legata al piacere della ricerca in se stessa, all’appagamento intellettuale che l’andare a caccia di verità, secondo il proprio talento, porta con sé: «L’animo nostro si pasce della investigazione e apprensione delle cose degne; e quando ben vi fusse qualche fatica, niuna cosa si fa in vita sí facile ch’ella non sia laboriosa a chi ella non piace. Cosí niuna delle cose degne sarà tanto laboriosa qual non sia con voluttà a chi la tratti con desiderio d’assequirla … Non si può descrivere né stimare il piacere qual seque a chi cerca presso a’ dotti le ragioni e cagioni delle cose; e vedersi per questa opera fare da ogni parte piú esculto, non è dubbio, supera tutte l’altre felicità qual possa l’omo avere in vita» (De iciarchia, I, p. 213).
Il platonismo, latente nell’estetica di Alberti, si guadagnava intanto una posizione di primo piano nel microcosmo della cultura fiorentina. L’insegnamento del greco (a partire dalla prima cattedra istituita nel 1397 per il bizantino Crisolora), i testi di Platone, di Plotino e della tradizione ermetica, messi a disposizione dai maestri bizantini affluiti a Firenze in diverse riprese (agli inizi del Quattrocento, poi nel 1439 per il Concilio cattolico-ortodosso di Ferrara-Firenze, infine alla caduta di Costantinopoli nel 1453), avevano alimentato studi e traduzioni, riaprendo la discussione sulla tradizione platonica e sapienziale antica.
Dopo la metà del secolo, anche l’evoluzione signorile della politica fiorentina spingeva a valorizzare i temi filosofici di interesse contemplativo rispetto a quelli dell’impegno civile repubblicano. Per quanto questo non possa spiegare la rinascita del platonismo e la profondità dei suoi effetti di rinnovamento sulla cultura filosofica, è indubbio che alla precisa volontà di Cosimo de’ Medici dobbiamo l’inizio degli studi intensivi di Marsilio Ficino, la mente direttiva del neoplatonismo rinascimentale. Tra il 1462 (data in cui riceve da Cosimo nuovi codici platonici e la villa di Careggi, in cui dedicarsi allo studio e alla traduzione) e il 1492 (data in cui pubblica a stampa la prima traduzione latina di Plotino), Ficino mette a disposizione u...