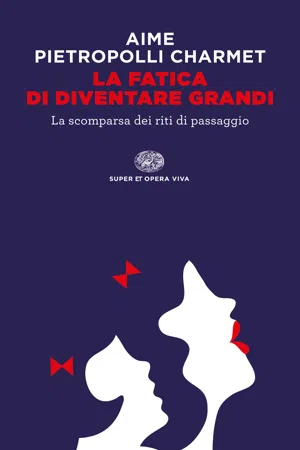![]()
![]()
Il tempo non ha un’esistenza indipendentemente avulsa dall’ordine di eventi attraverso cui noi lo misuriamo.
A. EINSTEIN
1. Percepire il tempo che passa.
«Che cos’è il tempo? Se nessuno m’interroga lo so. Se volessi spiegarlo a chi mi interroga, non lo so», scriveva sant’Agostino. Infatti, sebbene siamo abituati a convivere con il tempo e a utilizzarlo per organizzare la nostra vita, quando ci soffermiamo a riflettere sulla sua vera natura, sulla sua essenza, ci troviamo di fronte a un problema complesso. Problema in qualche modo risolto dalla mano di un anonimo che su un muro di Genova ha scritto: «Il tempo non esiste, gli orologi sí».
In effetti, il tempo esiste proprio nel momento in cui cerchiamo di afferrarlo, per sottoporlo a una qualche forma di misurazione. Come afferma il grande antropologo britannico Edmund Leach:
Noi parliamo di misurare il tempo come se il tempo fosse una cosa concreta posta lí per essere misurata; ma di fatto noi, creando degli intervalli nella vita sociale, creiamo il tempo. Fino a che non abbiamo operato questa suddivisione non c’è tempo da misurare1.
Insomma, siamo noi a «inventare» il tempo nel momento in cui ci mettiamo a calcolarlo. Per fare questo dobbiamo fissare punti fermi, che scandiscano cadenze, appigli a cui aggrapparci seppur arbitrari. Tali scansioni temporali diventano ancora piú importanti quando vengono applicate all’esistenza umana, a quel ciclo della vita che ci vede tutti coinvolti in un processo che porta dalla nascita al decesso.
Quale che sia la nostra cultura di appartenenza, quale la religione che professiamo, quale la lingua che parliamo, quale il colore della nostra pelle, tutti noi umani veniamo al mondo, cresciamo, ci sviluppiamo, poi, piú o meno lentamente, iniziamo a declinare fino al termine del nostro cammino. Si tratta di un processo naturale, di cui tentiamo di rallentare la corsa con adeguate cure mediche, ma al quale siamo inevitabilmente sottoposti.
L’invecchiamento biologico che il nostro corpo, come ogni altro organismo vivente, subisce, viene però percepito e accompagnato, nelle diverse società umane, da differenti processi di interpretazione. Tali modelli riflettono le modalità di percezione che ogni cultura ha dell’invecchiamento, ed è sulla base di queste percezioni che si costruiscono i diversi sistemi di classificazione dell’età.
Se lo sviluppo biologico segue un percorso lineare, cumulativo, costante e continuo, perché la natura non fa salti, quello sociale viene spesso frazionato in fasi, culturalmente determinate, che mettono in evidenza le differenti percezioni che la società ha dei propri componenti. Tutti i sistemi inventati per scandire la vita umana non sono solamente codici comuni finalizzati a definire piú o meno approssimativamente l’età di un individuo. In alcuni casi sono legati anche a modelli di assegnazione dei diversi ruoli sociali sulla base dell’età. Infatti, come vedremo, l’invecchiamento fisico si intreccia talvolta, in modo piú o meno evidente, con la posizione che la società ci assegna.
Un esempio di come l’età possa condizionare i rapporti umani è fornito dal Giappone odierno: l’antropologa giapponese Chie Nakane descrive dettagliatamente il rituale dello scambio dei biglietti da visita, che avviene ogni volta che due o piú sconosciuti si incontrano. Tale scambio è finalizzato a stabilire immediatamente la posizione relativa dei due individui, e di conseguenza il modo di rapportarsi dell’uno nei confronti dell’altro. Infatti, nella società giapponese gli uomini si dividono in tre categorie fondamentali: i senpai (senior), i kohai (junior) e i doryo (colleghi). Tale divisione è basata sul rango, che a sua volta è determinato dall’anzianità: non solo dall’età biologica, ma anche da quella di assunzione in una ditta, di laurea o di diploma. Di conseguenza ogni individuo si rivolgerà al suo interlocutore con appellativi diversi. Infatti, scrive la Nakane:
Questa partizione si ripresenta nelle tre forme in cui ci si rivolge a una seconda o terza persona; il signor Tanaka, per esempio, può essere chiamato Tanaka-san, Tanaka-kun o semplicemente Tanaka, senza suffisso. San si usa per i senpai, kun per i kohai e il nome senza suffisso è riservato ai doryo2.
Ogni società non solo stabilisce un metodo per calcolare l’età, ma attribuisce alle diverse fasi della vita significati differenti, che implicano anche determinati stereotipi relativi allo sviluppo intellettuale, morale e sociale. Ci si aspetta che le persone cambino il loro comportamento e assumano di volta in volta un ruolo considerato consono al periodo dell’esistenza che stanno vivendo. Per esempio, in molte società tradizionali agli anziani viene riservato un ruolo fondamentale, che prevede rispetto, espresso a volte anche con gesti o atteggiamenti particolari, come un inchino o il divieto di guardarli negli occhi. Sono numerosissimi i proverbi che richiamano questa concezione. Ecco tre esempi africani: «Gli anziani e Dio non sono compagni, ma sono stati molto tempo assieme»; «La saggezza è come il fungo, cresce solo nella stagione avanzata»; «Il giovane sogna di diventare ricco, l’anziano spera di non diventare povero». E uno cinese: «Consulta il padre quando è ancora vivo, consulta il suo esempio quando non c’è piú».
Nelle società occidentali industrializzate, come si è detto, lo status degli anziani è stato piuttosto ridimensionato, in quanto sono ormai espulsi dal ciclo produttivo. Negli ultimi decenni, però, qualcosa è mutato. Peter Laslett, storico inglese tra i promotori del Gruppo di Cambridge e fondatore delle prime università della terza età inglesi, ha proposto una rilettura del ruolo degli anziani alla luce delle nuove speranze di vita offerte dalla nostra società, tenendo conto che oggi un quinto della popolazione dell’Occidente è costituita da pensionati e la percentuale è destinata ad aumentare3. In altri termini, è nata una nuova generazione, quella degli over sessanta, che nel secolo scorso era assai ridotta e per lo piú costituita da persone in condizioni fisiche precarie.
Dato che la vita media di noi occidentali si è allungata rispetto al passato, accade che un uomo sulla sessantina sia ancora potenzialmente attivo, anche se escluso dal processo produttivo, considerato un fattore di integrazione determinante e un protagonista sociale ed economico oltremodo significativo. Infatti, per quanto riguarda l’Italia, la generazione degli ultrasessantenni è in molti casi quella che detiene la maggior parte del patrimonio: è la generazione che ha goduto del lavoro fisso e per di piú in anni in cui il potere di acquisto era maggiore, riuscendo cosí a realizzare quel risparmio che ancora oggi, sebbene sempre piú minacciato, è una delle fonti di salvezza di parecchie famiglie italiane. Salute fisica e disponibilità finanziaria fanno di questi «vecchietti» protagonisti attivi, a cui la società dei consumi presta un’attenzione sempre crescente.
Analogamente è previsto che un bambino non sia ancora a conoscenza delle regole sociali, che compia errori, che sia libero di divertirsi e che debba apprendere dagli adulti. Mentre da un giovane ci si attende un certo grado di trasgressione, di conflitto con i genitori, ma anche un progressivo avvicinamento al comportamento sociale ritenuto corretto.
Tali percezioni sono in parte condivise da moltissime società umane, con specificità che però le rendono diverse. Inoltre, non sono sempre basate su un’età precisa, ma su una fase della vita, che può essere definita in modo differente a seconda della cultura. Termini come bambino, child, Kinder, enfant indicano una concezione sociale del piccolo individuo. Non esiste un’età assoluta in cui si cessa di essere bambini: ogni cultura determina il passaggio a un’età informale superiore (adolescente, ragazzo) in base a elementi diversi. Nella società occidentale contemporanea, potremmo dire che è la scuola a determinare la scansione delle prime fasce d’età. In genere, terminate le scuole elementari, non si è piú «bambini».
Presso i taneka del Benin settentrionale, per esempio, nei primi anni di vita, i bambini vengono chiamati bihà, termine che definisce gli animaletti selvatici della boscaglia. Una metafora con cui si indicano individui che non hanno ancora appreso le regole del vivere in società. Viene riconosciuto uno status maggiore quando il maschietto è in grado di manovrare la zappa e la ragazzina di trasportare la legna sulla testa (piú o meno attorno agli otto-dieci anni). In pratica, quando si entra a fare parte del ciclo produttivo. Questo atteggiamento è significativo, in quanto lega all’età biologica l’attribuzione di un riconoscimento sociale connesso al lavoro.
Il modo di classificare l’età, però, non muta solo in funzione della diversità culturale, ma anche all’interno di una stessa società con il trascorrere del tempo. Un giorno, viaggiando in auto, ascoltavo un dibattito alla radio su bambini e infanzia. Un ascoltatore parlò a lungo dei problemi della sua bambina, fino a quando il conduttore della trasmissione gli chiese quanti anni avesse costei. «Quattordici», rispose l’ascoltatore e la discussione proseguí tranquillamente. Mi venne spontaneo chiedermi se a quattordici anni si è ancora bambini. Pensavo ai miei genitori o ancora di piú ai miei nonni, che a quell’età lavoravano e non erano considerati bambini nel senso in cui lo intendiamo oggi. Tale termine è associato, nel nostro immaginario, al concetto di infanzia, e questo ci rimanda automaticamente al periodo dei giochi, del divertimento e del primo apprendimento. È, però, sufficiente leggere i romanzi di Charles Dickens o di Émile Zola per comprendere come, quasi due secoli fa, quelli che oggi chiamiamo bambini fossero pienamente inseriti nel processo produttivo industriale e implicati in lavori anche pesanti. Nell’Europa del XIX e del XX secolo c’era una forte domanda di lavoro minorile e i ragazzi partecipavano a moltissime attività produttive e di supporto. Come scrive amaramente Marvin Harris:
Ai bambini che, in precedenza erano stati trascurati, abbandonati o uccisi durante l’infanzia, veniva ora concesso il privilegio di vivere fino all’età in cui potevano cominciare a lavorare in una fabbrica per alcuni anni prima di soccombere alla tubercolosi4.
Se poi ci spostiamo al di fuori del mondo occidentale (dove peraltro sono presenti ampie sacche di sfruttamento dei minori), quando ci si trova di fronte alla questione del «lavoro minorile» in certi Paesi extraeuropei, tale divario di concezioni risulta evidente. A proposito, la lingua inglese distingue con termini diversi due tipologie di lavoro: work indica il lavoro salariato, inserito in un processo produttivo esterno alla famiglia; labour è, invece, il lavoro svolto all’interno del contesto familiare, come accade, per esempio, nelle società contadine, dove i piccoli vengono piano piano addestrati e inclusi nel ciclo produttivo domestico. Si tratta di due tipologie differenti. Se nella prima possiamo vedere uno sfruttamento, nella seconda ravvisiamo un normale apprendistato all’interno della famiglia.
Per quanto il primo fenomeno possa essere deprecabile, spesso si assiste ad analisi viziate da un certo etnocentrismo, che porta a giudicare il problema sulla base del nostro metro attuale. Lo status di bambini non è un dato naturale, ma il prodotto di determinate condizioni sociali, che porta una società a definirlo sulla base delle necessità. In alcune situazioni il lavoro minorile non è una scelta, ma l’unico modo per sopravvivere.
Non a caso molti storici della famiglia parlano di «invenzione» dell’infanzia come di una conquista della società occidentale contemporanea. Come sostiene Philippe Ariès nel suo bellissimo libro Padri e figli nell’Europa medievale e moderna, nell’Europa preindustriale non si distingueva affatto l’infanzia dalle altre fasi della vita preadulta. Neppure l’adolescenza veniva differenziata dall’infanzia5. L’unica vera distinzione piú o meno netta era tra l’essere giovani e l’essere adulti. Ed è per questo che il passaggio dalla prima fase alla seconda in quasi tutte le società viene marcato da qualche evento particolare di carattere collettivo.
Perché è cosí importante evidenziare le differenze tra giovani e adulti? Perché l’adolescenza, che è lo stato di transizione tra la condizione di bambino e quella di adulto, una sorta di migrazione interna dalla dimensione tranquilla e protetta dell’infanzia, totalmente dipendente dalla famiglia, verso una situazione di autonomia decisionale ed economica, nella quale si aprono nuovi e piú impegnativi orizzonti, è una fase molto difficile e delicata, in cui l’individuo inizia a costruire la «sua» identità personale.
Affinché questo accada, occorre che la comunità, in cui si vive e si cresce, ponga limiti, fissi punti fermi. Si tratta, infatti, di una fase di rapida trasformazione biologica, in cui l’individuo inizia a prendere coscienza di se stesso e del fatto che deve decidere per conto suo. Come afferma Jean Piaget, rispetto al bambino, l’adolescente elabora sistemi e teorie. Mentre il bambino piccolo riporta tutto a se stesso e si costruisce un mondo a parte, a scala ridotta rispetto a quello dei grandi, l’adolescente si crea un programma di vita suo e, pur sentendosi diverso, si pone su un piano di eguaglianza rispetto agli adulti. Di qui nascono la tipica irrequietezza e la tendenza alla ribellione che ca...