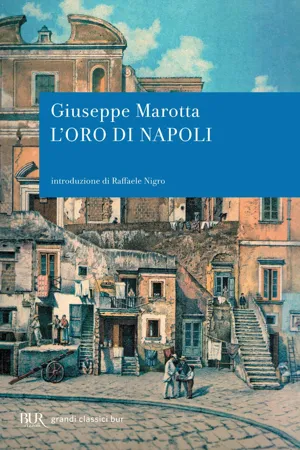![]()
I parenti ricchi
Mio padre morì il 3 febbraio 1911; allora io dicevo «Mio padre è morto» come se avessi detto qual era la sua professione. Anzi suppongo di aver ostentato, coi compagni del secondo anno di scuola, la mia qualità di orfano: fu insomma una disgrazia di cui sentivo soltanto la rarità e il decoro.
Ma un bambino cresce anche per ricostruire i fatti ai quali ebbe tutta l’aria di non partecipare, finché diventa uomo e se li scopre addosso come minuziose cicatrici. Il 3 febbraio ritorna puntualmente ogni anno; in questa giornata, dovunque io sia, mi fluttua intorno un odore di ceri e di ghirlande: in casa apro le finestre e taccio; a un certo punto i miei figli interrompono i loro giuochi e non sanno perché. Mia moglie continua a sorridere, se le va di farlo, perché non abbiamo morti in comune; le portai in dote questo defunto avvocato Marotta che deve passare integralmente ai bambini; le nostre strade divergono nel passato, si dirigono verso morti diversi, che ciascuno, in caso di necessaria separazione (un lungo viaggio, se non addirittura una vedovanza) non affiderebbe all’altro con assoluta fiducia.
Il 3 febbraio 1911 mio padre soggiacque alle estreme conseguenze di una malattia che lo aveva consumato per anni. Tre mesi prima ci eravamo trasferiti a Napoli da Avellino, col ricavato della vendita di un nostro ultimo poderetto. A un certo punto, fissando sempre lo stesso riquadro di pavimento, l’avvocato si era accorto che la terra lo chiamava; avutane conferma da un vecchio medico col quale aveva frequentato il ginnasio, egli pensò ai suoi facoltosi parenti napoletani e decise di morire con le loro mani in mano.
Fu un’idea come un’altra, che ci portò in un qualsiasi vecchio edificio di quella che doveva diventare la mia città.
Per tre mesi la mia nonna materna stipò quella anonima casa di novene, di tridui e di vecchiette reclutate non so come e non so dove, ma che risultavano capaci di recitare con lei fino all’alba novene e tridui. Pregavano tutte insieme, con lo sforzo razionale e collettivo che i pescatori esercitano sul canapo della rete: sepolte nei loro scialli, strenue cariatidi della preghiera, si stimolavano con improvvise recrudescenze individuali di religiosi bisbigli, finché il sonno non arrivava a fulminarle.
Mia nonna e mio padre si erano da poco riconciliati, dopo una decennale inimicizia. L’avvocato Marotta aveva voluto sposare in seconde nozze una sartina di quasi trent’anni più giovane di lui; inoltre, nell’epoca in cui gli arridevano salute e successi, soleva proclamarsi indipendente da quelle stesse celesti autorità che la madre di sua moglie, le cui ginocchia avevano levigato il marmo di tutte le navate irpine, anteponeva a ogni bisogno umano. L’ateismo di mio padre, basandosi quasi esclusivamente sulle manchevolezze dei preti, era superficiale e candido: tanto valeva che egli si fosse rifiutato di credere al Tempo solo perché molti orologi funzionano male. Una mattina, comunque, si agitò eccezionalmente nel suo letto: disse che aveva visto la Madonna di Pompei al suo capezzale, e riprese i rapporti con Dio e con la nonna. Umida di acquasanta, la vecchia ci seguì a Napoli; mi tendeva agguati nel corridoio per costringermi a pregare con lei, ma il Signore era dalla mia parte perché generalmente riuscivo a sfuggirle e mi rifugiavo in terrazza.
Sui muretti crescevano strane e spesse erbe, tumide come labbra; certe foglie parevano polpastrelli: se accarezzandole mi addormentavo al sole, esse mi prendevano per mano e mi portavano nel paese di Sandokan.
In casa, mia madre riempiva siringhe e preparava infusi; col soverchiante odore dei medicinali che respirai in quei mesi, se non lo avessi sperperato dormendo coi dayachi sulla terrazza, potrei curarmi di tutti i mali per vent’anni. Mamma, eri giovane e infelice, allora; da troppo tempo la siringa, fra le tue dita sottili, aspirava guaiacolo e lacrime, determinando una formula terapeutica non meno astrusa e inefficace di qualsiasi altra ufficiale e famosa; da troppo tempo vivevi la tua disperata vigilia. Senonché, in attesa che i parenti ricchi venissero a raccoglierci, l’avvocato Marotta si rifiutava di morire.
Ci eravamo appena allogati nella nuova casa quando egli scrisse e diramò i suoi patetici appelli. Era contento. Riteneva che sua sorella Luisa e gli innumerevoli importanti figli di lei avrebbero formato intorno a noi baluardi di tenerezza.
Diceva: «Del resto non è che una restituzione. Io li ho sempre beneficati. Cedetti a Luisa il meglio dell’eredità paterna. Quirino fu ospite in casa mia per tutto il periodo dei suoi studi. Ma non è il caso di parlarne; si tratta o non si tratta di gente del mio sangue?».
Avvocato, che idea. Ecco una sorgente sulla collina, che forma rivoletti; sappiamo forse che strada prenderà quest’acqua?
Infatti i giorni passavano e nessun parente ricco si faceva vivo. Le condizioni di mio padre peggioravano ora per ora: ma egli si era impuntato, Dio sa a quali cavillosi espedienti legali ricorresse per ottenere tante dilazioni.
Così arrivò finalmente mio cugino Aurelio, l’arciprete. Nel corridoio benedisse le vecchiette oranti; suggerì loro alcune speciali preci, che peraltro erano state già tentate, quindi si chiuse con mia madre nel salotto. Naturalmente io non partecipai a questo fatto; ma più tardi diventai un uomo e me lo scoprii addosso come una cicatrice.
Il cugino Aurelio esordì dicendo che rappresentava anche sua madre e i suoi fratelli. Affermò che ciascuno aveva pianto ricevendo la lettera del morente avvocato. Ma non si sentivano in grado di obbligarsi a ciò che egli si aspettava da loro. Nessuno poteva assumersi, in circostanze così dolorose e solenni, l’impegno di nutrire tre bambini e una vedova. Opportunamente egli non accennò alla nonna, che mangiava soltanto avemarie. Mia madre annodava e scioglieva le sue lunghe dita. Osservò che non si trattava di mantenere, ma soltanto di promettere. L’indispensabile era che l’avvocato finisse di soffrire. Bisognava dargli l’illusione di vincere la sua ultima causa. Egli aveva ormai il diritto di morire: non era più il miscuglio di guaiacolo e di lacrime che lo teneva in vita, ma soltanto un ostinato proposito. A questo punto il cugino Aurelio trasalì.
«Una finzione?» disse scandalizzato. «Io, Concetta, con questo abito?»
Sciogliete le mani di mia madre, scioglietele. Cantava in un cortiletto, stirando biancheria, quando mio padre la vide e deliberò di farne una signora. Era calvo e pingue, ma aveva una bella barba appena spruzzata di grigio, e gli occhiali d’oro. Concetta fu una moglie troppo giovane per lui, ma ecco che l’avvocato agisce da galantuomo, ecco che dopo soli nove anni sta per restituirla al cortiletto.
Sul serio? Parlando al cugino Aurelio, Concetta misteriosamente afferma che non si arriverà a questo. Dopo un enorme silenzio essa fa il nome di un preziosissimo signorotto irpino. Costui ebbe e tuttora ha l’intenzione; se una disgrazia dovesse accadere...
«Voi sapete a chi ho voluto bene, e chi ho sempre rispettato» disse mia madre. «Ma i bambini... mi rimariterei per i bambini. E allora vedete, non occorre che vi preoccupiate per noi. Si tratta soltanto del vostro povero zio. Gli potete promettere tutto.»
Il cugino Aurelio si rassettava macchinalmente la tonaca e rifletteva. Non s’è ancora concluso un romanzo, nella vita di questa giovane moglie, che già un altro se ne inizia: egli era abituato a formulare constatazioni simili, nella remota ombra del confessionale, e probabilmente ne deduceva che i fatti intorno alla donna corrono e s’accalcano perché troppo breve è la sua stagione.
«È sempre una finzione, che ci domandi» disse stancamente.
Mia madre si alzò. Indicando l’attigua camera del malato, ribatté:
«Venite a vederlo. Solo un momento. Venite a vedere se non vale la pena di mentirgli».
Ma l’abito che il cugino Aurelio portava non permise questo. Egli non c’era neppure l’indomani, quando tutti i suoi fratelli, e la stessa zia Luisa, formarono un rispettabile semicerchio presso il letto dell’avvocato.
Erano uomini massicci e gravi, titolari di redditizie professioni, evocativi di targhe smaltate all’uscio e di clienti che dopo aver deposto su uno spigolo della scrivania la grossa busta dell’onorario si allontanano silenziosamente sui tappeti. L’avvocato si era ormai ridotto a chiedere soltanto con gli occhi; ma sovrattutto gli mancava il senso critico. Vedeva le grosse mani dei suoi parenti ricchi sui miei inquieti capelli o sulle esili spalle delle mie sorelle, ma è lecito ritenere che neppure una volta si domandò perché quando essi dicevano: «Le bambine saranno degnamente educate; il ragazzo avrà la sua laurea» non aggiungevano: «Ci penseremo noi». A un certo punto, fu evidente che l’avvocato cercava fra quei confortatori laici il cugino Aurelio; ma come ho detto costui non era venuto, e ancor oggi io rispetto le sue ragioni, anzi lealmente riconosco che egli fu l’unico parente ricco che mi pagò, nel 1916, una tassa scolastica. Suppongo che questo imprevedibile gesto fosse latente, in lui, fin dalla sera in cui mio padre si assopì finalmente in pace, mentre mia madre riconduceva all’uscio, con una fretta che parve ed era eccessiva, la gente del suo sangue.
L’indomani fu il 3 febbraio 1911.
Mia madre tinse di nero, rivoltandoli interminabilmente in un pentolone, i nostri vestiti e i suoi. Ancora per pochi giorni io sostenni con mia nonna, nel corridoio, duelli di agilità e di astuzia, e si capisce che se ero soccombente mi toccava recitare con lei spossanti preghiere, mentre nel caso contrario riuscivo a ricongiungermi, sulla terrazza, con l’imperturbabile Yanez. Furono venduti quasi tutti i mobili, e lasciammo quella casa per una stamberga di cui sto per parlarvi. Mia madre trovò un posto di guardarobiera e stiratrice; lo tenne per oltre dieci anni. Ho dunque molte ragioni di supporre che il preziosissimo signorotto irpino di cui aveva parlato al cugino Aurelio non fosse che un ingegnoso espediente di infermiera. Non se ne sa mai abbastanza sulle donne. Comunque fu una buona mamma; voi capite che una madre simile io andrei sin nell’inferno a riprendermela.
La casa in cui ci trasferimmo era uno stanzone alla base del campanile di Sant’Agostino degli Scalzi; una porta-finestra dava in una esigua striscia di terreno sassoso come il letto di un torrente, che noi chiamavamo giardino; sei lire al mese pagavamo d’affitto.
Come guardarobiera e stiratrice del Conte di M. la vedova Marotta (questa madre dalle lacrime e dai sorrisi subitanei, che mi ha trasmesso molti connotati fisici e la confidenziale, perentoria maniera di parlare dei miei guai ai santi) percepiva un salario di dieci lire settimanali. Chiusasi dietro a mio padre la porta di questo mondo, essa parlò alla zia Luisa del seppellimento.
«Voi che siete sua, sorella, e che possedete una tomba di famiglia a Poggioreale, non potreste accogliervelo?» disse.
La zia Luisa era una gelida vecchietta con la quale spero che non mi sia riserbato nessun incontro ultraterreno. Rimproverò mia madre per la sua vanità, le raccomandò di adeguarsi al nostro nuovo stato, dichiarò che il collocamento di suo fratello nella tomba dei Nardi esigeva costosissime pratiche, e lasciò capire che io avrei potuto recarmi alla sua villa tutti i pomeriggi, per ritirare gli avanzi del pranzo.
Così mio padre si allogò nella fossa comune, dove immagino che Dio fosse costretto a frugare a lungo, ogni volta che gli orfani e la vedova pregavano per il defunto avvocato; quanto ai cibi, andavo effettivamente a prenderli ogni giorno alle sedici e ancor oggi, se ci ripenso, mi sento il tepore e la forma del pentolino fra le dita, mentre le inferriate del Ponte della Sanità (i Nardi abitavano a Capodimonte) mi sfilano accanto non più rigide e fredde come mi apparivano allora, ma illeggiadrite e spiritualizzate dal ricordo, dolci come stecche di ventaglio.
Nel pentolino la zia Luisa mescolava tutto, spaghetti e insalata e magari croste di “sfogliatelle”; ma la fame non bada a queste cose.
Finché da un maturo cameriere del Conte di M., dopo un po’ che serviva in quella casa, mia madre ebbe una autentica proposta di matrimonio.
Pensate a una casa di poveri, posta al pianterreno di un campanile, nel giorno in cui la giovane vedova che ha suddiviso il locale mediante coperte sostenute da corde tese, per separare di notte il figlio maschio dalle femmine, viene chiesta ufficialmente in moglie da un grosso e bonario cameriere.
Maria, la mia sorella maggiore, mi aveva vagamente informato di ciò che stava per accadere. Per tutta la mattina io non ebbi il coraggio di guardare mia madre; d’altronde immagino che essendo egualmente occupata a sfuggire i miei occhi attoniti, essa non si avvide del mio disagio.
Era una nuvolosa domenica di marzo; mia madre cominciò a sfaccendare con lo strofinaccio fin dall’alba, come se avesse dovuto asciugare tutta la città lavata dalla pioggia; spolverò e lucidò con l’alito il grande ritratto di mio padre, fece altrettanto con noi, ci collocò su tre sedie contro la parete d’ingresso, specialmente della mia pettinatura pareva preoccupata.
Ricordo i volti seri e assorti delle mie sorelle (le bambine, al contrario dei maschi, hanno sempre l’aria di saper tutto sul matrimonio); quanto a me sentivo di essermi irreparabilmente smarrito, suppongo che mi ero trasformato in uno qualsiasi degli oggetti della casa, fra i più fragili, forse il lume a petrolio o la campana di vetro su Gesù Bambino, che pareva dover cadere, e infrangersi da un momento all’altro. Pensavo alle sere che andavo ad aspettare mia madre in Via dei Mille, presso la casa del Conte. Compariva e con lievi gesti mi rassettava il vestito. Prendevo la sua mano e ci avviavamo. Era lunga la strada; sulle salite del Museo o di Santa Teresa io camminando mi addormentavo, con la fiducia e il tepore di quella cara mano nelle dita. Forse non più che per un passo o due; riaprendo con un sussulto gli occhi pesanti, tornavo a vedere il suo volto bianco dietro la veletta; eravamo a Toledo e lei già diceva: «Peppino, siamo arrivati». Possibile che ora avesse dimenticato tutto questo? «Mamma, tu eri già fidanzata con me!» avrei voluto dirle mettendomi a piangere.
Arrivò prima don Aurelio, il cugino prete, che doveva presiedere alla cerimonia: mentre mia madre gli serviva il caffè, entrò in una folata di pioggia l’eventuale sposo. Si sedette e si mise il cappello sulle ginocchia. La tonaca e l’anello del cugino prete lo intimidivano. I miei occhi erano diventati finestre, le pareti si allontanavano e noi eravamo là, al centro di una radura. Mia madre non guardava niente e nessuno. Disse:
«Don Aurelio, questo è don Salvatore di cui vi ho parlato».
«Servo vostro, eminenza» disse il cameriere grasso.
«Non sono eminenza» dichiarò il cugino prete.
«Monsignore, bacio le mani.»
«Non sono monsignore.»
«E pazienza. Con auguri e per cento anni» concluse rassegnato il visitatore.
Silenzio. Mia madre non si era seduta. Ritta sotto il ritratto del suo morto avvocato era andata a mettersi, piccola e bianca e senza forme come le mamme in realtà non sono che nel ricordo dei figli maschi.
«Parliamo, Concetta» disse il cugino prete.
«Mi vuole» disse semplicemente mia madre, indicando il cameriere grasso.
Don Aurelio formulò adeguate domande. Don Salvatore dichiarò che era da vent’anni al servizio del Conte di M., rivelò che possedeva un gruzzoletto, confermò la sua intenzione di sposare al più presto mia madre.
«Concetta, stammi a sentire» disse il cugino prete. «Don Salvatore mi sembra un uomo serio e dabbene. Per me, non vedo difficoltà.»
«Gesù» replicò mia madre. «Domandategli perché non si è sposato prima!»
Non riconoscevo la sua voce. Le parole pareva che le si tarlassero in bocca. Se una vedova di avvocato, successivamente diventata guardarobiera, può sogghignare, ritengo che mia madre sogghignasse. Vedevo le sue mani tremare. Ripeté:
«Perché non vi siete sposato prima?».
«Non lo so» rispose il cameriere grasso. «Il matrimonio è come la morte, viene una volta sola.»
«Francamente, don Salvatore, questo non è normale» disse mia madre, con un riso isterico. «Voi arrivate a quarantacinque anni senza sposarvi, e poi di colpo, vedete me...»
«Signora mia, destino; significa che a questo dovevo arrivare. »
Il cameriere grasso aggiunse che non giustificava l’evidente ostilità di mia madre. Che c’era da dire sul suo conto? Era onesto, aveva una casa e un po’ di denaro: tutto il rione di Chiaia poteva testimoniare su questo.
Il cugino prete approvò celestialmente. Mia madre sussultò accorgendosene. Disse:
«Nel vostro interesse, don Salvatore, non fatemi parlare!».
Il cameriere grasso impallidì. Nella vita dei camerieri grassi, per esemplari che siano, c’è sempre qualche fosco episodio di marsine rivoltate e fatte pagare per nuove al padrone.
«Donna Concetta, che c’è?» disse comunque il cameriere grasso.
Mamma, ti rivedo. Addossata al muro sotto il ritratto del defunto avvocato, tu ti irrigidivi sempre più; una pietosa fierezza induriva il tuo volto bianco e le parole ti si tarlavano in bocca.
«I miei tre figli, don Salvatore.»
«Certo» disse il cugino prete. «Avranno in lui un secondo padre.»
«Così è» disse, sogguardandoci, il cameriere grasso.
«Figuriamoci!» esclamò mia madre...