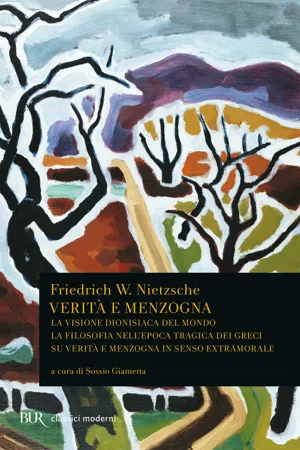
- 192 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Verità e menzogna
Informazioni su questo libro
In 'Verità e menzogna' si trovano raccolti tre scritti di Nietzsche. Tre scritti giovanili, nei quali si intravedono i grandi temi della maturità. C'è la distinzione tra apollineo e dionisiaco, che poi sarà al centro della Nascita della tragedia. C'è la riscoperta dei presocratici. C'è la prima e insuperata teoria della conoscenza che nega la possibilità stessa della conoscenza e propone quello scenario scettico che nella maturità approderà al nichilismo. E c'è, soprattutto, la potenza di uno stile visionario e di un temperamento esplosivo, quello stile e quel temperamento che sconvolgeranno la modernità con la forza di un terremoto.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Print ISBN
9788817010597eBook ISBN
9788858657812LA FILOSOFIA NELL’EPOCA TRAGICA DEI GRECI
dp n="86" folio="86" ? dp n="87" folio="87" ?Degli uomini che sono lontani da noi ci basta conoscere i fini per approvarli o rifiutarli nel loro complesso. Per quelli che ci sono più vicini, giudichiamo in base ai mezzi con cui essi perseguono i loro fini; spesso disapproviamo i loro fini, però li amiamo per i loro mezzi e per il loro modo di volere. Orbene, i sistemi filosofici sono interamente veri solo per i loro fondatori; per tutti i filosofi posteriori ciascuno di essi è di solito un unico grande errore, e per le teste meno forti è una somma di errori e verità; ma in ogni caso, nel suo fine supremo, è un errore e pertanto rigettabile. Perciò molti disapprovano qualunque filosofo, dato che il suo fine non è il loro: sono quelli che stanno più lontano. Chi invece prova gioia per i grandi uomini in genere, prova gioia parimenti per tali sistemi, anche se sono del tutto erronei, perché hanno comunque in sé un punto che è assolutamente inconfutabile, un pathos e un colore personale, che possono servire per ricavare l’immagine del filosofo, allo stesso modo che dalla vegetazione di un certo luogo si può capire la natura del terreno. Quel modo di vivere e di vedere le cose umane è comunque esistito una volta ed è dunque sempre possibile; il «sistema», o almeno una parte del sistema, è quello che cresce1 su questo terreno.
dp n="88" folio="88" ? Qui io racconto, semplificata, la storia di quei filosofi. Metterò in rilievo, in ogni sistema, solo quel punto che è un campione di personalità e appartiene a quella parte inconfutabile e indiscutibile di esso che la storia ha il dovere di conservare. È un cominciamento per ricuperare e far rivivere quelle nature per via di paragone e infine per far risuonare ancora una volta la polifonia della natura greca. Il compito consiste nel riportare alla luce ciò che sempre ameremo e venereremo e che nessuna conoscenza futura potrà mai rubarci: il grande uomo.
Questo tentativo di raccontare la storia dei filosofi greci più antichi si distingue da altri tentativi consimili per la sua brevità. Questa è ottenuta menzionando, di ogni filosofo, solo un numero molto esiguo di teorie – dunque grazie all’incompletezza. Ma le teorie scelte sono quelle in cui si fa sentire più forte il tono personale del filosofo, mentre una completa enumerazione di tutte le possibili teorie tramandate, come si usa fare nei manuali, porta comunque all’unico risultato di ridurre completamente al silenzio ciò che è più personale. Questa è la ragione per cui quelle esposizioni diventano poi così noiose. Nei sistemi confutati, infatti, quello che ancora può interessarci è solo la personalità, perché essa resta eternamente inconfutabile. Con tre aneddoti è possibile tratteggiare l’immagine di un uomo. Io cerco di mettere in luce, in ogni sistema, tre aneddoti e lascio perdere il resto.
1
Ci sono avversari della filosofia, e si fa bene a dar loro ascolto, specialmente quando sconsigliano la metafisica alle teste malate dei Tedeschi, predicando loro, al posto di quella, una purificazione attraverso la physis, come Goethe, o un risanamento attraverso la musica, come Richard Wagner. I medici del popolo rifiutano la filosofia; chi dunque la vuole giustificare si compiaccia di mostrare per che cosa i popoli sani hanno e hanno avuto bisogno della filosofia. Forse, qualora costui riesca a mostrarlo, perfino i malati riusciranno a capire, con profitto, perché proprio per loro la filosofia sia dannosa. Ci sono invero validi esempi di una buona salute che può sussistere senza nessuna filosofia o con un uso moderatissimo, quasi giocoso di essa; così, i Romani vissero nel loro tempo migliore senza filosofia. Dove si troverà, per contro, un esempio della malattia di un popolo a cui la filosofia abbia restituito la salute perduta? Semmai la filosofia si è manifestata aiutando, salvando e proteggendo, ciò è accaduto coi sani; i malati, li ha resi sempre ancora più malati. Semmai un popolo è stato in disgregazione ed è stato legato ai suoi membri con un legame allentato, la filosofia non è mai riuscita a riannodare più strettamente questi individui al tutto. Semmai c’è stato qualcuno intenzionato a starsene in disparte e ad alzare intorno a sé la siepe dell’autosufficienza, la filosofia è stata sempre pronta a isolarlo ancora di più e, con l’isolamento, a soffocarlo. Essa è pericolosa, là dove non è nel suo pieno diritto, e solo la salute di un popolo, ma anche non di qualunque popolo, le dà questo diritto.
Guardiamoci ora attorno, per vedere se c’è un’autorità suprema per ciò che in un popolo si debba chiamare sano. I Greci, come il popolo veramente sano, hanno giustificato essi stessi una volta per tutte la filosofia col fatto stesso di filosofare, e di filosofare molto più di tutti gli altri popoli. Non seppero nemmeno smettere al momento giusto, giacché ancora nella rinsecchita vecchiaia si atteggiarono a ferventi adoratori della filosofia, sebbene intendessero con essa ormai soltanto il pio arzigogolare e il santissimo spaccare il capello in quattro della dogmatica cristiana. Per questo fatto, di non aver saputo fermarsi al momento giusto, essi hanno perfino diminuito di molto i loro meriti nei confronti della posterità barbara, perché questa, nell’insipienza e irruenza della sua giovinezza, era destinata a impigliarsi proprio in quelle reti e in quei lacci così artificiosamente tessuti.
Invece i Greci seppero cominciare al momento giusto, e questo insegnamento: quando si debba cominciare a filosofare, essi lo dànno con tanta chiarezza, come non lo dà nessun altro popolo. Cioè non nell’afflizione, come ritengono taluni che fanno derivare la filosofia dalla tetraggine; bensì nella felicità, nell’adolescenza matura, nel bel mezzo dell’infuocata serenità di una valorosa e vittoriosa età virile. Il fatto che i Greci abbiano filosofato in quel tempo ci ammaestra sia su ciò che la filosofia è e deve essere, sia sui Greci stessi. Se costoro fossero stati allora quegli uomini pratici e serenissimi prosaici e saccenti, quali ama immaginarseli il dotto filisteo dei nostri giorni, o se non avessero vissuto che in una gozzoviglia di ondeggiamenti e suoni, aneliti e passioni, come ama pensare il visionario sprovveduto, la scaturigine della filosofia non sarebbe affatto venuta in luce presso di loro; al massimo ci sarebbe stato un ruscello, che ben presto si sarebbe perduto nella sabbia o sarebbe evaporato nella nebbia, ma giammai ci sarebbe stato quel fiume largo, riversantesi in superbe ondate, che noi conosciamo come la filosofia greca.
Certo, ci si è dati da fare per stabilire quanto i Greci hanno potuto trovare e imparare nei paesi stranieri dell’Oriente e quante mai cose hanno preso da lì. Veramente si è assistito a uno spettacolo strano quando si sono chiamati insieme a convegno i presunti maestri dell’Oriente e i possibili discepoli della Grecia, esibendo Zoroastro accanto a Eraclito, gli Indiani accanto agli Eleati, gli Egizi accanto a Empedocle, o collocando addirittura Anassagora tra gli Ebrei e Pitagora tra i Cinesi. Di concreto è stato trovato ben poco; ma tutto questo architettamento, noi potremmo anche accettarlo, se soltanto non ci si importunasse sostenendo che dunque in Grecia la filosofia è stata semplicemente importata e non è cresciuta sul suolo nativo naturale, e che, in quanto cosa straniera, ha piuttosto rovinato che non fatto progredire i Greci. Niente sarebbe più stolto che attribuire ai Greci una cultura autoctona; al contrario, essi risucchiarono ogni cultura fiorente presso altri popoli; e fecero tanta strada proprio per aver saputo scagliare la lancia più lontano dal punto in cui essa era stata abbandonata da un altro popolo. I Greci sono ammirevoli nell’arte di imparare e mettere a frutto, e così come hanno fatto loro, anche noi dobbiamo imparare a fare dai nostri vicini, per la vita e non per la conoscenza erudita, sfruttando ogni cosa imparata come un appoggio su cui sollevarci e salire più in alto dei vicini. Le questioni sugli inizi della filosofia sono del tutto indifferenti, giacché dappertutto, all’inizio non c’è che rozzezza, mancanza di forma, vuoto e bruttura, e giacché in tutte le cose vengono in considerazione solo i gradi superiori. Chi, invece che della filosofia greca, preferisce occuparsi di quella egizia e persiana, perché queste sono forse «più originali» e in ogni caso più antiche, pecca della stessa sconsideratezza di coloro che, a proposito della mitologia greca, così splendida e profonda, non sanno darsi pace finché non siano riusciti a ricondurla a banalità fisiche, al sole, al fulmine, ai temporali e alla nebbia, come suoi primordi, e che per esempio, nella limitata adorazione di una stessa volta celeste, vaneggiano di aver ritrovato presso i bravi Indogermani una forma di religione più pura di quella politeistica dei Greci. La via che conduce alle origini conduce dappertutto alla barbarie; e chi si occupa dei Greci deve sempre tener presente che in ogni epoca la sfrenata sete di sapere porta di per sé alla barbarie, alla stessa stregua dell’odio del sapere, e che i Greci, per riguardo alla vita, per un bisogno ideale di vita, domarono la loro sete di sapere, in sé insaziabile – perché volevano vivere subito quello che imparavano. I Greci filosofarono anche come uomini di cultura e con le finalità della cultura, e perciò si risparmiarono di inventare ancora una volta, per una qualche spocchia autoctona, gli elementi della filosofia e della scienza; invece si applicarono subito a perfezionare potenziare elevare e purificare questi elementi ricevuti, in modo tale da divenirne allora gli inventori in un senso più alto e in una sfera più pura. Inventarono infatti i tipi delle menti filosofiche, e l’intera posterità non ha inventato più niente di essenziale da aggiungere a ciò.
Ogni popolo ha di che vergognarsi, quando si guarda a un gruppo di filosofi così mirabilmente idealizzato come quello dei più antichi maestri greci: Talete Anassimandro Eraclito Parmenide Anassagora Empedocle Democrito e Socrate. Tutti costoro sono uomini tutti d’un pezzo e scolpiti in un solo blocco di pietra. Tra il loro pensiero e il loro carattere corre una stretta necessità. In loro manca ogni convenzionalità, perché a quel tempo non c’era ancora una classe di filosofi e di dotti. Essi campeggiano tutti in maestosa solitudine, come quegli esseri unici che allora vivevano solo per la conoscenza. Possiedono tutti l’energia virtuosa degli antichi, per la quale superano tutti quelli che sono venuti in seguito, per trovare la loro propria forma e per continuare a svilupparla, per metamorfosi, fin nell’ultima finezza e grandezza. Nessuna moda, infatti, venne loro incontro per aiutarli e agevolarli. Così essi costituiscono tutti insieme quella che Schopenhauer ha chiamato la repubblica dei geniali, in antitesi alla repubblica dei dotti. Un gigante chiama l’altro attraverso i desolati intervalli delle epoche e l’alto colloquio degli spiriti continua, senza badare ai nani petulanti e strepitanti che strisciano sotto di loro.
Di questo alto colloquio degli spiriti, io mi sono proposto di raccontare soltanto quello che la nostra durezza d’orecchi moderna è forse in grado di sentire e di intendere, ossia certamente un minimo. Mi sembra però che in questo minimo quegli antichi sapienti, da Talete a Socrate, abbiano parlato, sia pure nella forma più generale, di tutto quanto costituisce, per il nostro modo di vedere, ciò che è tipicamente greco. Al loro colloquio, come già alle loro personalità, essi imprimono i grandi tratti del genio greco, di cui tutta la storia greca è una vaga impronta, una copia incerta, che perciò parla più indistintamente. Se noi interpretassimo rettamente tutta quanta la vita del popolo greco, vi troveremmo riflessa sempre e soltanto l’immagine che splende nei suoi geni supremi coi colori più smaglianti. Subito la prima esperienza della filosofia in terra greca, la sanzione dei sette sapienti,2 segna nell’immagine della grecità un lineamento chiaro e indimenticabile. Altri popoli hanno i santi, i Greci hanno i sapienti. A ragione è stato detto che un popolo non è caratterizzato tanto dai suoi grandi uomini quanto dalla maniera in cui li riconosce e li onora. Nelle altre epoche il filosofo è un viandante casuale e solitario che, in un ambiente quanto mai ostile, cerca di scivolar via furtivamente o di aprirsi un varco stringendo i pugni. Solo presso i Greci il filosofo non è casuale. Quando, nel sesto e nel quinto secolo, egli appare tra gli enormi pericoli e allettamenti della mondanizzazione e passa, per così dire, dalla caverna di Trofonio alla sontuosità, alla felicità delle scoperte, alla ricchezza e alla sensualità delle colonie greche, allora sentiamo che egli viene come un nobile ammonitore, per lo stesso scopo per cui nacque in quei secoli la tragedia, e che i misteri orfici fanno capire coi grotteschi geroglifici delle loro costumanze. Il giudizio di quei filosofi sulla vita e sull’esistenza in genere dice molto più di un giudizio moderno, perché essi avevano di fronte a sé la vita in una rigogliosa compiutezza e perché per essi il sentimento del pensatore non si confondeva, come per noi, nel dissidio tra il desiderio di libertà bellezza e grandezza di vita e l’impulso verso la verità che chiede soltanto: che valore ha la vita? Il compito che il filosofo è chiamato ad assolvere entro una vera civiltà, foggiata secondo uno stile unitario, non può essere chiaramente individuato in base alla nostra situazione e alle nostre esperienze, in quanto noi una tale civiltà non l’abbiamo. Solo una civiltà come quella greca può rispondere alla domanda circa questo compito del filosofo, essa soltanto può, come ho detto, giustificare in genere la filosofia, perché essa soltanto sa e può dimostrare perché e come il filosofo non sia un qualunque viandante casuale, sbalestrato ora da una parte ora dall’altra. C’è una ferrea necessità che incatena il filosofo a una vera civiltà. Ma come può avvenire ciò se questa civiltà non esiste? Allora il filosofo diventa una cometa dal corso imprevedibile, che perciò incute spavento, mentre nel caso favorevole risplende nel sistema solare della civiltà come un astro di prima grandezza. Perciò i Greci giustificano il filosofo, perché soltanto presso di loro egli non è una cometa.
2
Dopo tali considerazioni si accetterà senza difficoltà che io parli dei filosofi preplatonici come di un gruppo omogeneo e pensi di dedicare questo scritto esclusivamente a loro. Con Platone comincia qualcosa di completamente nuovo; o, come si può anche dire, con Platone viene a mancare ai filosofi qualcosa di essenziale, se paragonati alla suddetta repubblica dei geniali da Talete a Socrate. Chi volesse esprimersi sfavorevolmente su quei maestri più antichi, potrebbe chiamarli i filosofi unilaterali, e chiamare invece i loro epigoni, con Platone in testa, i filosofi multilaterali. Sarebbe comunque più giusto e più spregiudicato intendere questi ultimi come caratteri filosofici ibridi e i primi come tipi puri. Platone stesso è il primo grandioso carattere ibrido, che come tale è impresso sia nella sua filosofia sia nella sua personalità. Nella sua dottrina delle idee sono riuniti elementi socratici, pitagorici ed eraclitei. Per questo essa non è un fenomeno tipico, puro. Anche come uomo, Platone riunisce in sé i tratti di Eraclito, regalmente chiuso in sé e assolutamente autosufficiente, di Pitagora, legislatore melanconico e intriso di pietà, e di Socrate, dialettico scrutatore di anime. Tutti i filosofi posteriori sono siffatti caratteri ibridi; quando in loro si manifesta qualcosa di unilaterale, come per i cinici, non si tratta di un tipo, bensì di una caricatura. Ma ciò che è molto più importante è che costoro sono fondatori di sètte e che le sètte fondate da loro sono in complesso formazioni di contestazione della civiltà greca e della sua unità di stile. A loro modo essi cercano una liberazione, ma solo per i singoli individui o al massimo per i gruppi più vicini di amici e discepoli. L’attività dei filosofi più antichi mira invece, anche se essi non se ne rendono conto, a un risanamento e a una purificazione in blocco; il possente corso della civiltà greca non dev’essere fermato, la sua strada dev’essere sgombrata da terribili pericoli, il filosofo protegge e difende la sua patria. In seguito, da Platone in poi, è in esilio e cospira contro la patria. È una vera disgrazia che ci sia rimasto così poco di quei maestri e filosofi più antichi e ci sia stato sottratto ogni scritto integro. A causa di questa perdita, noi li giudichiamo involontariame...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- INTRODUZIONE
- LA VITA DI NIETZSCHE DAL 1869 AL 1873
- BIBLIOGRAFIA
- LA VISIONE DIONISIACA DEL MONDO
- LA FILOSOFIA NELL’EPOCA TRAGICA DEI GRECI
- SU VERITÀ E MENZOGNA IN SENSO EXTRAMORALE