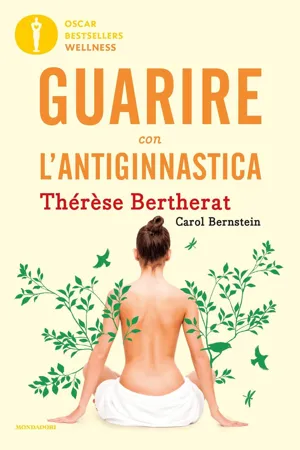È l’ora. Nella stanza di «lavoro», aspetto le prime allieve, saranno quattro. Il giorno prima avevo voluto vederle ognuna separatamente, per avere il tempo di guardarle, di cominciare a vederle e di ascoltarle. Le prime tre erano state sbrigative. La quarta, V., aveva parlato a lungo, instancabile.
Tono di voce irregolare: parole come un fuoco d’artificio che si smorzi bruscamente, per lasciare il posto a uno sguardo che fissa dietro ciglia che sbattono, poi riprende in una nuova esplosione di scintille. Un registro oscillante, imprevedibile: una voce piuttosto bassa, piacevole che, a metà di una frase e senza alcun rapporto col contenuto, sale, stride, si strozza, poi si riabbassa come se nulla fosse.
Non fa nessuno sforzo per controllare quello scatenamento vocale, sembra quasi non esserne consapevole. Mi racconta che, incoraggiata dal suo psicoanalista, un mio amico, ha accettato di assistere alla lezione. La parola dell’analista è sacra. Vengo a sapere che fa un lavoro interessante che però non la interessa, che il suo matrimonio va a rotoli, che il bambino che sperava di avere non arriva.
«E così mangio cioccolato» conclude. «Troppo cioccolato.»
Sono colpita di vederla così a suo agio nel raccontarmi i suoi disturbi, e mi vien fatto di pensare a un’attrice che faccia una prima lettura della sua parte, che non sia ancora «entrata» nel personaggio. Non so come risponderle. Ma lei, tutta presa dal suo monologo, non aspetta da me niente di simile. Già in piedi, mi dà la mano e poi sparisce rapidamente.
Dopo che se ne è andata, la sua voce, le sue voci, mi rimangono nelle orecchie, ma gli occhi non si ricordano di niente se non che era bruna: protetta da uno schermo di parole, era riuscita a nascondersi, a rendersi invisibile.
Con H., l’amica di un’amica, il colloquio è brevissimo. Alla domanda: «Perché vuole venire a lezione?» risponde con un leggero accento che non saprei definire: «Per far andare via la pancia». Ma non ha pancia, non ha grasso da nessuna parte. Un tempo indossatrice, ha gambe e collo lunghissimi, e straordinariamente rigidi. Non ne sembra affatto consapevole, come non sembra consapevole del portamento della testa, che sporge, quando si china, come quella di una tartaruga dal guscio. Con aria quasi disinvolta, mi fa un luminoso sorriso professionale e se ne va.
C., un’amica di vecchia data, si sforza di raccontarmi durante il nostro primo colloquio «ufficiale» i particolari di una grave caduta di quando era giovane, e di una operazione di ernia del disco di alcuni anni prima. Ne soffre ancora e non le piace parlarne.
N., una vicina di pianerottolo, viene a fare «un po’ di ginnastica» per curiosità e perché è comodo, ma sulla soglia mi confida che si era «dimenticata» di dirmi che a volte le faceva male la schiena e che si faceva manipolare le vertebre molte volte all’anno.
Dal momento che ho imparato a scuola l’importanza della patologia vertebrale, mi sembra evidente di dover dedicare la mia attenzione soprattutto all’amica C. e alla vicina N.
Ed ecco che arrivano tutte e quattro, con le brave calzemaglie tagliate all’estremità in modo da lasciar libero il piede, e un pullover in tinta unita, tutte meno V., che ha un pullover nero a righe bianche a zig zag. Dà noia agli occhi il suo pullover, ma sono soprattutto i suoi, di occhi, che sbattono. Viene avanti con circospezione nella stanza vuota.
«Ho le vertigini» dice.
Che la stanza sia troppo luminosa?
Dopo qualche stiramento, dico alle quattro allieve di stendersi per terra. V. manda un enorme sospiro di sollievo. Sdraiata, ritrova forse la sicurezza (relativa) del divano dell’analista?
Chiedo a ognuna di immaginare di scavare l’impronta del proprio corpo nel suolo. Il sollievo di V. finisce, ricomincia a sbattere le palpebre. Seccata, solleva una spalla, la batte, la schiaccia contro il suolo. Improvvisamente si mette seduta e stringe le dita del piede sinistro con tutte e due le mani.
«Ho un crampo!» Poi: «Ne ho spesso. Di notte. Mi sveglio. Che cosa vuole dire? Da che cosa dipende?».
Sembra meravigliata che io non lo sappia. Le altre allieve stanno in silenzio tutte comprese a «penetrare» nel suolo. La mia amica C. si è tolta gli occhiali, mi commuove vederla così, con gli occhi chiusi, e tutta concentrata.
Ma i guai di V. hanno il sopravvento. Prendendo spunto dalle sue dita pateticamente erette, ci sediamo per lavorare le articolazioni delle dita e del piede. Cerco di stabilire un ritmo lento, una progressione graduale dei movimenti, ma non riesco a resistere all’agitazione di V. e i movimenti si susseguono più rapidamente di quanto vorrei.
Nell’ultimo movimento, in cui si stende il dietro delle gambe come fa un gatto che si stiri arrotandosi le unghie, V. sembra finalmente trovare un po’ di pace. Ma appena finita la lezione dobbiamo sorbirci una vera e propria esplosione verbale. Veniamo a sapere fra l’altro che lei è al tempo stesso padrona e schiava di due gatte (l’immagine degli unghioli, dunque, le diceva qualcosa). Mentre tutte e quattro si vestono nella stanza vicina, sento ancora la voce di V. che sovrasta le altre e continua anche dietro la porta d’ingresso che si è richiusa alle sue spalle.
Ritrovandomi sola e in silenzio, ho l’impressione di aver sbagliato qualcosa, di essermi lasciata abbindolare. Io volevo concentrarmi su quelle che soffrivano «veramente», ed ecco che tutta la mia attenzione è stata captata da colei che non si era neppure lamentata di qualche dolore. E ancora una volta sono incapace di farmi un’idea precisa del suo corpo. Lo sguardo intenso fisso su di me come per intercettare il mio, il pullover a lampi accecanti, l’agitazione costante si sono aggiunti alla sua corazza verbale. Nel silenzio il suo corpo grida con i crampi, con lo sbattere delle palpebre. Quale verità non detta, sepolta da chissà quando, pensa che le si voglia strappare? Quale segreto difende con tanto accanimento?
Sono passate alcune ore e il modo con cui la lezione si è svolta mi tormenta ancora, come mi tormentano i dolori alle braccia, alle spalle, alle cosce. Le mie! Eppure ero sicura di essermi servita solo della voce. Immobile davanti alle allieve non avevo mai voltato loro le spalle. Come una madre che segua continuamente con lo sguardo i suoi bambini, per paura che si facciano male o che spunti, chissà da dove, un pericolo imprevisto. E se il mio lavoro fosse davvero pericoloso? Eppure so perfettamente che i movimenti non richiedono forza muscolare, non presentano alcun rischio per il corpo. Solo molto più tardi riuscirò a capire questa prima e ancora imprecisa impressione di essermi incamminata su un terreno pericoloso.
Mi preparo ad andare a letto di buonora, quando suona il telefono. Una donna mi dice che ha un dolorosissimo torcicollo. Non riconosco la voce e non sarei sorpresa che si trattasse della mia vicina N. Invece è H.
Arriva subito da me: sulla bella maschera di indossatrice, non c’è dolore, ma collera. Esaminandola, mi accorgo che i muscoli del collo e delle spalle sono tesi, e sono tesi anche i muscoli della schiena e delle gambe. Mentre lavoro per sciogliere i trapezi della nuca, molto contratti sulla destra, lei mi esorta a non risparmiarla, a fare quanto occorre perché sia in forma il giorno dopo. È assolutamente necessario. Perché? Perché deve alzarsi presto, deve fare la spesa, deve preparare il pasto, deve andare a prendere la figlia alla stazione.
«Era in vacanza?»
«No, vive con mia madre, ma l’ultimo sabato del mese deve venire da me, a lei non piace, piange perché non vuole, ma deve venire.»
«Ah.»
«Devo vederla.» Poi aggiunge: «Non creda che questo mi diverta». E aspetta la mia reazione.
Ma io sono tutta presa dai nodi della sua nuca.
Riattacca: «Quello che mi esaspera, soprattutto, è il dover fare la spesa, e poi cucinare».
«Le prepara i suoi piatti preferiti?»
«No di certo. Deve abituarsi a mangiare di tutto.»
Per un istante, immagino H. al mercato, mentre esita davanti alla merce esposta, preoccupata di scegliere quanto c’è di meno appetitoso.
«Può fare più forte» mi rassicura. «Domani, sa, devo…»
Devo. Deve. Questa giovane donna dalla vita apparentemente libera si sente dunque incatenata a tal punto dal dovere, da immobilizzare anche il suo corpo?
«Ha spesso il torcicollo?»
«No.» Poi: «Non so, non ci faccio caso. Sì, sì, ce l’ho, una volta al mese, direi, forse di più».
Tento di cambiare argomento dicendole che ha un piacevole accento che però non so riconoscere.
«Nessuno lo riconosce.» Lungo silenzio. Poi, senza che io le faccia altre domande, mi racconta che è nata in Austria, ma che è cresciuta in Argentina; «da austriaca», mi precisa.
Sua madre, ancora più di suo padre, le impose una ferrea disciplina: imparò a tuffarsi nell’acqua gelida, a camminare per ore e ore sotto il sole a picco, a dormire per terra, ad attraversare il vasto giardino di notte senza lanterna, a non dare importanza alle ferite, a non piangere mai.
«Non avevo paura di niente, neppure delle iene che ululavano nella notte.»
Non rimprovera niente a questo tipo di educazione, ne parla con fierezza mentre sento irrigidirmisi sotto le mani i muscoli che avevo appena sciolto.
«Solo i serpenti mi facevano paura e ce n’erano dappertutto.» Poi: «Mia figlia ha paura di tutto. Persino mia madre non può farci niente».
«Quanti anni ha?»
«Ne ha già cinque, credo che ormai non ci sia più rimedio.»
Cade in un profondo silenzio e anch’io taccio. Come spiegare a questa donna che la rigidità dei muscoli è indissolubile dalla rigidità di quell’educazione di cui va tanto fiera e che vorrebbe imporre anche alla figlia? Sostiene di esserne soddisfatta, ma il suo corpo protesta, frena davanti agli ostacoli che lei si sente in dovere di superare. Crede di amarsi, l’unica cosa che non le piace del suo corpo è un ventre che non esiste. Come farle capire che non si ama e che non potrà amarsi, né quindi amare sua figlia, se non diventerà cosciente del suo corpo imbavagliato anziché continuare a reprimerlo e a contrariarlo?
Anche se questo discorso potesse, a rigore, venire capito e accettato intellettualmente da H., non cambierebbe nulla. Il mio lavoro deve limitarsi ad aiutarla a riconoscere la rigidità del suo corpo. Accetta di venire regolarmente a lezione.
Il torcicollo ritorna spesso nel corso del primo anno, ma mai con la violenza della prima volta. Nei mesi di lavoro fatto con lei mi è sembrato a volte che la maschera di sfida lasciasse il posto a un atteggiamento d’introspezione, a un vero turbamento.
Non facevo domande, ma spesso guardandola pensavo alla frase di Wilhelm Reich: «Ogni irrigidimento muscolare contiene la storia e il significato della sua origine. Eliminarlo non solo libera energia… ma fa riaffiorare alla memoria la situazione infantile in cui si è verificata la rimozione».1 Del resto, il pericolo che sentivo al momento della mia prima lezione non sarebbe forse riaffiorato alla memoria?
Fin dalle mie prime esperienze professionali, e attraverso anni di lavoro, ho constatato che ogni nuovo allievo ha del suo corpo una conoscenza parziale, frammentaria.
«La mano destra non sappia quello che fa la sinistra» si dice. Ora, in pratica, la dissociazione non solo degli arti, ma di tutte le parti del corpo, è comune e considerata come normale. Non sappiamo che rapporto abbiano tra di loro le varie parti del corpo, e non sappiamo neppure come siano organizzate e quali siano le loro funzioni e le loro vere possibilità.
Acquistiamo prestissimo un repertorio minimo di gesti a cui non pensiamo più. Per tutta la vita ripetiamo quei pochi movimenti senza mai riesaminarli, senza capire che rappresentano solo un esiguo campionario delle nostre possibilità. Come se avessimo imparato solo le prime lettere dell’alfabeto e ci accontentassimo delle poche parole che possiamo comporre con loro. In questo caso non solo il nostro vocabolario sarebbe ridotto, ma anche la nostra capacità di pensare, di ragionare, di creare. Quando un individuo si serve solo di un centinaio di parole della sua lingua, si dice che è un ritardato mentale. Ora, moltissimi di noi adoperano soltanto alcune variazioni di un centinaio fra i duemila movimenti (almeno) di cui l’essere umano è capace. Ma non prenderemmo mai sul serio chi asserisse che siamo dei ritardati motori…
Non ci sentiamo in rapporto col nostro corpo, forse proprio perché non sentiamo il rapporto delle varie parti del corpo tra di loro. In quanto poi al rapporto tra testa e corpo, spesso c’è una separazione totale. E proprio qui nasce il pregiudizio della separazione dei poteri fisici e psichici. Per molti di noi la testa è la testa, e il corpo il corpo. E poi il corpo è soprattutto il tronco che ha quattro arti che gli stanno attaccati non si sa bene come. Non siamo pienamente consapevoli che la nostra testa sia legata alla colonna vertebrale come lo sono braccia e gambe. Testa e arti non fanno corpo? Sono forse soltanto delle appendici?
Così ignoriamo che potremmo aumentare le nostre capacità intellettuali se scoprissimo come ci orientiamo nello spazio, come organizziamo i movimenti del corpo. Non ci viene neppure in mente che, aumentando la velocità e la precisione degli stimoli nervosi tra cervello e muscoli, miglioriamo anche il funzionamento del cervello.
E non troviamo neppure un nesso tra corpo e testa, in quanto centro «metaforico» delle emozioni e dei ricordi. Ammettiamo che occorre tempo e maturità per sapere «che cosa succede nella testa», passiamo tutta la vita a porci domande su questo argomento. Ma il nostro corpo – che è altrettanto misterioso, che è altrettanto «noi stessi», che è di fatto indissociabile dalla testa – è solo oggetto di domande superficiali e mal poste.
La rigidità del corpo, le restrizioni che ci impone, le sentiamo fino a provarne disagio e a volte persino sofferenza, solo che ci è praticamente impossibile analizzarci e conoscere le cause reali di questo disagio. L’origine viene nascosta da un particolare che attira tutta l’attenzione: un ventre sporgente, una spalla più alta dell’altra, un alluce che fa male… oppure ci sentiamo «nervosi», insonni, digeriamo male. A volte un solo albero ci nasconde la foresta.
Così il desiderio profondo della persona che viene a «fare ginnastica» corrisponde di rado alla domanda espressa. Esaminiamo le domande più ricorrenti: eliminare la pancia; «esercitarsi», dato che la vita sedentaria è malsana; essere in forma per le vacanze.
Eliminare la pancia
Tutti hanno la fissazione della pancia, perché vedono solo lei. Alla lettera. Gli occhi umani sono situati in modo che lo sguardo sia rivolto davanti a sé e sul davanti del corpo. Appena il ventre è un po’ sporgente si ved...