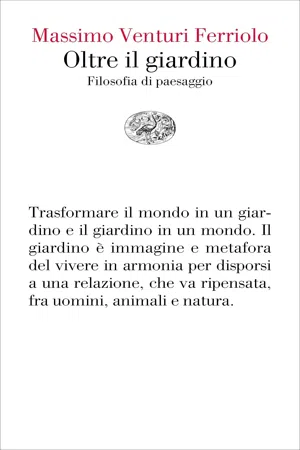Inizia ora il percorso postcartesiano del desiderio sconfinato di ricongiungersi alla natura per ritornare all’antico dialogo ormai estinto. Tra le figure che oltrepassano la finitezza per diluirsi nell’infinito, il «giardino romantico» indica uno stile di arte dei giardini con i segni della storia, con le tracce dei sentimenti, con gli effetti pittoreschi, con la bramosia della natura selvaggia. Questo luogo è nato con la diffusione del giardino paesaggistico, informale copia della natura. Lo sguardo dello spettatore scopre, grazie all’abbattimento di ogni barriera visiva, l’assenza del limite e rivitalizza la natura con il sentimento, con una commozione provocata piú dalla sua idea che dalla realtà.
L’assenza del limite non è solo un accorgimento creato dalle artificiali forme nascoste, ma si trasforma via via in un’aspirazione mentale legata all’immagine di spazi sempre piú affascinanti e sorprendenti. L’inventiva vuole superare un gioco basato sulla vista della semplice riproduzione del paesaggio, divenuto il moderno sostituto della natura.
Il modello inglese diventa una moda e si trasforma in giardino anglo-cinese, sentimentale, pittoresco, una voga ben rappresentata da Goethe nel Trionfo del sentimentalismo con gli eccessi sentimentali del principe Oronaro, con la natura da viaggio come bagaglio appresso da distribuirsi tra camere e giardini ovunque si reca. Contro questa moda, distruttrice dei preesistenti modelli di stile geometrico, come gli Horti Palatini di Heidelberg, si rivolge la nuova visione del mondo che guarda all’antichità, tanto desiderata dal poeta e sua nostalgia, delineando un duplice luogo ambiguo. Questo parte da Omero e giunge fino al mondo germanico del XVIII secolo, attraverso un percorso che da Shaftesbury, per Rousseau, Girardin, Kant, Schiller e Goethe, arriva al Phantasus di Ludwig Tieck e al cuore del mondo di Joseph von Eichendorff, cioè al poeta che, unico, sa riproporre l’antico giardino procedendo verso l’infinito e guardando indietro alla ricerca della Natura, idilliaca realtà passata, dove uomini, piante e animali dialogavano fra loro, che rifiorirà con la sua arte. Provvisto di una visione mitica dell’antico, il poeta osserva fin dove lo porta la fantasia. Aspira all’universale compimento di una Natura ormai ideale, non piú in sintonia con l’uomo, simbolo del passato lontano di un’unità inscindibile e realmente estetica, trasformato nell’infinito poetico, rivolto al futuro, al tempo di un’unica bellezza, quando uomo e natura si fonderanno in una sola entità divina, e il futuro diventerà passato mentre l’ideale tornerà Natura.
Indietro, dove guarda l’immaginazione, si estendono paesaggi e giardini, antiche pergamene con incisi i luoghi d’incontro tra desiderio e realtà. Il giardino diventa vita interiore, segno e sogno di un’età dell’oro indelebile, cantata dalle Esperidi con voce soave, eco di un suono non ancora spento. Appartiene solo al poeta, alle sue emozioni e ai suoi sentimenti: è del tutto soggettivo e non rappresentazione reale di un oggetto.
I luoghi dei Romantici esprimono un desiderio giunto da lontano, cresciuto nello spirito ed espresso senza limiti, fantasia pura e acuta malattia del ritorno a un’unità perduta. Non costituiscono un modello concreto, tantomeno da riprodurre. Nessun impianto esiste con le sue reali architetture. Le emozioni e i sentimenti non sono riproducibili: non sono maniera, ma possesso interiore. Il pozzo profondo dello spirito si riflette qui, tra giardini e paesaggi, e quando, nella sua infinita e ideale ricerca della Natura, lo spirito toglie il velo adagiato su di lei, rivela se stesso nelle proprie multiformi manifestazioni.
Gli antichi hanno trasmesso il desiderio di trasformare lo stato selvaggio per modellare una natura piú nobile, coltivando fiori e erbe, combinando tra di loro boschi, prati, fonti e rupi per renderli giardini ameni. Ai loro tempi, la natura era piú animata e sensibile. I poeti greci sapevano cogliere la vita segreta dei boschi evocando fiorenti giardini. I discepoli di Sais di Novalis trasmettono questa magica nostalgia chiamata dolce struggimento, portando con sé il fertile ardore estatico della fantasia: «piú larghe e rigogliose diventavano le foglie, sempre piú rumorosi e allegri gli uccelli e gli animali, piú gustosi i frutti, piú intenso l’azzurro del cielo, piú calda l’aria, piú ardente il suo amore»1, amore come legame tra il tu e l’io, profondo ineffabile artefice del vincolo tra soggetto e oggetto.
L’amore è il bene, coincidenza di felicità e virtú, godimento della bellezza, dove confluiscono l’estetica come grazia e la metafisica quale armonia, bellezza assoluta che si riflette con contrasti e limitazioni nelle piacevolezze del mondo. Il suo possesso è l’unica felicità raggiungibile dall’uomo e s’identifica nell’amore come unità del molteplice, identità del diverso, infinitizzazione del finito, cioè l’armonia assoluta della natura, che si apre e manifesta il suo splendido cuore solo in compagnia del poeta, perché egli è il suo vero amico e interprete. Solo lui incide giardini su antiche pergamene, vere creazioni dello spirito teso all’infinito, giardini possibili grazie alla poesia. La natura rivela la sua anima unicamente al poeta che in lei ricerca la beatitudine dell’età dell’oro.
L’uomo quando guarda le onde di un fiume con un certo spirito diventa egli stesso l’oggetto della sua osservazione. Senza lo spirito del Romantico, la natura è in sé soltanto la vita spontanea, l’eterno fluire delle cose. Per comprenderla, bisogna che sia un autoconcepimento interiore.
I giardini sono prodotti alti dello spirito venuto dall’ultimo poeta mediterraneo. Omero ha descritto Ogigia da ingenuo cantore. L’isola di Calipso diventa il modello secolare, la lontana traccia di un’originaria divina selvatichezza inclusiva dell’uomo, spazio nostalgico del nostro essere stati Natura, sua parte integrante e non divisa, per arrivare al sentimento, superarlo e svelare l’approdo all’isola felice, ideale ritorno, fantasia nuova dal tempo incerto perché non sappiamo quanto occorre per comprendere i misteri della Natura.
Le prime tonalità spirituali dell’indefinibile sensazione del non so che sono un torrente romanzesco che inonda l’Europa del Settecento, sgorgando dalla sensibilità per la natura intatta con il suo bel disordine amato in Inghilterra da Shaftesbury e in Francia da Marivaux, che confluirà nella Romantik con le sue immagini del sublime, del pittoresco e del romanzesco.
Il mondo si rivela e si comprende con le poetiche del giardino governate dall’idea di natura, ma l’ideale ha rappresentato, e rappresenta, per i moderni ciò che è stato natura. La sua immagine antica viene colta con nostalgia dal poeta, quando svela ogni giardino nella sua individualità complessa di modello irripetibile.
Un fiore, una fontana, una pietra ricoperta di muschio, il cinguettio degli uccelli sono oggetti che non amiamo di per sé ma per l’idea rappresentata: sono «ciò che eravamo, sono ciò che noi dobbiamo tornare a essere. Come loro noi eravamo natura, e ad essa la nostra cultura deve ricondurci attraverso la via della ragione e della libertà»2.
Forte della sua immaginazione il poeta crea il giardino. Lo sostiene Kant quando definisce l’arte dei giardini, in un passo dove confluisce il dibattito precedente aprendo la prospettiva dei Romantici, dopo aver esposto la relazione tra giardino, memoria, gioco dell’immaginazione e il significato pieno del libero gioco dell’immaginazione nella contemplazione. L’arte dei giardini è arte del genio, il cui carattere è l’originalità del talento e si oppone allo spirito d’imitazione: è rappresentazione bella, azione creatrice. Lo spirito desidera tornare alla propria fonte e scorge, con la sua intelligenza, gli archetipi della forma e dell’ordine, quindi anche il giardino. La bellezza è in noi, legata al libero gioco tra immaginazione e intelletto. L’arte dei giardini come arte bella esprime idee mediante figure nello spazio, sfuggendo cosí a ogni rigido formalismo. La strada alla poetica del giardino è aperta e lo è da un filosofo di peso.
L’ingegno crea una rappresentazione ricca di pensieri. Questi arricchiscono l’immaginazione, che è un altro nome dello stesso ingegno in quanto creare e conoscere. Sviluppa infinite forme di giardino dalla figura della natura. La poesia compone giardini con le parole degli elementi naturali. L’immaginazione supera la scissione uomo-natura, vivificando l’assenza e abbandonandosi del tutto alla dolcezza di un sentimento profondo.
Lo spirito libero apre una varietà di forme pari agli occhi che osservano, innalza anche una fiaba alla superiore verità artistica, seguendo una necessità interiore. Matura una sottile filosofia del soggetto e della sua fantasia creatrice. La poesia non imita ma amplia e rende infinita l’immagine della nostra interiorità, grazie all’esperienza estetica della natura. L’imitazione non è immaginazione. La copia non può contener nulla di piú dell’originale: solo questo possiede qualità drammatiche e dipinge i nostri sentimenti o quelli estranei.
Il poeta, spirito creatore, amplia e rende infinita l’immagine nella nostra interiorità, grazie all’esperienza estetica della natura, al suo carattere soggettivo e non oggettivo, con la conseguente spiritualità individuale insita nel giardino: uno stato d’animo, una poetica nella quale e della quale vive il Romantico, rivelando anche l’anima della Natura.
Il giardino è quindi poetica vissuta tramite la contemplazione, esperienza priva di un criterio oggettivo della bellezza ma soggettivo, considerato perciò universale, differente dalle altre espressioni artistiche e sentimentali. L’immaginazione lo crea trasformando l’informe della natura, processo spirituale della contemplazione come sua realtà. L’informe ha un animo e modifica il contemplatore che, a sua volta, muta con l’osservazione. Lo stato d’animo della natura coinvolge lo spirito. Il suo essere nel giardino, quindi diventarlo, è parte dello spirito. Questa condizione è altro dall’imitazione. Il poeta deve rivelare i misteri imperscrutabili della natura attraverso alberi, piante, fiori, monti e acque. La poesia conferisce all’umanità la piú completa espressione possibile, eleva la realtà all’ideale e al passato per proiettarlo nel futuro.
Si apre una visione piú ricca e completa della natura con la nostalgia, acuta malattia del ritorno. La differenza tra la rappresentazione classica dell’antico nel giardino paesaggistico e quella dei Romantici è tra un mondo in rovina e un passato immaginato di una storia restituita alla natura. Imitazione e immaginazione sono due modi opposti d’intenderla. La grande critica di fine secolo coinvolge l’imitazione. Si esalta l’immaginazione produttrice e creatrice di una nuova realtà in contrasto con quella riproduttrice, che è solo reminiscenza del vissuto e del percepito, come tale finita e non illimitata.
L’effetto romanzesco si contrappone all’aspirazione romantica; infatti descrive una scena che colpisce l’occhio, suscita ammirazione e riflette i sentimenti. Il Romantico va oltre: dalla descrizione della scena, dalla particolare emozione suscitata in chi la contempla, passa all’immaginazione nella contemplazione che svela le figure e le forme della bramosia del bel tempo antico espressa per rivelare un passato proiettato nel futuro. Si manifesta un modo di sentire che, come ha scritto Baudelaire, non troviamo precisamente nella scelta dei soggetti, né nella verità esatta, ma nel modo di sentire.
Lo spirito dell’antico è oggetto di desiderio, il fondamento del ritorno alla natura, nostra madre e matrice. L’immaginazione offre lo sfondo di un paradiso dell’ingenuità e dell’innocenza, mondo poetico della nostalgia:
Tutti i popoli apparsi nella storia hanno un paradiso, uno stato d’innocenza, un’età dell’oro; anzi, ogni singolo uomo ha il suo paradiso, la sua età aurea, che ricorda con maggiore o minore entusiasmo, a seconda che nella sua natura sia piú o meno presente l’elemento poetico. L’esperienza stessa offre dunque tratti sufficienti per il quadro che l’idillio pastorale presenta. Questo è dunque in ogni caso una finzione bella e nobilitante, e la poesia, rappresentandola, ha realmente agito in favore dell’ideale3.
La poesia sentimentale, in contrapposizione a quella ingenua degli antichi, dà al poeta moderno la facoltà di superarli nella ricchezza della materia, nello spirito con la forza del gioco dell’immaginazione al quale Kant aveva dedicato pagine ricche di sviluppi teorici. Dallo stato di natura a quello di civiltà corrispondono i due generi di poesia: l’essere e la rappresentazione. Gli antichi, poeti ingenui, sono natura. I moderni, sentimentali, cercano la natura, la rappresentano con nostalgia: l’uomo moderno è uscito nella natura, la cerca e la trova nel paesaggio. I Romantici si pongono in questo contesto con una loro peculiarità, determinante per l’estetica moderna grazie alla lunga ombra, non ancora esaurita, dell’immaginazione.
La poesia conferisce all’umanità la piú completa espressione possibile in due modi diversi, caratterizzati dall’ingenuo e dal sentimentale, vale a dire dalla natura e dalla cultura. L’imitazione piú perfetta e possibile del reale è poesia allo stato di semplicità naturale; allo stato della cultura, invece, il poeta cerca di elevare la realtà all’ideale o alla sua rappresentazione. La differenza tra imitazione e rappresentazione è fondamentale nella critica delle forme dell’arte dei giardini. I poeti antichi si commuovono in virtú della natura, i moderni invece grazie alle idee. Gli antichi sentivano in modo naturale mentre i moderni sentono il naturale, aggettivo dal significato sempre piú distante dalla natura. Nasce cosí lo spirito della ricongiunzione.
Il giardino romantico ha assunto cosí tanti significati da non averne uno preciso. Possiamo sentirci romantici e vedere un giardino. Il poeta ha una visione infinita: è il cuore del mondo di Joseph von Eichendorff. Le Affinità elettive di Goethe mostrano l’atteggiamento sospeso dei Romantici nei confronti delle due forme classiche del giardino, la regolare e l’inglese, che mostrano lo spirito del tempo. Quando il capitano è sopra la collina e vede i due diversi giardini, esprime in un certo modo il suo tempo. Goethe è molto critico: tutti si dilettano a scopiazzare giardini francesi o inglesi senza avere o apporre idee chiare distintive, senza avere un chiaro fine progettuale e senza rendersi conto a cosa può portare questa mancanza di originalità. Le parole del capitano sono significative nel nuovo contesto natura-arte; colgono la mancanza di un...