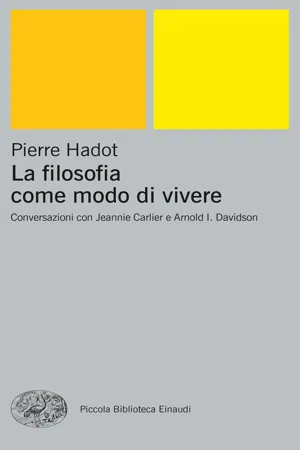
eBook - ePub
La filosofia come modo di vivere
Conversazioni con Jeannie Carlier e Arnold I. Davidson
- 304 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La filosofia come modo di vivere
Conversazioni con Jeannie Carlier e Arnold I. Davidson
Informazioni su questo libro
Pierre Hadot è solo un ragazzo quando il cielo stellato gli regala un'esperienza indimenticabile, in cui piú tardi riconosce ciò che Romain Rolland chiama il «sentimento oceanico». «Credo di essere filosofo a partire da quel momento», dice una sessantina d'anni dopo. Che cos'è filosofare? Per Hadot la filosofia è un'esperienza vissuta. I discorsi filosofici degli antichi sono «esercizi spirituali» che non mirano a informare, ma a formare e a trasformare noi stessi. E se filosofare vuol dire «esercitarsi a morire», esercitarsi a morire vuol dire esercitarsi a vivere con piena lucidità, staccarsi dal proprio io per aprirsi a una prospettiva universale - l'itinerario della saggezza.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a La filosofia come modo di vivere di Pierre Hadot, Anna Chiara Peduzzi, Laura Cremonesi, Anna Chiara Peduzzi,Laura Cremonesi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Philosophy e Philosophy History & Theory. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Appendice
Che cos’è l’etica?
Conversazione con Pierre Hadota
Pierre Hadot, lei è un grande specialista di filosofia antica e, tra l’altro, è autore di Che cos’è la filosofia antica?1. Ha appena pubblicato un’edizione del Manuale di Epitteto2, ma ha anche scritto, ad esempio, su Montaigne, Kierkegaard, Thoreau, Foucault, Wittgenstein. Possiamo dire che il suo interesse per pensatori cosí diversi è di ordine etico? E in quale senso di «etico»?
Quando sento il termine «etico» rimango un po’ perplesso, perché il termine «etico» implica una valutazione sul bene e sul male delle azioni, delle persone o delle cose. Il mio interesse per tutti questi autori forse non è propriamente «etico». Direi che si tratta piuttosto di un interesse esistenziale. In Wittgenstein, per esempio, tenuto conto della mentalità con cui lo leggevo nel 1959, mi ha interessato soprattutto la mistica, o meglio, quello che per me era positivismo mistico. Era quasi una contraddizione in termini: perché Wittgenstein aveva osato parlare di mistica? In Wittgenstein, la fine del Tractatus era per me particolarmente sorprendente. Si tratta, secondo la mia interpretazione, che credo non sia troppo falsa, di una «saggezza silenziosa». Questa era anche una formula che avevo letto nel libro di Elizabeth Anscombe, la quale diceva, a proposito di Wittgenstein, che per lui la cosa piú importante era lo stupore davanti al mondo. Tutto questo non è poi cosí «etico».
In generale, io non sono un grande moralista e temo che il termine «etico» sia troppo ristretto, a meno che non lo si intenda nel senso dell’etica di Spinoza. Dopotutto, Spinoza ha intitolato Etica un libro di metafisica. Bisognerebbe quindi prendere il termine «etica» in senso molto ampio.
A questo senso particolare del termine «etica», che lei rivendica, attribuisce a volte il nome di «perfezionismo», una forma di filosofia morale un po’ trascurata dalla filosofia contemporanea. Sarebbe l’idea di ricerca dell’io migliore, l’idea del perfezionamento di sé, che trova la sua fonte in Platone e che compare, come la sua opera ha mostrato, nell’insieme della filosofia antica. La possiamo ritrovare anche in pensatori piú contemporanei come, ad esempio, nel filosofo americano Emerson, o in Nietzsche. Questo perfezionismo – che lei lega anche all’idea di esercizio spirituale – potrebbe essere definito dopo il periodo storico degli esercizi spirituali? In breve, questa etica può avere una pertinenza piú moderna?
Sí, la nozione di perfezionismo può essere considerata da un lato una forma di etica e, dall’altro, ha il vantaggio di implicare ogni genere di nozione che non sia propriamente etica. In definitiva è una formula comoda che corrisponde, inoltre, a una tradizione che risale a Platone. Alla fine del Timeo, Platone parla della parte migliore di noi, che bisogna mettere in accordo con l’armonia del tutto. D’altronde sono stato colpito, in particolare commentando il Manuale di Epitteto, nel constatare come la nozione di «andare verso il meglio», di «volgersi verso il meglio», che compariva piú volte, fosse praticamente equivalente alla nozione di filosofia, sia in Epitteto stesso, sia in un cinico dell’epoca di Luciano. Si tratta di colui a proposito del quale Luciano di Samosata, il famoso satirico del II secolo d. C., dice, appunto: «Demonatte si volse verso il meglio», il che significa che si convertí alla filosofia. È la stessa idea che troviamo alla fine del Timeo di Platone: la parte migliore si mette in armonia con il tutto, con il mondo.
Questo ci riconduce al problema dell’etica e della sua definizione. Nella prospettiva di quello che lei ha appena chiamato perfezionismo, potremmo dire che l’etica è la ricerca di uno stato o di un livello superiore dell’io. Non è, quindi, solo una questione di morale. Nell’antichità – come sono stato portato a dire in particolare per gli stoici, ma credo che in fondo lo si possa dire per ogni filosofia – ci sono tre parti della filosofia: la logica, la fisica e l’etica. In realtà, ci sono una logica teorica, una fisica teorica, un’etica teorica e poi ci sono una logica vissuta, una fisica vissuta, un’etica vissuta. La logica vissuta consiste nel criticare le rappresentazioni, cioè, semplicemente, nel non lasciarsi fuorviare nella vita quotidiana da falsi giudizi, in particolar modo riguardo ai giudizi di valore. Tutto il lavoro di Epitteto consiste, appunto, nel tentare di portare il discepolo a prendere coscienza del fatto che bisogna, prima di tutto, attenersi alle cose tali quali sono, cioè a una rappresentazione oggettiva, cosa che evita di aggiungere immediatamente giudizi di valore di fronte agli eventi, per quanto gravi essi siano. La logica vissuta consiste in questo. Troviamo molto spesso della fisica vissuta in Marco Aurelio, ma anche in Epitteto. Si tratta della presa di coscienza del destino, per la filosofia stoica, oppure della presa di coscienza delle realtà fisiche, per gli epicurei. Secondo questi ultimi, per poterci rendere conto che possiamo vivere senza avere paura degli dèi, poiché gli dèi non hanno creato il mondo, dobbiamo applicare la fisica al nostro comportamento di tutti i giorni. Per quanto riguarda l’etica vissuta, si tratta evidentemente di non accontentarsi di un’etica teorica, ma di praticarla. Per gli stoici, si tratta soprattutto di quelli che essi chiamano i doveri, cioè gli obblighi della vita di tutti i giorni. Si tratta, quindi, di esercizi spirituali, o di quelli che io chiamo esercizi spirituali, cioè pratiche destinate a trasformare l’io e a fargli raggiungere un livello superiore e una prospettiva universale, in particolar modo grazie alla fisica, alla coscienza del rapporto con il mondo, o grazie alla coscienza del rapporto con l’umanità nel suo insieme, cosa che comporta il dovere di tenere conto del bene comune.
Tutto questo può avere dunque un senso, attualmente? Credo che queste pratiche conoscano una continuità e al tempo stesso una discontinuità. Questi esercizi spirituali ricompaiono sempre nel corso del secoli. Li ritroviamo, ad esempio, nel Medioevo, integrati però nella vita cristiana, perché i cristiani hanno ripreso molti esercizi spirituali, come ad esempio l’esame di coscienza, la meditazione della morte (tra l’altro deformandola, in una certa misura), ecc. D’altra parte, li ritroviamo anche, ad esempio, in Cartesio (almeno nelle Meditazioni, per fare uno degli esempi piú chiari), nello scrittore inglese Shaftesbury (che ha scritto degli Esercizi – semplicemente – proprio alla maniera di Epitteto e di Marco Aurelio), in Goethe (tra l’altro in certi poemi), in Emerson, in Thoreau e in Bergson. In tutti questi casi c’è perfezionismo, perché si tratta proprio di un movimento verso un io superiore. È molto chiaro in Bergson, perché egli oppone sempre le abitudini che smussano la nostra percezione (quelle, cioè, che fan sí che le nostre decisioni non siano vere decisioni, ma risposte quasi meccaniche a situazioni abituali) alla coscienza chiara di un io (egli usa l’immagine inversa) piú profondo. Anche in questo caso si tratta di perfezionismo. Del resto, potremmo ritrovare questo perfezionismo anche in Heidegger, nella misura in cui egli oppone il «si», che è l’io del tutto sprofondato nelle abitudini meccaniche e nei riflessi automatici, all’esistenza autentica, che è un’esistenza che non ha paura dell’angoscia e che quindi suppone uno stato superiore dell’io. In questa prospettiva, il perfezionismo è molto attuale.
Nel suo libro su Marco Aurelio, La cittadella interiore3, ha voluto modificare una lettura tradizionale, che presenta Marco Aurelio come un pessimista disgustato dalla vita quotidiana, e ha messo in evidenza quello che egli ci insegna della bellezza della vita, la meraviglia di fronte al mondo di cui ha appena parlato. In questa prospettiva, l’esercizio filosofico non è piú lo sradicamento dalla vita quotidiana che ha definito negli esercizi spirituali, ma può compiersi nella vita quotidiana, attraverso la comprensione stessa di cosa il quotidiano sia. Si pone quindi un problema: quello dell’ambiguità di questa idea del quotidiano, dato che, secondo lei, bisogna poter accettare l’ordinario, ma anche strapparsene. Come risolve questa dualità? Penso qui a quello che dice il filosofo americano Stanley Cavell 4 a proposito dell’esistenza di due generi di quotidiano. Il primo comporta le abitudini di cui parlava poco fa e di cui bisogna liberarsi. Il secondo, che è una trasformazione del primo, sarebbe una sorta di «seconda ingenuità». Nella sua lettura di Marco Aurelio c’è la stessa dualità del quotidiano da superare e del quotidiano da raggiungere?
Sí. Questo corrisponde del resto proprio a un’interrogazione personale. Avevo pensato, alla fine di Che cos’è la filosofia antica?, di definire la filosofia come trasfigurazione del quotidiano. Lei ha perfettamente ragione a chiedere quale sia la situazione di questo quotidiano, cioè se il filosofo debba strapparsi dal quotidiano o, al contrario, trasfigurarlo. C’è senz’altro una rottura con il quotidiano. In Marco Aurelio, ad esempio, troviamo questo sforzo per evitare di avere le rappresentazioni o i giudizi che sono abituali nella vita quotidiana. A un uomo in estasi di fronte alle pietanze servite a tavola, risponde che non sono altro che cadaveri di pesce o di animale. Di fronte alla propria porpora, dice a se stesso che è solo sangue d’animale quello di cui la stoffa è imbevuta. E, per quanto riguarda i piaceri sessuali, che nel quotidiano vengono considerati come qualcosa di straordinario, dice che sono uno sfregamento di ventri, ed ecco... produce definizioni che ricollocano le realtà quotidiane nel mondo o nel cosmo, dà definizioni fisiche di queste realtà. Come lei diceva a proposito di Stanley Cavell, c’è una rottura con il quotidiano, nella misura in cui esso consiste in giudizi o in comportamenti nei quali il vero io non si mette in gioco, ma è dominato dalle abitudini e dai pregiudizi.
Nonostante la filosofia sia una rottura con questo quotidiano, ne rimane tuttavia inseparabile. Ho sempre amato il brano di Plutarco, nel suo trattato Se un anziano possa fare politica, in cui parla di Socrate, e dice che non è stato filosofo per avere insegnato da una cattedra e sviluppato delle tesi, ma per aver scherzato, bevuto, fatto la guerra, essere andato all’agorà e, soprattutto, per aver bevuto la cicuta. Socrate ha dimostrato cosí che in ogni momento, qualsiasi cosa ci accada o qualsiasi cosa facciamo, la vita quotidiana è inseparabile dalla possibilità di filosofare. Credo che questo corrisponda abbastanza alle concezioni di Cavell: non c’è separazione tra il quotidiano e la filosofia. La filosofia non è un’attività riservata a un contemplativo che resta chiuso nel suo studio e che cessa appena egli ne esce o appena finisce di fare lezione. Si tratta invece di un’attività assolutamente quotidiana.
Lei ha notato, sempre a proposito di Marco Aurelio, che l’esercizio spirituale è anche esercizio di linguaggio. Si è sempre interessato ai problemi di linguaggio e parla, a proposito di Epitteto e di Marco Aurelio, di «esercizi di scrittura sempre rinnovati, sempre ripresi». Qual è il ruolo della scrittura e del linguaggio nella trasformazione di sé operata dall’etica?
Ci sono due generi di discorso. Lo dicevano gli stoici, ma è una questione di buon se...
Indice dei contenuti
- Copertina
- La filosofia come modo di vivere
- Introduzione di Jeanny Carlier
- Nota all’edizione italiana
- La filosofia come modo di vivere
- Tra le sottane della Chiesa
- Ricercatore, docente, filosofo
- Il discorso filosofico
- Interpretazione, obiettività e fraintendimenti
- Esperienza unitiva e vita filosofica
- Il discorso filosofico come esercizio spirituale
- La filosofia come vita e come ricerca della saggezza
- Da Socrate a Foucault. Una lunga tradizione
- Inaccettabile?
- Solo il presente è la nostra felicità
- Nota conclusiva
- Appendice
- Indice dei nomi
- Il libro
- L’autore
- Dello stesso autore
- Copyright