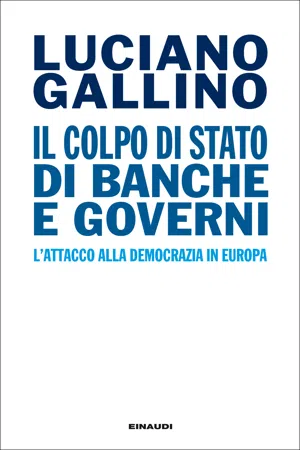![]()
![]()
1. L’accumulazione del capitale: da una crisi all’altra.
Le origini strutturali della crisi risalgono al regime di accumulazione del capitale che si è andato affermando nei Paesi sviluppati a partire dagli anni Ottanta. Esso è contraddistinto dal predominio acquisito dal sistema finanziario sull’intera economia. Tale regime si è affermato come risposta alla crisi del regime di accumulazione produttivista, fondato sul predominio del sistema manifatturiero, che aveva caratterizzato l’economia dei primi tre decenni dopo il 1945. Per oltre vent’anni il nuovo regime ha impresso – a caro prezzo – nuovo slancio all’economia mondiale, dopodiché è entrato a sua volta in crisi nel primo decennio del Duemila.
Prima di proseguire, alcune note preliminari saranno forse opportune, a cominciare da un paio di definizioni. Ricordiamo che per accumulazione s’intende il «processo di crescita del capitale esistente entro un’impresa, un settore produttivo o una società, mediante l’addizione a esso di nuove dosi di altro capitale derivante dall’eccedenza netta del [valore realizzato] della produzione sul consumo [di materiali, mezzi di produzione e lavoro] in un determinato periodo»1. Da parte sua il concetto di regime di accumulazione si riferisce alle pluriformi e interrelate modalità economiche, politiche, sociali, culturali, diverse da un’epoca all’altra in rapporto allo sviluppo del capitalismo, in cui l’accumulazione avviene; modalità che quest’ultima produce e da cui è riprodotta, fino ad arrivare inevitabilmente a un punto di crisi da cui nasce un regime differente.
L’accumulazione del capitale è il mezzo con cui l’economia capitalistica persegue il suo scopo ultimo, la realizzazione del massimo profitto. In condizioni normali ogni ciclo produttivo di un’impresa si conclude creando un valore eccedente, o plusvalore, rispetto a quello investito in mezzi di produzione e forza lavoro: tale eccedente viene appunto chiamato profitto. Una volta pagati gli interessi sui prestiti, le tasse e i debiti in scadenza, una quota di codesto plusvalore viene impiegata dai proprietari ovvero dai gestori del capitale in varie forme: dividendi distribuiti ai proprietari e ai piccoli azionisti; compensi ai top manager a titolo di gratifica o bonus, opzioni sulle azioni, azioni in regalo o altro; infine, nel caso di imprese quotate in Borsa, capita che sia utilizzata per il riacquisto di azioni proprie. Un’altra quota del plusvalore realizzato viene invece reinvestita in mezzi di produzione addizionali, oltre che nel rinnovo di quelli esistenti, e talvolta nell’acquisto di altra forza lavoro. In quanto il capitale investito ex novo si aggiunge al capitale preesistente, si parla propriamente di accumulazione del capitale.
Tra le due frazioni della quota di capitale reinvestita in un nuovo ciclo produttivo esiste un’asimmetria fondamentale. Infatti l’accumulazione accresce costantemente la frazione di capitale investita in impianti e mezzi di produzione, mentre diminuisce proporzionalmente la frazione investita in forza lavoro. Ciò avviene perché ogni quota addizionale di mezzi di produzione permette di creare un maggior numero di unità di prodotto, o un maggior valore per unità, per ogni ora di lavoro. Ma se aumenta il volume del prodotto e/o il valore aggiunto creato da ogni ora di lavoro, a volume di produzione costante il volume di lavoro utilizzato per produrlo si riduce (è a tale processo incrociato che ci si riferisce quando si parla di produttività). Ciò comporta che diminuisca pure la quantità totale di forza lavoro necessaria per produrre un determinato volume di beni, siano essi automobili, elettrodomestici o computer, il che a parità di orario porta a ridurre la quantità di lavoratori impiegati. Il problema è che insieme con la quantità di forza lavoro utilizzata per una data produzione si riduce il numero di persone avente un reddito tale da consentire loro di acquistare i beni che producono. L’esito appare cosí inevitabile: l’economia capitalistica corre di continuo il rischio di entrare in un periodo di sovraproduzione, poiché la sua capacità di produrre beni e servizi finisce per superare la sua possibilità di venderli. Ne segue che il tasso di accumulazione tende forzatamente a contrarsi se non a cessare, dando cosí origine a periodi ricorrenti piú o meno lunghi di stagnazione dell’economia, o quantomeno di crescita molto lenta. Proprio come quello che l’economia atlantica, Usa piú Ue, sta attraversando dal 2007. Soltanto eventi eccezionali provenienti dall’esterno del sistema, siano intenzionali o accidentali (se ne parla piú avanti), sono in grado di rilanciarlo, dando cosí origine a un nuovo regime di accumulazione. Tuttavia i loro effetti positivi sull’accumulazione possono durare a lungo, ma non sono eterni. Ogni regime di accumulazione, si potrebbe dire, intanto che si sviluppa prepara la propria crisi, mentre le risposte a ogni singola crisi sono atte ad alleviare oppure aggravare la crisi medesima, a ritardare oppure accelerare la successiva.
2. La stagnazione dell’economia capitalistica: stato normale o ciclico?
Il fenomeno della stagnazione dell’economia capitalistica si presta a essere oggetto di due interpretazioni, le quali sono fortemente divergenti su vari punti mentre appaiono convergere su altri. La prima, che si può definire neomarxista, muove dal postulato che la stagnazione è una tendenza endemica del sistema capitalistico. Ne discende che la finanziarizzazione dell’economia, con la sua massiccia componente di finanza speculativa, ha operato «come una sorta di motore ausiliario per la crescita data la debolezza del motore principale, l’investimento produttivo»2. In questo caso la crisi del 2007 e seguenti pare derivare dal guasto del motore ausiliario, la finanza, che finora nessuno ha provveduto a riparare, e dalla permanente debolezza del motore principale, l’investimento produttivo, con il suo necessario complemento nel settore del consumo. Per contro una seconda interpretazione della stagnazione, definibile come neokeynesiana, scorge in essa la conseguenza del modello di crescita neoliberale, fondato sulla crescita del debito e sull’inflazione dei titoli finanziari al fine di sostenere la domanda al posto della crescita dei salari, considerato che questi ultimi in termini reali sono risultati stagnanti per decenni, con particolare evidenza negli Stati Uniti. L’esplosione della bolla del debito ha fatto sí che al tempo stesso fosse bloccata la crescita e fossero portati alla luce i difetti del modello3. Vediamo piú da vicino le due interpretazioni.
L’interpretazione stagnazionista ha una lunga storia, che nel Novecento risale quantomeno alla Grande depressione degli anni Trenta. Mezzo secolo fa gli economisti americani P. A. Baran e P. M. Sweezy avevano riassunto con inusitata chiarezza la tendenza insita nel motore dell’accumulazione a procedere verso uno stato autoindotto di inceppamento:
Pur avendo la tendenza a generare quantità sempre maggiori di surplus, [il capitalismo monopolistico] non riesce a creare gli sbocchi di consumo e d’investimento necessari per assorbirle e quindi per assicurare il normale funzionamento del sistema. Poiché il surplus che non può essere assorbito non viene prodotto, ne consegue che lo stato normale dell’economia nel capitalismo monopolistico è la stagnazione4.
Stagnazione non significa che tutto si ferma, ma piuttosto che l’economia subisce un forte rallentamento, se non un arretramento, rispetto ai ritmi di crescita precedenti. In tempi recenti questa interpretazione è stata ripresa e aggiornata, facendo riferimento al decorso della crisi in atto, da autori vicini alla rivista socialista «Monthly Review».
Dagli inizi del Novecento, secondo questi autori, il principale fattore di stagnazione è stato lo sviluppo, in tutti i settori dell’economia, di grandi imprese monopolistiche e oligopolistiche5. Per le loro gigantesche dimensioni e articolazioni, nell’economia mondiale tali imprese risultano inattaccabili alla concorrenza fondata sui prezzi. Tutte cercano di ridurre, mediante la tecnologia, sia l’impiego di forza lavoro per unità di prodotto sia il suo costo. Nondimeno alla fine l’impresa monopolistica determina essa stessa il prezzo dei suoi prodotti, giacché sul mercato da essa dominato non è presente nessun altro concorrente. Da parte sua l’impresa oligopolistica, quella che condivide con poche altre il dominio del mercato, tende ad accordarsi con esse al fine di prestabilire un prezzo remunerativo delle merci o servizi che tutte producono. Le imprese che formano un circuito oligopolistico continuano in realtà a farsi concorrenza, ma con mezzi diversi dal prezzo. Ricorrono piuttosto a strumenti quali lo sviluppo di nuove tecnologie produttive; le specifiche e gli accessori del prodotto offerto; una pubblicità onnipervasiva e martellante; la competizione centrata sui marchi; le relazioni pubbliche; la sovvenzione di fondazioni, università, musei; l’attività di lobbying presso i Parlamenti e le organizzazioni intergovernative.
L’impiego di tecnologie ad alta intensità di capitale e a bassa intensità di lavoro porta ad accrescere senza posa la produttività, il precitato valore aggiunto per ora lavorata. A mano a mano che l’intensità di impiego dei due fattori di produzione si divarica, si ha per risultato che aumenta la produzione, ma non il numero o la capacità di spesa dei consumatori. Da ciò discendono vari inconvenienti correlati. Si manifesta anzitutto una marcata sovraproduzione, ossia un’eccedenza della produzione rispetto alle vendite. L’inevitabile riduzione della produzione si trasforma rapidamente in un eccesso di capacità produttiva: impianti capaci di produrre 100 finiscono per produrre 70 o meno. A loro volta la sovraproduzione e l’eccesso di capacità produttiva disincentivano gli investimenti. Si apre cosí un periodo piú o meno lungo di stagnazione dell’economia, in attesa che dall’esterno del sistema provengano stimoli per un suo rilancio, visto che dall’interno del sistema essi non proverranno mai.
L’interpretazione alternativa, quella che vede pur essa nella stagnazione un tratto intrinseco del capitalismo, ma ciò nonostante ritiene possa venire contrastata da idonee politiche economiche, risale all’economista inglese John Maynard Keynes. Un tema chiave della sua Teoria generale è il rallentamento dell’investimento. Keynes fu uno dei primi (grandi) economisti a far rilevare una contraddizione interna al processo di investimento capitalistico. In contrasto con l’economia neoclassica, che si fondava (e si fonda) sul presupposto che il sistema capitalistico contiene meccanismi di autoregolazione tali da sollecitare costantemente all’investimento, e da assicurare in tal modo uno sviluppo senza fine, egli analizzò i numerosi fattori atti a disincentivare l’investimento stesso. La contrazione degli investimenti porta alla crisi. Molti passi della Teoria appaiono singolarmente attuali. Eccone uno:
La natura dei mercati finanziari organizzati, sotto l’influenza di compratori in gran parte ignoranti di ciò che comprano e di speculatori i quali si preoccupano piú di prevedere il prossimo cambiamento dell’opinione del mercato che di stimare ragionevolmente il rendimento futuro degli attivi aventi forma di capitale, è tale che, quando la disillusione cade su un mercato troppo ottimistico e caratterizzato da un’eccessiva prevalenza di acquisti, essa [l’efficienza marginale del capitale, cioè la sua redditività] non può fare a meno di cadere con una forza improvvisa e magari catastrofica […] È quest’ultima in realtà che rende la crisi cosí intrattabile6.
La riduzione brusca degli investimenti in capitale influisce negativamente sulla domanda, sui salari, sui consumi, sull’occupazione, sui bilanci pubblici, e genera alla fine una ulteriore caduta di essi. Da questo circolo vizioso può nascere un lungo periodo di stagnazione dell’economia. In questa interpretazione sono però possibili delle varianti. La piú autorevole è quella dell’americano Hyman P. Minsky, che per vari rispetti è stato il maggior continuatore dell’opera di Keynes nella seconda metà del XX secolo. Questo autore ha incentrato l’analisi delle contraddizioni interne del capitalismo piú sulla finanza e sul sistema bancario che non sull’investimento produttivo. È indicativo del suo approccio quanto scriveva in un testo del 1986 sull’economia finanziarizzata, il suo capolavoro:
Allo scopo di comprendere la nostra economia è necessario rivolgere uno sguardo critico, al difuori di ogni insulsaggine, al sistema bancario. È una forza dirompente che tende a indurre e amplificare l’instabilità, sebbene sia un fattore essenziale ove si voglia che l’investimento e la crescita economica siano finanziati7.
Quanto tale forza possa essere dirompente era evidente sin da quegli anni. Le banche finanziano investimenti d’ogni genere sia creando esse stesse denaro (operazione che al presente si compie semplicemente con qualche tocco sul computer, iscrivendo tra gli attivi in bilancio un credito e tra i passivi un deposito), sia contraendo debiti sui mercati finanziari e con altre banche. Tale funzione di per sé essenziale per l’economia, la quale comporta che una banca presti molto piú denaro di quanto non ne possegga, si è ingigantita patologicamente sino a rompere ogni argine a partire dagli anni Ottanta. Scriveva ancora Minsky:
Negli Stati Uniti nel 1983, il rapporto tra il patrimonio netto e gli attivi era circa il 3 per cento per alcune delle maggiori banche, circa l’8 per cento per molte delle grandi banche, e fino al 12 per cento per le banche piú piccole. In altre parole, per ogni dollaro di attivi posseduto da una banca, tra 88 e 97 centesimi era finanziato da denaro preso a prestito da qualcuno […] In questo modo, la complessiva fragilità-robustezza della struttura finanziaria, da cui dipende la stabilità ciclica dell’economia, emerge dai prestiti effettuati dai banchieri. Se i banchieri sono orientati al flusso di cassa ciò conduce a sostenere una robusta struttura finanziaria. Se i banchieri attribuiscono importanza soprattutto al valore del collaterale e al valore atteso degli attivi ciò porta a far emergere una struttura finanziaria fragile8.
Questo era precisamente ciò che stava avvenendo già negli anni Ottanta. Alla base, lo scenario della crisi appariva dunque predisposto venticinque anni prima che questa esplodesse.
Una volta intervenuta la crisi, si sono moltiplicate le opere che in qualche modo si ricollegano a quella di Minsky, individuando nella degenerazione del sistema finanziario la causa principale di essa9. Vi sono però autori i quali, pur rientrando nel medesimo campo neokeynesiano, hanno spostato l’analisi verso il paradigma che ha orientato la crescita degli Usa nel ventennio finale del Novecento. Ecco come spiega la crisi Thomas Palley, uno specialista di studi sulla crescita, in un testo del 2012:
La tesi centrale di questo libro è che le radici della crisi finanziaria del 2008 e la Grande Recessione possono essere fatte risalire a un paradigma economico difettoso che ha le sue radici nel neoliberalismo, che è stato il paradigma economico dominante. Un difetto del paradigma fu il modello di crescita adottato dopo il 1980 che contava sul debito e sull’inflazione del prezzo degli attivi per spingere la domanda, al posto di una crescita dei salari legata alla crescita della produttività. Un secondo difetto fu il modello di imp...