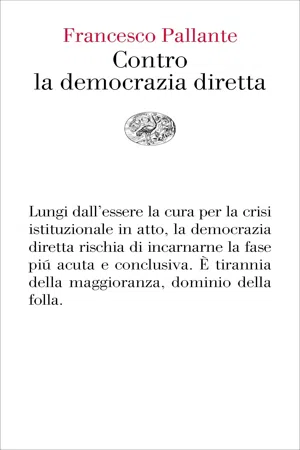Tra i seguaci piú incantati di Margaret Thatcher c’è chi ha voluto attribuirle un ruolo decisivo anche nello sviluppo di internet. Se oggi la Rete è cosí come la conosciamo – accessibile a tutti, libera, strabordante informazioni gratuite – parte rilevante del merito sarebbe ascrivibile alla decisione, presa dal governo di Sua Maestà nel 1984, di privatizzare e liberalizzare il servizio telefonico britannico. Una decisione senza precedenti nell’Europa occidentale – British Telecom era la piú grande azienda britannica – che, liberando lo spirito imprenditoriale imprigionato nella gabbia statalista, avrebbe innescato un processo tecnologico capace, nel giro di pochi anni, di trasformare il telefono a ghiera in fibra digitale. Esagerazioni agiografiche, senza dubbio. Del medesimo tenore di quelle che indussero Al Gore a coprirsi di ridicolo nel tentativo di accreditarsi come l’«inventore» di internet. E, tuttavia, la tesi che il web sia il mezzo che nel mondo contemporaneo, nel mondo della post-società, consente agli individui di mantenersi in relazione reciproca è frutto di una visione perfettamente sovrapponibile all’ideologia thatcheriana. La Rete come risultante di innumerevoli connessioni inter-individuali orizzontali, tra loro annodate in modo imprevedibile e spontaneo – non lo Stato come struttura organizzata di rapporti di potere stratificati in dimensione verticale. Ecco la veste piú adatta a raffigurare una società finalmente liberata dal giogo dei corpi intermedi.
Internet, in questa prospettiva, non è uno strumento, ma un nuovo principio d’ordine destinato a disarticolare e ricostruire l’intera esistenza collettiva. Una visione che Evgeny Morozov ha criticamente definito «internet-centrismo», il cui radicamento fa sí che possano essere prese sul serio dichiarazioni come quelle rilasciate il 22 giugno 2017 da Mark Zuckerberg alla Cnn in occasione della modifica della «mission» di Facebook:
Negli ultimi dieci anni siamo rimasti concentrati sull’obiettivo di rendere il mondo piú aperto e connesso. Non abbiamo terminato. Ma prima pensavo che, se solo avessimo dato alle persone la possibilità di esprimersi e le avessimo aiutate a connettersi, il mondo sarebbe migliorato da sé. Per molti versi è stato davvero cosí. Ma la nostra società è ancora divisa. Ora credo che noi abbiamo la responsabilità di fare di piú. Non basta connettere il mondo: dobbiamo fare in modo che si unisca sempre piú.
Chi avesse la voglia di raccogliere in un libro le dichiarazioni degli imprenditori della Silicon Valley ne ricaverebbe una lettura oscillante tra il distopico e il delirante, solitamente celebrata dai politici piú in voga come profetica anticipazione del futuro. Difficile trovare cyber-entusiasti maggiormente convinti dei pubblici amministratori. Scottato dal caso Perot, il mondo politico statunitense è il primo ad accodarsi alla rivoluzione informatica. Nel 1995 il Congresso rende disponibili in Rete tutte le informazioni relative alle proprie attività: atti preparatori, dibattiti parlamentari, produzione legislativa. L’anno successivo il repubblicano Bob Dole, candidato alle presidenziali, comunica il proprio indirizzo internet in diretta televisiva, invitando gli elettori a mettersi in contatto con lui. Nel medesimo frangente temporale, sull’altra sponda dell’Atlantico, Tony Blair fa della rivoluzione informatica il cuore della proposta politica del New Labour. L’obiettivo, annunciato al congresso di Brighton del 1997, è portare internet in ogni scuola, in ogni università, in ogni ospedale, in ogni casa. Per dimostrare la sua determinazione, il neo primo ministro britannico ottiene di essere ricevuto da Bill Gates, per averne la benedizione. Un ribaltamento di ruoli epocale, che non sfugge a un giornalista attento come Vittorio Zucconi:
[...] sbalorditivo, un uomo d’affari che concede il suo imprimatur ideale all’azione del governo di uno Stato sovrano e importante, come il Regno Unito.
Che le nuove tecnologie abbiano cambiato il nostro modo di stare al mondo è indubbio. Altro, tuttavia, è riconoscere che l’informatica abbia prodotto effetti in parte anche positivi; altro ritenere che qualsivoglia problema della vita collettiva possa trovare soluzione ottimale grazie a internet (un atteggiamento che Morozov definisce «soluzionismo»). Quel che sembra difficile negare è che anche la “luna” informatica abbia una faccia che tende a rimanere nascosta. La si può esplorare a partire da due prospettive diverse: quella di chi produce e gestisce i servizi informatici (siano questi provider, siti, social, software o hardware); e quella di chi, invece, li utilizza.
Dalla prima prospettiva, emerge l’ingenuità dell’atteggiamento di chi, in nome dell’affermazione della propria autonomia, finisce con l’affidare se stesso a un pugno di aziende private che, sfruttando in maniera non controllabile i dati personali degli utenti, realizza profitti inimmaginabili. Siamo tutti riconoscenti ai social network, per essere gratuitamente a nostra disposizione. Pensiamo di ricevere, e non ci rendiamo conto di quanto diamo sotto forma di informazioni altrimenti non conoscibili. Ce ne fornisce, con efficacia, un’idea il giornalista Matteo Bartocci su «il manifesto» del 28 giugno 2019:
Facciamo un esperimento.
Immaginate di uscire di casa e di avere alle spalle ogni volta una ventina di tizi mascherati che vi seguono ovunque e prendono nota di tutto quello che fate, di quali vetrine guardate e per quanto tempo, del tragitto che fate.
Immaginate di indossare un paio di occhiali che trasmettono in tempo reale a una società sconosciuta delle isole Vergini tutto quello che vedete, fate o scrivete.
Immaginate che tutti i vostri messaggini e telefonate siano catalogati da un tizio irlandese che può dire a chiunque con chi avete parlato e per quanto tempo. Magari pure cosa vi siete detti.
Immaginate che tutte le vostre foto siano raccolte in faldoni infiniti da funzionari del Nevada. E che davanti casa vostra ci sia un vigile gentilissimo, che vi dà ogni informazione che vi serve ogni volta che vi serve. Peccato che scriva su un quaderno il dettaglio di ogni vostra domanda.
Immaginate di vedere in ufficio un tabellone con le vostre date di ovulazione, i km che avete fatto a piedi o tutte le cose che avete comprato nell’ultimo mese.
Immaginate di avere in salotto una simpatica signora yankee che ascolta tutto quello che dite, la musica che sentite o i film che guardate e ne prende nota diligentemente.
Tutte queste situazioni, se pensate nella vita reale, terrena, sarebbero intollerabili. Neanche nella peggiore delle dittature accetteremmo di vivere cosí, braccati e registrati 24 ore su 24.
Su Internet, invece, questa è la pura normalità. Funziona esattamente cosí.
Esistono, certamente, strategie per sottrarsi, almeno in parte, a controlli tanto asfissianti. Per esempio: utilizzare motori di ricerca e browser che non tengano memoria dei comportamenti degli utenti; scegliere per gli acquisti i negozi del quartiere anziché i supermercati o, peggio, i portali elettronici; rifiutare le tessere di raccolta punti “offerte” dalla grande distribuzione; sviare il monitoraggio delle opinioni e delle preferenze ponendo, occasionalmente, in essere comportamenti menzogneri (come rispondere il falso a un’inchiesta demoscopica o effettuare ricerche on line su argomenti che in realtà non ci interessano); ridurre al minimo la presenza sui social network; fare un uso prudente dei servizi di cloud storage; e altri. Il problema è che, pur essendo alla portata di tutti, l’attuazione di tali strategie richiede impegno e, prima ancora, un’adeguata consapevolezza dei rischi derivanti dal controllo informatico a cui siamo sottoposti.
Il caso piú clamoroso – non certo l’unico – di sfruttamento dei dati degli utenti è l’«affaire Cambridge Analytica», dal nome della società britannica di consulenza elettorale fallita nel 2018 per aver concordato con Facebook l’utilizzo dei dati personali di decine di milioni di utenti al fine di orientarne l’opinione a favore di Trump e della Brexit. Acquisire consapevolezza del potere dei Big Tech che stanno all’altro capo del cavo permette di riformulare in termini attuali l’obiezione dell’impraticabilità della democrazia diretta. Quanta libertà ci permettono davvero di esprimere i social media? Quali influenze inconsapevolmente subiamo per opera di chi registra, classifica e incrocia le nostre preferenze? Come e da chi vengono selezionate e gerarchizzate le informazioni reperite on line? Qual è il funzionamento degli algoritmi di “fidelizzazione” rivolti a rinsaldare le nostre convinzioni tramite link compatibili con i nostri profili?
Sono interrogativi che ridimensionano la portata politicamente rivoluzionaria delle trasformazioni tecnologiche in atto, sino al punto da indurre alcuni a ritenere che internet abbia impoverito, non arricchito, il dibattito pubblico (è l’opinione espressa dal giurista statunitense Cass Sunstein, a proposito della possibilità di ricevere, in risposta alle nostre interrogazioni informatiche, informazioni sempre piú personalizzate).
Dobbiamo ancora a Evgeny Morozov l’aver rilevato quanto l’informatica abbia semplificato la vita dei regimi autoritari. Quel che sta avvenendo in Cina grazie alla tecnologia di riconoscimento facciale – utilizzata, in particolare, per reprimere la minoranza uigura dello Xinjiang – sembra, in effetti, la realizzazione della distopia orwelliana. Molte altre dittature hanno approfittato delle tracce lasciate su internet dagli oppositori per reprimerli piú agevolmente, non di rado con la complicità di aziende informatiche specializzate nel settore.
Anche su scala incomparabilmente minore, emerge comunque il potere di chi controlla la tecnologia nei confronti degli utenti delle piattaforme informatiche. In un evidente gioco delle parti, Beppe Grillo si è spinto a dileggiare il modo in cui, tramite il sito Rousseau, ai militanti pentastellati è stato chiesto se processare Salvini per il sequestro dei migranti sulla nave Diciotti. «Se voti Sí vuol dire No. Se voti No vuol dire Sí. Siamo tra il comma 22 e la sindrome di Procuste!», ha sentenziato in un post su Facebook del 17 febbraio 2019. Poche settimane dopo, a fronte del disastroso risultato del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee, la manipolazione si faceva ancora piú esplicita: «Domani si vota su Rousseau per confermare la fiducia a Luigi Di Maio», twittava senza ritegno l’account ufficiale del movimento il 29 maggio 2019. La possibilità del voto contrario non era contemplata nemmeno in astratto. Chissà mai che qualcuno degli iscritti si fosse lasciato tentare…
La cosa piú grave è che nessun soggetto indipendente sa come effettivamente funzioni il sito della Casaleggio Associati: quali garanzie vi siano che a tutti sia consentito l’accesso, che la partecipazione sia quella dichiarata, che il voto non sia controllabile o, peggio, manipolabile. A lasciare interdetti non è tanto che il Garante della privacy abbia ritenuto di sanzionarne l’opacità, quanto che la sanzione di cinquantamila euro sia stata prontamente pagata, senza che la contestazione andasse al di là di un’accusa di pregiudizio politico affidata al «Blog delle stelle».
A ben vedere, ciò di cui stiamo parlando – la manipolabilità degli elettori – è un limite che da sempre grava sugli istituti di democrazia diretta. Il potere di rivolgere la domanda è ben piú decisivo di quello di fornire la risposta. Referendum, petizione, iniziativa popolare ecc. sono tutti strumenti attivabili da minoranze organizzate che formulano opzioni politiche circoscritte da sottoporre al corpo elettorale. Sono, dunque, piú credibilmente considerabili dispositivi nelle mani di élite, in dialettica con le forze parlamentari, piuttosto che come mezzi d’azione del popolo nel suo complesso.
Come ha argomentato il costituzionalista tedesco Ernst-Wolfgang Böckenförde – che pure riconosce alla democrazia diretta un «plusvalore democratico» rispetto alla democrazia rappresentativa –, a ben guardarle, le forme della democrazia diretta non riescono a mascherare la sostanza dell’organizzazione rappresentativa che le mette concretamente in azione. Basti pensare alla formazione politica che piú di tutte, nella storia repubblicana, ha utilizzato lo strumento referendario, il Partito radicale: un ristretto circolo di militanti raccolto intorno a un leader carismatico oggetto di venerazione.
Esempio clamoroso di manipolazione dell’elettorato tramite lo strumento referendario è il quesito formulato per la consultazione costituzionale del 2016:
Approvate il testo della legge costituzionale concernente disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione?
Come a dire: siete favorevoli o contrari al Paese di Bengodi?
Persino la scelta della data della consultazione può rivelare le intenzioni manipolative dei proponenti: come nel caso del referendum consultivo veneto sull’autonomia regionale, fissato nel giorno esatto del 151° anniversario del plebiscito che sancí l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Con battuta fulminante, il costituzionalista Alfonso Di Giovine domanda: «democrazia diretta: da chi?» e mette in luce come, nella storia repubblicana, i quesiti referendari siano stati utilizzati, piú che per innovare l’ordinamento giuridico, per influire sugli equilibri politici esistenti.
Proseguendo l’esplorazione del lato nascosto della “luna” informatica, e assumendo ora la prospettiva degli utenti, a venire in evidenza è il sovraccarico di informazioni a cui i navigatori del web sono esposti giorno e notte. Una ricerca dell’Università della California stimava, già nel 2008, che ciascuno di noi fosse quotidianamente esposto a un “bombardamento” visivo e uditivo di oltre centomila parole, molte piú di quante il cervello umano sia in grado di elaborare. Avere troppi elementi da considerare ostacola la concentrazione. Svia l’attenzione verso le informazioni piú idonee a provocare emozioni forti e meno complesse da trattare: in entrambi i casi a discapito della loro importanza. È un paradosso: l’abnorme quantità di dati, nel contempo, diminuisce la capacità di elaborarli e incrementa la necessità di prendere decisioni. Con il risultato che sempre piú ci affidiamo alle scelte che gli algoritmi prendono per noi – algoritmi che, come la funzione di completamento automatico della ricerca di Google, sono oramai cosí potenti da anticipare i nostri desideri.
Sovraccarico di informazioni, difetto dell’attenzione, sensibilità agli stimoli eccitanti, necessità di semplificazione: sono gli ingredienti della mistura esplosiva che spiega il successo del complottismo in Rete. Ce n’è per tutti i gusti: dalla farsa al dramma. Un’inchiesta condotta da YouGov nell’aprile 2018 ha rilevato che il 2 per cento degli americani è convinto che la terra sia piatta, mentre un ulteriore 7 per cento non esclude che sia un’ipotesi plausibile. Sembra incredibile: nel complesso, si tratta di ventinove milioni di persone disposte a sostenere la tesi – o quantomeno a discuterla – che il Polo Nord si trovi al centro di un enorme disco di terra e acqua circondato da un’altissima catena montuosa, il cosiddetto Polo Sud, che impedisce alle acque degli oceani di defluire nel vuoto cosmico. La forza di gravità, la rotazione terrestre, la rivoluzione attorno al sole, le missioni spaziali: tutte fandonie. Già che ci sono, i terrapiattisti religiosi aggiungono anche l’evoluzionismo.
Disposto a credere solo a ciò che può osservare di persona, lo statunitense Mike Hughes, autista di limousine, è salito per due volte, nel 2014 e nel 2018, su un razzo da lui stesso costruito allo scopo di verificare la curvatura della terra. La modesta altitudine raggiunta – intorno ai quattrocento metri – non gli ha consentito di portare a termine l’esperimento, ma, per lo meno, ha contribuito a limitare la gravità delle ferite subite al momento dell’impatto al suolo.
Ben piú drammatiche le conseguenze di un’altra colossale menzogna che spopola sul web: quella rivolta a denunciare il Piano Kalergi, un complotto ord...