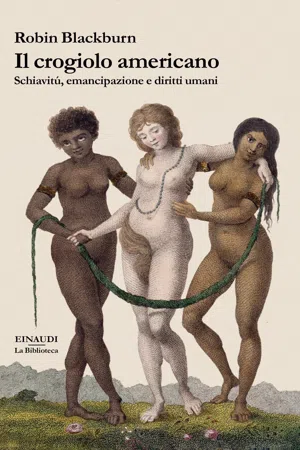La fine della schiavitú nel Nuovo Mondo indurrebbe fin troppo facilmente a immaginare un’incontenibile avanzata del movimento abolizionista. Al contrario, i risultati furono spesso incerti e conseguiti solo in modo disuniforme e imperfetto. Nondimeno, l’abolizionismo, la resistenza degli schiavi, la mobilitazione patriottica e la lotta di classe alla fine si unirono per distruggere i sistemi schiavisti. Nel volgere di pochi decenni, la schiavitú, dopo essere stata rispettata in Europa come un’istituzione ormai consolidata, divenne una pratica diffusamente odiata. Vi furono momenti in cui perfino molti proprietari di piantagioni ebbero a pentirsi sinceramente di dipendere dagli schiavi. Nelle Americhe, la schiavitú non si limitò semplicemente a scomparire, come aveva fatto in molte parti dell’Europa tardo medievale. La tratta atlantica e i sistemi schiavisti che essa aveva creato nel Nuovo Mondo furono distrutti con atti legislativi ben precisi e dalla resistenza degli schiavi. L’emancipazione non fu una questione localizzata o furtiva, ma qualcosa da incorporare in clamorosi decreti di importanza storica e piena consapevolezza. Grandi movimenti sociali contro la tratta degli schiavi e la schiavitú sorsero fuori dalle zone in cui essa era praticata, cosí come la retorica abolizionista venne ad aggrovigliarsi con grandi conflitti politici, plasmando e rimodellando la condotta e la cultura dei principali stati atlantici. Tutto questo richiede una spiegazione sistematica, la stessa che si rende necessaria riguardo ai limiti spesso deludenti dell’emancipazione, i cui decreti venivano visti come prova di una superiorità morale e come il riconoscimento del diritto di decidere in nome di razze ritenute comunque inferiori. I discorsi sulla libertà troppo spesso vennero a fondersi con la retorica di una nuova espressione di potere, ricchezza e razza. In quanto segue cerco di delineare, seppure provvisoriamente, il tentativo di comprendere l’abolizionismo – limitandomi in alcuni punti solo a una sorta di inventario, in altri a generalizzazioni che si sforzano di non essere troppo generali o, peggio ancora, errate.
L’abolizione avanza.
La schiavitú del Nuovo Mondo fu soppressa in un territorio dopo l’altro, dal Vermont e la Pennsylvania, rispettivamente nel 1777 e nel 1780, a Cuba nel 1886 e al Brasile nel 1888. All’inizio di tale periodo, la schiavitú era legale e apparentemente inattaccabile in tutte le colonie europee del Nuovo Mondo. Prima del 1760, non era mai stata messa in discussione da qualcuno a cui la questione sembrasse davvero importare, e la produzione ottenuta grazie al lavoro degli schiavi costituiva la base di un commercio atlantico che, a sua volta, come abbiamo visto nel capitolo IV, era la linfa vitale degli imperi europei nel Nuovo Mondo. La nascita dell’ideale antischiavista, generatosi in un contesto inizialmente poco promettente, è stata tracciata nel capitolo VII. Nonostante alcuni successi su piccola scala, come una piú rigida regolamentazione delle navi negriere, la prima campagna abolizionista di massa in Gran Bretagna (1787-92) si concluse nel panico anti-giacobino. La Rivoluzione haitiana (1791-1804) assicurò la libertà a mezzo milione di schiavi e favorí il risveglio dell’abolizionismo britannico. Il divieto della tratta degli schiavi nell’Atlantico, emesso nel 1808 da Gran Bretagna e Stati Uniti, fu di grande soddisfazione per gli abolizionisti, cosí come la denuncia del traffico di esseri umani da parte del Congresso di Vienna nel 1815. Negli anni venti del XIX secolo, come abbiamo visto nel capitolo precedente, a tutto questo seguí nell’America spagnola la nascita di nuove repubbliche che bandirono l’importazione di schiavi e promulgarono leggi sulla Libertad de vientres. Il sentimento abolizionista fu stimolato da quei successi, ma anche dalla consapevolezza che nell’Atlantico persisteva un traffico clandestino di esseri umani e che la stessa schiavitú prosperava ancora in varie regioni delle Americhe. La Rivoluzione francese del 1830, pur comportando soltanto modeste conseguenze dal punto di vista abolizionista – ad esempio il divieto delle importazioni di schiavi nelle restanti colonie francesi –, segnò la rinascita di un’idea di progresso, come Condorcet l’aveva delineata.
Il riaccendersi della campagna contro la schiavitú in Gran Bretagna negli anni venti del XIX secolo e la sua vittoria definitiva nel decennio successivo sembrarono confermare l’irresistibile marcia in avanti dell’abolizionismo. La Gran Bretagna era la vera «superpotenza» atlantica, tanto che nelle Indie Occidentali britanniche l’emancipazione portò la libertà a 700 000 schiavi. La stessa breccia aperta dall’abolizionismo rifletteva la nuova vulnerabilità dell’ordinamento schiavista nei Caraibi, in un momento di profonda crisi sociale e politica sia nella madrepatria sia nelle colonie.
Le ribellioni degli schiavi a Barbados nel 1816, nella Guyana britannica nel 1823 e in Giamaica nel 1831-32 rispecchiavano e radicalizzavano il dibattito sulla schiavitú condotto nella madrepatria. I rivoltosi sapevano bene che lo stesso funzionamento della schiavitú era controverso. Alcuni credevano che i proprietari delle piantagioni o i funzionari locali nascondessero o ostacolassero le misure approvate dalla madrepatria in favore degli schiavi. In realtà, era stata proprio l’azione dei ribelli a incoraggiare e rianimare un movimento dormiente. Nel 1816, alcuni rivoltosi di Barbados interpretarono il tentativo di redigere un registro degli schiavi come uno sforzo della madrepatria di regolamentarne o frenarne il possesso. In genere, i ribelli che negli anni tra il 1816 e il 1832 capeggiarono i disordini nelle Indie Occidentali britanniche cercavano il negoziato piuttosto che il massacro o il saccheggio e ritenevano che la madrepatria e le autorità coloniali fossero in grado di esercitare un potenziale controllo sui padroni delle piantagioni o sugli amministratori delle proprietà terriere. Talora, gli schiavi ribelli richiedevano soltanto piú tempo libero o il pagamento dei lavori supplementari. Le autorità coloniali non avevano istruzioni per negoziare su tali rivendicazioni, mentre i bianchi chiedevano che le rivolte venissero schiacciate e che i loro capi fossero giustiziati. L’arrivo dei missionari metodisti e battisti aveva aperto alcuni canali di comunicazione non ufficiali tra la madrepatria e le colonie, benché i missionari non mancassero di ribadire che gli schiavi dovevano dimostrare obbedienza ai loro padroni. Il fatto che agli stessi battisti, metodisti e altri protestanti «non conformisti» fossero negate in Gran Bretagna le cariche pubbliche e il diritto di voto dimostra quanto fossero pertinenti le loro campagne a favore degli schiavi.
A Demerara, nel 1823, il missionario John Smith fu arrestato e imprigionato con l’accusa di aver incoraggiato gli schiavi ribelli, ma morí in prigione prima di poter arrivare al processo vero e proprio. I «non conformisti» britannici si sentirono oltraggiati e raddoppiarono le loro agitazioni contro la schiavitú. I parlamentari sostenitori dell’abolizionismo deplorarono sia la ribellione degli schiavi sia la repressione messa in atto dai proprietari delle piantagioni. Allorché appresero maggiori informazioni sulla natura dei disordini a Demerara, capirono che la ribellione in atto non era un cieco atto di vendetta. Nel 1824, il leader abolizionista Henry Brougham spiegò al Parlamento che gli schiavi erano «infiammati dal desiderio di libertà» e che per loro era piú che naturale credere che un tentativo della madrepatria di migliorare la loro condizione non potesse che promuovere la loro libertà. Brougham rimarcò il comportamento moderato dei ribelli e il fatto che avevano accettato di negoziare con il governatore, spiegando che desideravano solo la libertà, non lo spargimento di sangue1. Mentre nel 1816 non esisteva alcuna organizzazione che mirasse all’emancipazione degli schiavi, nel 1823 era stata istituita la Society for the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery Throughout the British Dominions («Società per mitigare e abolire gradualmente la schiavitú nei domini britannici»). Nel 1830, la società si persuase a porsi come proprio obiettivo l’emancipazione immediata e a intraprendere campagne di massa.
Durante la «guerra dei battisti» in Giamaica (alla fine del dicembre 1831), circa 30 000 schiavi, armati solo di machete, abbandonarono le piantagioni e organizzarono dimostrazioni per la libertà. Molti dei leader erano in qualche modo coinvolti con le Chiese battiste. Se la ribellione degli schiavi assunse il carattere di una manifestazione armata che avanzava specifiche richieste, la reazione dei padroni delle piantagioni fu sanguinosa e indiscriminata, causando centinaia di morti. Quattro missionari furono deportati dalle autorità coloniali, nonostante l’assenza di prove che avessero in qualche modo istigato la rivolta.
La campagna contro gli abusi della schiavitú nelle Indie Occidentali e il crescente sdegno per la persecuzione dei missionari iniettarono una forte componente morale e simbolica nella lotta contro la «Old Corruption», e questo proprio quando la crisi innescata dal Reform Act 1832 – la crisi piú grave dell’ordinamento politico inglese dal 1688 ai tempi moderni – raggiungeva il suo culmine2. Gli interessi personali erano contrari al seppur minimo cambiamento, il che portò il duca di Wellington ad assumere la premiership nel momento piú critico per affrontare la protesta popolare. Manifestazioni, petizioni, rivolte e scioperi erano espressione di un caos civile diffuso e disparato. In assenza di moderne forze di polizia, e con la maggior parte dell’esercito in Irlanda, Londra e le contee circostanti potevano contare solo su circa 5000 soldati3. A Birmingham, i partigiani della Riforma iniziarono ad aizzare il popolo. Le campagne erano spazzate dalle rivolte di «Captain Swing», mentre la capitale assisteva a enormi dimostrazioni – effettivamente senza precedenti – delle «classi lavoratrici» che esigevano una «riforma», ovvero il diritto di voto. Il paese non stava correndo incontro a una rivoluzione in stile 1789; il governo degli Hannover era un regime borghese tronfio e corrotto, ma non era un apparato feudale assolutista. Piú vicino e piú preoccupante poteva essere il parallelismo con la Rivoluzione francese del 1830, con l’ulteriore minaccia di qualcosa di maggiormente simile al 1848. Un epilogo del genere fu evitato quando il re Guglielmo IV dimostrò il buon senso di lasciare il passo a Gray, Macaulay e Brougham. La riforma da loro proposta, dopotutto, poteva spazzare via le sezioni elettorali con pochissimi votanti, eliminare i sussidi religiosi e concedere il diritto di voto ai proprietari che potevano contare su una rendita annuale minima di 10 sterline, ma manteneva la monarchia e la Camera dei Lord e a poter votare sarebbe stato soltanto poco piú di un decimo della popolazione maschile adulta. Come scrive Edward Thompson su quel periodo:
Da una certa angolazione, l’Inghilterra attraversò in dodici mesi (fino al maggio del 1832) una crisi da cui era possibile nascesse una rivoluzione. […] Alle enormi dimostrazioni, che nell’autunno del 1831 e nel maggio del 1832 portarono in piazza oltre 100 000 manifestanti a Birmingham e Londra, partecipavano in gran parte artigiani e operai. […] Da un’altra angolazione, possiamo capire perché durante quei mesi di crisi una rivoluzione fosse in effetti improbabile. Il motivo è da ricercarsi nella forza stessa del movimento radicale della classe operaia; nell’abilità con cui i leader dei ceti medi, insieme con Brougham e giornali come «The Times» e il «Leeds Mercury», usarono questa forza della classe operaia e negoziarono una ritirata che poté risultare accettabile a quasi tutti i difensori piú intransigenti dell’ancien régime. […] La borghesia industriale desiderava con tutta l’anima che non avvenisse nessuna rivoluzione, ben sapendo che nel giorno stesso del suo inizio vi sarebbe stata una drammatica radicalizzazione4.
Il clamore per l’emancipazione degli schiavi collimava perfettamente con una riforma responsabile, confermando l’idea che il Reform Act segnasse solo l’alba di una trasformazione di piú ampia portata, ottenuta con mezzi costituzionali5.
Sia i rappresentanti dei ceti medi sia quelli della classe operaia vedevano con favore l’antischiavismo, come un terreno su cui avrebbero potuto instaurare una collaborazione tale da rafforzare le loro posizioni in vista di difficoltà future6. Il «capitale morale» che la leadership borghese della classe media aveva guadagnato dalla lotta per l’emancipazione degli schiavi poteva essere usato per contenere la radicalizzazione politica e dimostrare la propria buona fede. Il disegno di legge riformista riconosceva la rappresentanza parlamentare ai nuovi centri manifatturieri e faceva della Camera dei Comuni il massimo organo di governo. Grazie alla sua natura moderata, tuttavia, ottenne anche il forte appoggio della City di Londra. In effetti, il Reform Act e la riforma del Parlamento risultavano cosí chiaramente e strettamente «borghesi» e legati ai ceti medi da far avvertire il bisogno di un qualche gesto drastico e generoso per dimostrare di non essere irrimediabilmente improntati all’individualismo e al corporativismo. Si rendeva necessario un appello piú ampio alle masse, poiché occorreva comunque la pressione popolare affinché la riforma fosse approvata a livello parlamentare e reale. L’emancipazione degli schiavi poteva aggiungere un elemento nobile e disinteressato a quella che altrimenti sarebbe stata palesemente una piattaforma programmatica del ceto medio, moderata ed egoistica7.
La campagna contro la schiavitú fu intensa, con migliaia di comizi, editoriali, solenni cortei fino a Downing Street e lunghe petizioni al Parlamento. Le associazioni abolizioniste femminili fecero la loro prima comparsa negli anni venti del XIX secolo, e nel 1825 la Birmingham Ladies Negro’s Friend Society spianò la strada con la richiesta di un’emancipazione immediata e non graduale. Un editore abolizionista pubblicò un vibrante racconto di schiavi, The History of Mary Prince, una vivida descrizione della vulnerabilità e dell’infinita fatica della donna schiava. Metodisti e battisti sostennero energicamente la campagna, e l’abolizionismo guadagnò grande risonanza nella cultura politica inglese. Per i governi britannici, la soppressione della tratta degli schiavi nell’Atlantico si era accompagnata in politica estera alle preoccupazioni legate al libero scambio e agli equilibri di forza tra le varie potenze. In risposta alle pressioni abolizioniste, i diversi governi avevano introdotto un registro della popolazione in schiavitú e proposto delle regolamentazioni – come il divieto di frustare le schiave – al fine di rendere piú umani i meccanismi del regime schiavista. Tali misure avevano provocato a loro volta la resistenza da parte dei proprietari delle piantagioni e ispirato speranze nelle comunità di schiavi.
Dopo la sorprendente approvazione del Reform Act nel 1832, il primo grande provvedimento legislativo adottato dal Parlamento nato dalla riforma fu lo Slave Emancipation Act del 1833. Con grande delusione di molti abolizionisti, ai proprietari delle piantagioni erano riconosciuti sostanziali indennizzi per la perdita dei loro 700 000 schiavi, sia in denaro contante – poco meno di 20 milioni di sterline – sia nell’obbligo imposto agli schiavi di lavorare per i loro padroni come «apprendisti» per altri sei anni, in cambio di una paga simbolica. Chiunque rifiutasse non doveva essere sottoposto alla fustigazione bensí tradotto dinnanzi a un tribunale, in cui sarebbe stato condannato al carcere e a spingere la gigantesca ruota di un mulino, dove avrebbe corso il rischio di ferirsi gravemente se non teneva il passo degli altri carcerati. L’Anti-Slavery Society inviò una missione per «accertare i fatti» che rilevò numerosi abusi. L’Emancipation Act prevedeva inoltre la trasferta nelle Indie Occidentali di «magistrati stipendiati» inglesi che avrebbero dovuto proteggere i tribunali dalle vessazioni dei proprietari delle piantagioni. Gli ex schiavi si opposero alla condizione dell’«apprendistato» e furono incoraggiati da missionari dissenzienti a esigere salari adeguati. Le istituzioni di apprendistato incarnavano la piú recente teoria penale, secondo cui occorreva somministrare agli elementi piú recalcitranti una «giusta dose di sofferenza». Agli occhi degli ex schiavi, tuttavia, i riluttanti «apprendisti» delle Indie Occidentali non apparivano dei malfattori. L’esperienza nelle squadre di lavoro e negli zuccherifici aveva instillato in loro una forte avversione al principio della prigione di tipo «panopticon»8. Mano a mano che il «Grande esperimento» si andava sviluppando, la combinazione tra resistenza dei lavoratori, proteste dei missionari, incertezze giudiziarie e indignazione abolizionista portò a una nuova crisi parlamentare in Gran Bretagna. Nel 1838, il governo pose quindi fine al sistema dell’apprendistato.
Il risarcimento di 20 milioni di sterline versato ai proprietari delle Indie Occidentali fu, dal canto suo, un espediente di maggior successo. Va da sé che la forma piú elementare di giustizia avrebbe dovuto imporre che quei soldi fossero pagati agli ex schiavi, che avrebbero cosí ricevuto un aiuto per affermarsi come agricoltori indipendenti. La clausola dell’indennizzo era stata aggiunta, in parte, per placare i proprietari delle piantagioni delle Indie Occident...