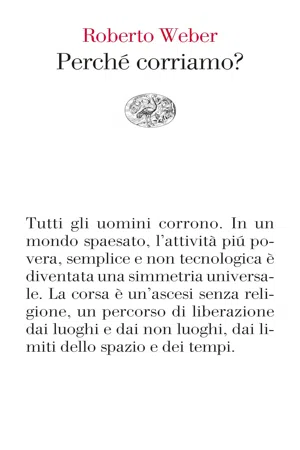1. La paura.
La gara comincia molto prima del via. Ricordo ancora l’angoscia che riempiva l’ora o la mezz’ora che precedevano la partenza. Di solito a un sommario riscaldamento lasciato a una leggerissima souplesse, seguivano delle accelerazioni di quaranta-cinquanta metri. Poi iniziava l’agonia: svestirsi, cambiare le scarpe, aggiustare il numero sulla maglietta, finché ci si riuniva nei pressi della riga di partenza tracciata con il gesso sulla pista in terra rossa e, con occhiate traverse, distratti sguardi laterali, goffo sbirciare, si prendevano le misure degli avversari. Si trattava di una paura priva di oggetto, di volto, nulla di precisamente referenziato. Era senza nome e, oltre a sentirsela addosso, la si leggeva negli occhi di tutti. Ben poche delle paure adulte hanno conservato lo stesso tratto di misteriosa minacciosità, nessuna mi è parsa altrettanto indeterminata e irriducibile. Essenzialmente era una sorta di mancanza di respiro senza che effettivamente mancasse il respiro, una compressione dell’anima. Il tempo spariva: la marea montava ingoiando il passato e prosciugando il futuro.
Quanto ci circondava, il cielo azzurro scintillante, l’alto calore estivo, le bandiere che flottavano nel vento, l’erba pungente sotto i piedi, era ridotto a un’interferenza detestabile e priva di senso. Come per gli eroi dannati di Dostoevskij e prima ancora di Stendhal, il mondo esterno avvizziva e ciò che contava era il battito del cuore, la pulsante vita interiore.
Era uno stato d’animo di natura duplice: da un lato c’era l’incertezza, il sentimento che davanti a noi in quel paio di minuti di gara si nascondesse un destino spezzato, che tutto fosse in gioco, se stessi, il diritto di vivere, soprattutto il diritto a un nome. Alla partenza eravamo qualcosa di confuso e indeterminato e ciò che inseguivamo era il riconoscimento, l’identità, il nome. Nulla di piú adolescenziale e nulla di piú vero. Dall’altro c’era una piú profonda pulsione animale: sapevamo che avremmo liberato una grande quantità di energia che a sua volta altro non era che violenza concentrata e sublimata. Una violenza che nel suo primario disordine faceva vacillare il nostro altro io quotidiano costruito sulle convenzioni, la disciplina, il controllo, la civiltà. Tutto ciò appartiene al chiuso e ristretto mondo dell’agonismo, indipendentemente dal livello, dallo spessore dei protagonisti, dai luoghi della lotta. Quanto si è affermato dopo, nell’allargamento e nella fortunata massificazione delle competizioni – le grandi maratone non competitive, le corse amatoriali di lunga distanza –, segna una diversa affermazione della pratica sportiva. Su tutto prevale una chiave di «cameratismo» antagonistico, un inseguire la pienezza fisica, un allargarsi dei traguardi «relativi», un sostanziale dominio della «maturità». Nell’agonismo non c’è spazio per i relativi, prevalgono gli «assoluti», non c’è maturità: domina un vissuto di onnipotenza e indeterminatezza e, quindi, la ricerca di senso tipica dell’adolescenza.
Achille in fondo è il primo dei grandi adolescenti.
2. Sconfitta.
Nella definizione dell’immaginario collettivo americano Hemingway rappresenta un punto di riferimento importante. Per raccontare e dar senso alla vita dell’uomo, Hemingway sceglie la caccia, la guerra, la morte, il pericolo.
Basta scorrere alcuni dei suoi quarantanove racconti per accorgersene – L’invitto, Breve vita felice di Francis Macomber, Il lottatore: uomini soli alle prese con la morte, la frustrazione, la paura, in una prova che è sempre senza appello.
È una tematizzazione importante la sua perché, da allora a oggi, la messa a fuoco di «vincenti e perdenti» costituirà uno dei terreni piú proficui per il giornalismo, la letteratura e naturalmente il cinema. E tuttavia c’è in Hemingway e nella sua capacità mimetica qualcosa di eccessivamente letterario, che rende il tutto over-americano e finisce per tradursi in una perdita di verosimiglianza, in una rigidità che accoglie il sarcasmo, ma esclude l’ironia. Insomma, è un prendersi troppo sul serio. Personalmente gli ho sempre preferito il tubercolotico Dashiell Hammet che, uscendo di galera dopo avervi trascorso sei mesi con l’accusa di essere comunista, a un cronista che lo interrogava si limitò a mormorare «be’ ho conosciuto posti peggiori». Negli echi di quella battuta ritrovavo il mio amico Aldo che in certe mattinate crude d’inverno, alla partenza di sei feroci chilometri di corsa campestre, alleviava il mio smarrimento sussurrandomi ridendo «non c’è da aver paura, dobbiamo semplicemente soffrire, soffrire e soffrire». Nel suo atteggiamento scanzonato, piú del desiderio di rimuovere la paura, il dolore, la stessa frustrazione per una sconfitta annunciata, c’era la volontà di assumerli «con divertimento», di trasformarli in una zona di esperienza da esplorare.
La peculiarità del rapporto che gli Americani mantengono con la sconfitta, emerge con plasticità se guardiamo ad alcuni episodi del grande mezzofondo considerati «drammatici» da molti commentatori. Mary Decker Slaney in qualche modo ci appare «tipica»: nella finale dei tremila metri piani alle Olimpiadi di Los Angeles entra in collisione con la giovanissima Zola Budd, cade e non riesce a riprendere la corsa. La delusione e la rabbia si trasformano in un pianto irato e irredimibile, che nel dopo gara diventerà una violenta requisitoria contro la rappresentante sudafricana che corre sotto bandiera inglese. Ciò che Mary Decker semplicemente non riusciva ad accettare era che per quanto duramente si fosse allenata, per quanto grandi fossero le sue aspettative e per quanto «vincente» si sentisse in quella giornata, ci potesse essere qualcosa che sfuggiva alla «contabilità generale», la mano inattesa del destino, o – chissà? – il gioco sottile del maligno. No, Mary Decker riteneva di aver sottoscritto un contratto particolare con il buon Dio che le riconosceva il diritto di vincere, poiché vincere contribuisce alla felicità e la Costituzione americana stabilisce il diritto di ogni uomo e donna a essere felice. Diversamente dagli eroi omerici che accettano la loro sorte, Mary quel giorno continuò a rifiutarla, in mondovisione, con plateale e infantile ostinazione.
Non sappiamo cosa provò Roger Moens alle Olimpiadi di Roma, cui giunse debilitato da una tendinite, dopo aver perso la miglior chance olimpica a Melbourne quattro anni prima, per un banalissimo incidente. Era la sua ultima occasione di vincere i Giochi e la smarrí contro Peter Snell per sette centesimi di secondo, dopo quattro gare in cinquantadue ore. Non seguirono acting out, proteste o conferenze stampa cariche di pathos e lacrime. Forse il grande Roger – come spesso accade – accettò quell’ulteriore frustrazione, in termini di «colpa personale» da sopportare in silenzio, ma potrebbe darsi che Moens – anche al tempo dei suoi giorni migliori – fosse riuscito a mantenere un legame sotterraneo con i suoi compagni di corsa, il senso di una piú profonda «parentela», il riconoscimento di quel «common bond» di cui parla Hawthorne, che riusciva a sottrarlo al demone dell’individualità per restituirlo a un’appartenenza piú vasta.
Sono, ahimé, cose che nascono «naturalmente» come frutto dell’esperienza, della vita, o forse dalla percezione fondante di essere comunque «relativi». Sto pensando a un corridore italiano, Scartezzini, che al tempo delle Olimpiadi di Mosca deteneva la miglior prestazione mondiale sui tremila siepi e che fu costretto a rinunciare ai Giochi perché, diversamente dai suoi compagni, apparteneva a un gruppo sportivo «militare». E sto pensando al grande Sebastian Coe, cui fu negata una wild card per le sue terze Olimpiadi, sebbene fosse noto che al tempo delle selezioni soffriva di mononucleosi. Entrambi, sia pur diversi per fama e fortuna, si limitarono ad accettare la carta «sporca» del destino, lasciando forse intendere che anche essere «esclusi» ingiustamente poteva far parte delle regole del gioco.
È probabile che l’abitudine a prendersela con il fato, o la sfortuna, si sia accentuata in questi ultimi vent’anni.
L’autopercezione dell’atleta, infatti, non è piú solo l’esito del vissuto della propria forza, abilità, capacità di sofferenza, ma anche il prodotto dell’immagine riflessa dei media, quella sorta di aura che giornali e Tv costruiscono attorno al malcapitato atleta.
Un buon terreno per capire questo scivolamento sta nel modo in cui giornalisti, esperti e atleti stessi trattano il problema degli infortuni: «non ho potuto allenarmi a fondo, solo ora sto ritrovando alcune sensazioni; i tendini non gli dànno pace, soffre di una maligna microfrattura…»
A essere chiamati in causa sono ancora la sfortuna, il destino avverso, addirittura – ne è la spia la parola maligna – l’intervento di divinità ostili, quando nella grandissima parte dei casi l’infortunio è l’esito di carichi di lavoro eccessivi per quel singolo atleta.
Cosí, anziché essere il segnale di una soglia raggiunta, della necessità quindi di non spingersi oltre, dell’idea che il tuo stesso corpo costruito per la velocità non può caricarsi di troppa velocità, l’infortunio diventa una sorta di risvolto ideologico marxiano, di falsa coscienza, di rimozione dei tuoi limiti…
In tempi di massima sofisticazione, dunque, riscopriamo le tracce di un mondo arcaico, pagano, animato da spiriti avversi o amici, un mondo che per molti versi elude l’idea della responsabilità individuale, l’idea di dover accettare ed elaborare la sconfitta.
3. Duelli.
Scrittori, commentatori Tv, giornalisti, atleti, giú fino ad arrivare al pubblico, alla gente, nessuno si sottrae alla mistica del duello: il duello infinito, il duello dell’anno o ancora il duello del secolo, il duello fra il vecchio campione e il talento emergente, il duello finale che deciderà della supremazia…
Sembra dunque che nell’immaginazione collettiva e nel ricordo, il «duello» svolga un ruolo fondante, abbia il compito di segnare i passaggi d’epoca, le cesure, la progressiva e inarrestabile costruzione della mitologia sportiva: nel ciclismo Coppi e Bartali, Merckx e Gimondi, Poulidor e Anquetil, e in atletica Harbig e Lanzi, Gebrselassie e Tergat, ancora Gebrselassie e Bekele, Coe e Ovett, Ryun e Keino. Basta volgersi indietro per scoprire che negli sport individuali il passato è cosparso di duelli, costellato di scontri «finali», di «epici», indimenticabili confronti. Eppure, se soltanto ci fermiamo a considerare con piú cura le stagioni trascorse, ci accorgiamo che spesso, spessissimo, il parametro fondamentale del vero «duello» è assente: manca infatti la prerogativa che dovrebbe rendere appassionante lo scontro, ovvero l’equilibrio fra i contendenti, e mancano – come naturale conseguenza – l’incertezza, l’imprevedibilità dell’esito finale. Il piú delle volte sappiamo da un pezzo chi è il piú «forte» e quindi siamo in grado di dire chi sarà il vincitore. Ciò ci riporta indietro al primo di tutti i duelli, al prototipo che segna la nascita della letteratura occidentale, allo scontro finale fra Ettore e Achille. È il libro ventiduesimo dell’Iliade e sappiamo ormai da tempo come andrà a finire. È stato Omero stesso a dircelo nel corso dei dodicimila versi precedenti: Achille, l’eroe acheo, è di gran lunga il piú forte fra i due ed è destino che Ettore perisca, perché sarà la sua morte a segnare la fine di Troia. Il lettore ne è consapevole, perché al pari di Omero è messo a parte della finalità nascosta della narrazione: Ettore invece crede, o vuol credere, di potercela fare «e allora per me è molto meglio o non tornare prima d’aver ucciso Achille, o perire davanti alla rocca, di sua mano, con gloria»; ed è solo piú avanti, quando scopre l’inganno di Atena e si rende conto che per lui è finita, che reagisce con queste parole: «ebbene, non senza lotta, non senza gloria morrò, ma avendo compiuto qualcosa di grande, che anche i futuri lo sappiano».
Noi sappiamo tutto, conosciamo in anticipo il futuro di Ettore e quello di Troia, e allora perché la partecipazione, la compassione, l’attesa per quel finale? È probabile che ciò che aspettiamo sia in realtà una conferma, meglio la «riconferma» di una certezza. Non è escluso che sia proprio questo a «placarci», l’idea cioè che il destino faccia il suo corso fino in fondo. Naturalmente, perché ciò possa accadere, c’è bisogno di un pattern, di una struttura di tipo narrativo: l’idea del duello vi rientra quindi perfettamente, e l’iterazione la rinforza. Prendiamo l’esempio di Harbig e Lanzi, due ottocentisti che fecero la storia della disciplina fra la fine degli anni Trenta e i primi anni Quaranta. Gli Italiani ne parlano come di un duello «infinito»; in realtà si trattò di un copione scritto e con le parti ben definite: si incontrarono ripetutamente, il tedesco si impose otto volte su dodici e nella gara considerata piú «eccitante», in occasione del record del mondo, lasciò il rivale a quasi tre secondi, un abisso che tuttavia non ha impedito la nascita del mito che riguarda entrambi.
Amiamo quindi che le attese trovino compimento e, in ciò, ci può capitare di amare nello stesso modo il vincente e il perdente. Non sapremo mai se Lanzi fosse cosciente della propria inferiorità, della sconfitta inevitabile, la stessa consapevolezza che si affaccia nella mente di Ettore prima degli attimi finali. Se cosí fosse lo ameremmo di piú, dell’amore di cui scrive Kavafis a proposito dei combattenti di Termopili: «E un onore piú grande gli è dovuto | se prevedono (e molti lo prevedono) | che spunterà da ultimo un Efialte | e che i Medi finiranno per passare».
Eppure qualche volta accade che due atleti siano davvero in equilibrio, che l’esito resti in dubbio. Siamo allora di fronte a un diverso tipo di pathos, che si nutre di «storia» piuttosto che di narratività. È quanto accadde verso la fine degli anni Settanta e nei primissimi Ottanta. Per quattro o cinque anni il rapporto di forze fra Sebastian Coe e Steve Ovett fu davvero molto equilibrato: dai campionati europei a quelli del Commonwealth, alle Olimpiadi, nella caccia ai primati mondiali, i due si inseguirono furiosamente scambiandosi vittorie e sconfitte. Furono duelli veri, dall’esito imprevedibile ed è forse per questa ragione che quel tempo può essere considerato come «l’età dell’oro» delle gare di mezzofondo.
Ma si tratta di occasioni rare. Keino e Ryun si incontrarono una mezza dozzina di volte, ma l’esito era sempre scontato: Ryun gli fu nettamente superiore nel suo periodo migliore, successivamente il dominio di Keino non fu mai in discussione. Quando Gebrselassie affrontava Tergat, c’era solo da chiedersi quando e come l’etiope si sarebbe liberato del grande avversario keniano, non se l’avrebbe fatto. Analogamente alle scorse Olimpiadi, dopo la sconfitta dei mondiali e le operazioni al tendine, era perlomeno probabile che Gebrselassie fosse nuovamente battuto da Bekele.
Naturalmente, se spezziamo l’involucro e ...