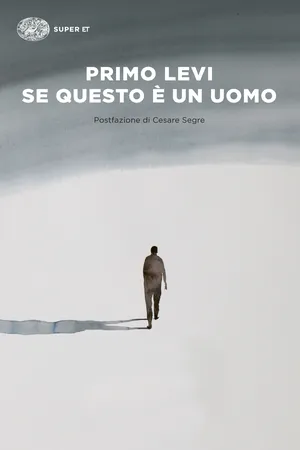
- 232 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Se questo è un uomo
Informazioni su questo libro
Testimonianza sconvolgente sull'inferno dei Lager, libro della dignità e dell'abiezione dell'uomo di fronte allo sterminio di massa, Se questo è un uomo è un capolavoro letterario di una misura, di una compostezza già classiche. È un'analisi fondamentale della composizione e della storia del Lager, ovvero dell'umiliazione, dell'offesa, della degradazione dell'uomo, prima ancora della sua soppressione nello sterminio.
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei «Saggi» e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo.
Primo Levi, reduce da Auschwitz, pubblicò Se questo è un uomo nel 1947. Einaudi lo accolse nel 1958 nei «Saggi» e da allora viene continuamente ristampato ed è stato tradotto in tutto il mondo.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Postfazione
Auschwitz, orribile laboratorio sociale
di Cesare Segre
1. Edizioni e redazioni.
Il libro, segnalato nel 1946 da Franco Antonicelli alla casa editrice Einaudi, venne rifiutato, e pubblicato nel 1947 nelle edizioni De Silva di Torino («Biblioteca Leone Ginzburg»), proprietà di Antonicelli. Solo nel 1955 Levi ripropone l’opera a Einaudi, che la pubblica nei «Saggi» (1958). Fra la prima e la seconda edizione Levi introdusse notevoli ampliamenti1, oltre a operare una completa revisione grafica, attenta in particolare a parole e nomi propri stranieri. L’intervento piú importante è l’aggiunta del capitolo [III] Iniziazione2; pure notevole, proprio all’inizio, il preambolo col breve racconto delle vicende di Levi prima dell’arrivo al campo di smistamento di Fossoli (Modena). Altre inserzioni intensificano il numero e il rilievo delle allusioni dantesche.
Senza dilungarsi sulle ristampe, va detto che Se questo è un uomo fu poi pubblicato, sempre da Einaudi, nei «Coralli» (1963); nei «Nuovi Coralli» (1971); nelle «Letture per la scuola media» (1973, con presentazione e note dell’autore; nella ristampa del 1976 fu aggiunta una fondamentale Appendice, poi riprodotta nel volume I delle Opere3; unito a La tregua, nei «Supercoralli» (1972) e in «Einaudi Tascabili» (1989). Infine, Se questo è un uomo apre il volume I delle Opere di Primo Levi nella «Biblioteca dell’Orsa» (1987) e il volume I delle Opere della «Nue», a cura di M. Belpoliti e con introduzione di D. Del Giudice (1997). Una versione drammatica, scritta da Levi con Pieralberto Marché, uscí nella «Collezione di teatro» (1966).
È ben piú che una curiosità la notizia che Levi, prima di Se questo è un uomo, aveva già pubblicato, con Leonardo De Benedetti, un Rapporto sulla organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz (Auschwitz-Alta Slesia) sulla rivista «Minerva medica»4. Un confronto con Se questo è un uomo sarebbe rivelatore.
2. La struttura.
2.1. Organizzazione dei capitoli.
Fondandosi naturalmente sulla redazione definitiva, si può descrivere cosí il libro: a una poesia dello stesso Levi messa ad epigrafe, e a una breve Prefazione, seguono diciassette capitoli non numerati: l’Appendice non fa parte dell’opera originale, ma è un’aggiunta risalente al 1976.
Seguendo i titoli e il contenuto dei capitoli, risulterà chiaro il disegno dell’opera.
[I] — Il viaggio. Premesse sulla cattura dell’autore. Sua prigionia nel campo di concentramento di Fossoli. La notte prima della deportazione; viaggio e arrivo ad Auschwitz.
[II] — Sul fondo. Primo contatto col Lager. Inserimento tra i prigionieri, compreso il tatuaggio del numero di matricola. Topografia del campo, in rapporto con la provenienza e le gerarchie dei prigionieri.
[III] — Iniziazione. La confusione delle lingue. Il rancio; il lavatoio e i problemi igienici.
[IV] — Ka-Be. Il lavoro. Levi è ricoverato in infermeria. Condizioni di vita nell’infermeria.
[V] — Le nostre notti. Rientro di Levi dall’infermeria ai capannoni del Block 45. Come passano le notti i deportati.
[VI] — Il lavoro. Descrizione di una giornata-tipo di lavoro al cantiere. Il problema delle latrine.
[VII] — Una buona giornata. Il paesaggio e i momenti di requie.
[VIII] — Al di qua del bene e del male. Economia del Lager: traffici, furti ed espedienti.
[IX] — I sommersi e i salvati. La lotta per la sopravvivenza nel Lager. Tipologia dei comportamenti fondata sul ritratto di quattro personaggi.
[X] — Esame di chimica. Levi, con altri compagni, viene condotto al Kommando Chimico per affrontare l’esame di chimica, in vista di un suo impiego nel Kommando.
[XI] — Il canto di Ulisse. Dopo la pulitura di una cisterna, durante il trasporto della zuppa, Levi recita e spiega al deportato francese soprannominato Pikolo il canto di Ulisse (Inferno, XXVI).
[XII] — I fatti dell’estate. Nell’agosto 1944 i bombardamenti alleati interrompono i lavori nel Kommando. Reazioni psicologiche dei civili tedeschi di fronte a una possibile sconfitta.
[XIII] — Ottobre 1944. Sofferenze portate dall’inverno e intensificazione delle selezioni per il crematorio.
[XIV] — Kraus. Continuano le sofferenze per il freddo. Episodio del deportato Kraus.
[XV] — Die drei Leute vom Labor. Altri lavori pesanti nel Kommando. Levi è scelto come operaio specializzato. Rapporti col personale civile del laboratorio.
[XVI] — L’ultimo. Espedienti quotidiani. L’impiccagione di un ammutinato.
Ho differenziato con caratteri spaziati le parti del libro di carattere piú descrittivo o riflessivo, lasciando in spazio normale quelle narrative, diaristiche. Appare subito che lo schema del diario è prevalente all’inizio (capitoli [I] e [II], e, parzialmente, [IV] e [V]) e dopo la metà del libro (dal [X] al [XVII]), con rare emergenze negli altri capitoli. Questo permette di ritenere che, precisando una dichiarazione di Levi stesso5, gli ultimi capitoli siano stati scritti per primi, allo scopo di fissare immediatamente l’ordine dei ricordi, mentre i precedenti sono il risultato di un’organizzazione generale, un intenso trattato sulla vita (e la morte) nel Lager (e per altre osservazioni sulla struttura del testo cfr. § 4.1). Naturalmente l’inizio è pure diaristico; ma non a caso la prima pagina, come s’è detto, è stata aggiunta solo nella seconda edizione.
2.2. Se questo è un uomo e gli altri scritti di Levi sul Lager.
Questo è il primo libro di Levi, chimico di vasta cultura anche umanistica ma senza ambizioni letterarie, almeno sino allora. Seguirono invece numerosi altri saggi, racconti e romanzi, e Levi finí per abbandonare il suo primario mestiere e farsi esclusivamente scrittore. Con una tematica molto varia, ma spesso ritornante al periodo decisivo del Lager. Nell’ordine, ricorderò che La tregua (1963), racconto del complicato e avventuroso ritorno in Italia dello scrittore, è una vera e propria continuazione di Se questo è un uomo, e nei primi due capitoli (Il disgelo e Il Campo Grande), oltre che nell’inizio del terzo (Il greco), si svolge ancora ad Auschwitz. Il sistema periodico (1975) contiene capitoli (Cerio e Vanadio) in cui si rievoca ancora l’amicizia con Alberto, in Buna-Auschwitz, e si narrano i contatti epistolari, occorsi nel 1967, col dottor Lothar Müller, che nel Lager controllava a volte il lavoro di Levi nel laboratorio. Gran parte delle poesie de L’osteria di Brema (1975) si riferiscono all’esperienza concentrazionaria (Buna, Shemà, Alzarsi, Ostjuden, Il tramonto di Fòssoli, ecc.), che ritorna ancora nelle poesie successive, come Nachtwache6. Passando a Lilít (1981), s’incontrano capitoli come Il nostro sigillo, in cui si rivede l’Elias del capitolo [IX] di Se questo è un uomo, e Il ritorno di Lorenzo, un lavoratore civile che ad Auschwitz aveva aiutato moralmente, e praticamente nutrito Levi, rischiando la vita (Se questo è un uomo, capitolo [XII]). Non meno ricco Racconti e saggi (1986), con i capitoli Auschwitz, città tranquilla, sul dottor Mertens, chimico e «buon» cittadino tedesco, il cui comportamento nel laboratorio di Buna mostrò la sua viltà; Pipetta da guerra, con un episodio di Lager; Un ‘giallo’ del Lager, incontro con la famiglia di un personaggio secondario di Se questo è un uomo; Il comandante di Auschwitz, sul maggiore Richard Baer, che intascava il meschino salario versato dalla I. G. Farbenindustrie per gli schiavi del laboratorio, perciò anche per Levi. Infine, e soprattutto, va citato I sommersi e i salvati (1986), che riprende il titolo del capitolo [IX] di Se questo è un uomo, e la problematica morale di tutto il libro. Va poi notato che Se non ora, quando? (1982) è in certo modo il risarcimento di quanto rievocato in Se questo è un uomo: l’autore partecipa, mediante il suo racconto, alle imprese di un gruppo di partigiani ebrei che lottano contro i tedeschi, fra Bielorussia e Ucrania, portando a termine il progetto resistenziale (implicante uno scontro diretto con i tedeschi) che la cattura impedí a Levi di mettere in atto. La simmetria è sottolineata da due elementi: l’inizio di entrambi i libri con un Se, e il fatto che mentre Se questo è un uomo è veritiero in ogni parte ed esclude l’invenzione, l’altro libro, pur basato su fatti storicamente documentati, è inventato in tutti i particolari.
3. La tematica.
3.1. Motivazioni della scrittura.
Il libro di Levi ha ambizioni piú alte che quella di contribuire alla letteratura sui campi di annientamento. Egli dichiara nella Prefazione che intende «fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano». Nello stesso tempo denuncia, sempre nella Prefazione, le conseguenze di ogni concezione xenofoba. Quando essa diventi un «sistema di pensiero», «quando il dogma inespresso diventa premessa maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager». Riconosce infine il bisogno di «liberazione interiore», conseguenza dell’«impulso immediato e violento» a raccontare la propria esperienza. Dunque quattro scopi: 1) documentare un’esperienza estrema; 2) mostrare, anche per poterle prevenire, le peggiori conseguenze della xenofobia; 3) meditare sul comportamento umano in condizioni eccezionali; 4) raccontare per liberarsi dell’ossessione.
Altro ci dice la poesia che fa da epigrafe al volume. Essa è riportata senza titolo, e fu pure pubblicata ne L’osteria di Brema (1975), col titolo Shemà. Essendo datata 10 gennaio 1946, dev’essere stata scritta durante la stesura di Se questo è un uomo, datato dicembre 1945 - gennaio 1947. Va premesso che shemà è l’orazione fondamentale degli ebrei, una specie di atto di fede (inizia con le parole: «Ascolta, Israele, il Signore Dio nostro è uno»; termina con l’esortazione a non dimenticare, e a trasmettere ai figli, questa nozione basilare). Nella poesia di Levi l’atto di fede manca; al contrario, si sviluppa il tono esortativo, dal Voi iniziale, ripreso anaforicamente nel terzo verso, agli imperativi Considerate (due volte), Meditate, Scolpitele, Ripetetele (in particolare i vv. 16-19 sono traduzione fedele del testo ebraico: «queste parole | scolpitele nel vostro cuore | stando in casa andando per via, | coricandovi alzandovi»); e si conclude con una specie di maledizione per chi non obbedirà. A che cosa? All’obbligo del ricordo.
I vv. 5-14 contengono una sintesi della vita e della morte nel Lager: 5 versi per gli uomini, 5 per le donne. Importante per noi la forma sintattica: «Considerate se questo è un uomo […]». Cosí il titolo del libro (che fu suggerito da Antonicelli; Levi pensava a usare il titolo del capitolo [IX]) assume la sua completa potenzialità: invito a riflettere sull’offesa all’uomo esercitata dal Lager; e in generale sulla disumanizzazione degli schiavi ad opera dei bestiali aguzzini. C’è un’inumanità che dal centro travolge tutti. L’esortazione a meditare e ricordare non è solo un omaggio alle vittime, ma la base per prevenire una possibile ripetizione dell’orrore.
Il ricordo come bisogno e come obbligo. Lo dichiara anche il volitivo ex sergente Steinlauf: «si deve voler sopravvivere, per raccontare, per portare testimonianza». Ciò significa anche render note verità che nella vita comune ci nascondiamo, e che hanno conseguenze decisive nella visione della realtà; comunicarle è «portare al mondo, insieme col segno impresso nella carne, la mala novella di quanto, ad Auschwitz, è bastato animo all’uomo di fare dell’uomo»: un vangelo negativo, che smentisce quello storico cosí come il numero tatuato sul braccio contiene piú verità della Bibbia.
Che Levi abbia usato un atto di fede tradizionale sostituendo al suo fulcro ideologico (esistenza e unità di Dio) l’obbligo del ricordo della Shoah, è significativo della sua posizione di non credente e della sua fede laica nei valori umani di cui pure ha sperimentato la fragilità. Il rispetto dell’imperativo kantiano non può prescindere dalla consapevolezza che gruppi politici o nazionali possono continuamente attentare all’imperativo stesso. Descrivendo vari tipi di comportamenti degli Häftlinge, dei prigionieri, Levi addita come principale colpa dei nazisti l’aver reso meno uomini, o non uomini, le loro stesse vittime («il Lager è una gran macchina per ridurci a bestie, noi bestie non dobbiamo diventare»). Alla fine, quando la liberazione s’intravvede e gli aguzzini infieriscono maggiormente, i prigionieri si rifugiano nel «torpore opaco delle bestie domate con le percosse, a cui non dolgono piú le percosse». I nazisti hanno voluto costruire una macchina che rendesse abietti gli esseri, prima di tutti gli ebrei, che già erano stati preliminarmente dichiarati abietti.
Poesia e Prefazione preannunciano in sostanza il sapiente accostamento tra modi di comunicare: se alla base c’è il ricordo (e relativa narrazione), circonfuso di sentimenti e atmosfere, poi si fa udire il giudizio, pacato e inesorabile, e vibra l’esortazione al lettore, perché rifletta, consideri, deduca. S’alternano dunque, in modo complesso, rammemorazione e referenzialità, emotività e valutazione, persuasione e ammonimento. Anche grammaticalmente, i segni di quest’alternan...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Se questo è un uomo
- Prefazione
- Il viaggio
- Sul fondo
- Iniziazione
- Ka-Be
- Le nostre notti
- Il lavoro
- Una buona giornata
- Al di qua del bene e del male
- I sommersi e i salvati
- Esame di chimica
- Il canto di Ulisse
- I fatti dell’estate
- Ottobre 1944
- Kraus
- Die drei Leute vom Labor
- L’ultimo
- Storia di dieci giorni
- Appendice a «Se questo è un uomo»
- Postfazione. ‘Auschwitz, orribile laboratorio sociale’ di Cesare Segre
- Cronologia della vita e delle opere di Primo Levi
- Il libro
- L’autore
- Dello stesso autore
- Copyright
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a Se questo è un uomo di Primo Levi in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Biografie in ambito storico. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.