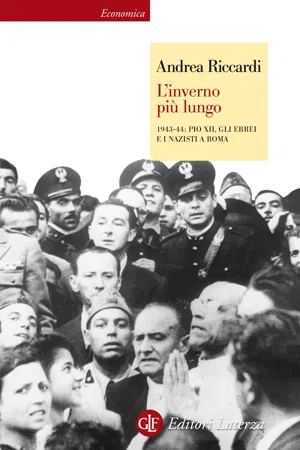X. Tra organizzazione e spontaneità
La più grande organizzazione ebraica
La vita clandestina a Roma ebbe un importante protagonista ebraico: la Delasem, che nel maggio 1944 arrivò a aiutare circa duemilacinquecento persone. Era una grande rete che consentiva il mantenimento degli ebrei nella clandestinità. Molti beneficiati erano non romani, non in grado di attivare da soli risorse minimali di vita nella città. Molti erano arrivati dalla zona francese occupata dall’Italia, dopo che l’armistizio dell’8 settembre aveva fatto fallire il progetto del trasferimento degli ebrei francesi dell’area in Nord Africa1.
La Delasem aveva sede a Roma vicino all’ufficio dell’Unione delle Comunità Israelitiche. Dopo l’ottobre 1943, entrò in clandestinità. Anima della Delasem a Roma fu Settimio Sorani, che ha narrato la sua storia. È un capitolo su cui fortunatamente si possiede una vasta bibliografia. Sorani tenne una documentazione sull’attività. Una sua relazione del 16 maggio 1944, afferma che gli ebrei assistiti erano al momento 2532: tra essi 250 polacchi, 300 italiani, 300 jugoslavi, 800 romani e via dicendo2. Il 7 settembre 1943 Sorani si incontrò, sulla scalinata di San Pietro, con Angelo Donati (nipote di Salvatore Donati, consigliere dell’Unione e impegnato nell’assistenza ai profughi ebrei) e con padre Benoît o Benedetto, cappuccino francese attivo per gli ebrei nella Francia occupata dagli italiani e spostatosi a Roma (egli aveva ragionato su di un progetto di trasferimento degli ebrei in Africa del Nord). Sorani, Donati e il cappuccino sarebbero stati protagonisti dell’attività clandestina.
Padre Benoît fu un collaboratore decisivo della Delasem che accolse nel convento cappuccino di Via Sicilia. Qui aveva la possibilità di utilizzare due diversi ingressi; vi venne trasportato l’archivio, poi spostato presso i carmelitani per motivi prudenziali. Il cappuccino aveva l’approvazione del generale dell’ordine. Il parlatorio del convento divenne un punto d’approdo per gli ebrei che cercavano il «padre degli ebrei» o «padre Benedetto»3. Dai cappuccini si riuniva talvolta il comitato della Delasem, che comprendeva il presidente Sorani e Giuseppe Levi come italiani, Stephan Schwamm e Aaron Kaszterztein venuti dalla Francia. Ad essi si aggiungeva padre Benoît. Vicino al convento c’era la famigerata pensione Jaccarino, dove si torturavano i prigionieri. Ma l’attività della Delasem a Via Sicilia non ebbe grossi problemi, nonostante la prossimità a questo luogo.
Padre Benedetto e Donati, quando incontrarono Sorani a San Pietro, erano reduci da un colloquio con mons. Hérissé in Vaticano, che teneva i contatti con i diplomatici britannici e americani. L’ecclesiastico francese ebbe un ruolo importante nei rapporti tra Delasem, diplomatici e ambienti vaticani. Era un canale decisivo per il sostentamento dell’attività clandestina. Con l’aiuto dei diplomatici, giunse il sostegno finanziario dell’American Joint Distribution Committee. Sembra che anche Montini abbia favorito il transito dei fondi attraverso il Vaticano4. Il problema finanziario era decisivo. Un primo fondo fu fornito dal presidente dell’Unione, Dante Almansi. Le elargizioni più cospicue furono fatte dall’American Joint Distribution Committee. La Santa Sede non dette contributi diretti, ma molti fondi transitavano all’ombra delle mura leonine. Qui Sorani si recava con padre Benedetto per incontrare i diplomatici alleati e incassare fondi. Spesso, con l’aiuto di Hérissé, Sorani e il cappuccino riuscivano ad ottenere anticipi e prestiti. Le risorse venivano distribuite ai rifugiati in questo modo:
Perché tutti gli assistiti italiani e non – racconta Sorani – potessero essere raggiunti e per avere gli importi a ciascuno assegnati, senza correre molti rischi, avevo stabilito che ogni persona addetta a tale compito avvicinasse non più di dieci persone e lo facesse per la strada, fissando gli appuntamenti in luoghi diversi di volta in volta. Agli angoli delle strade, o nei caffè, ci si incontrava...5.
Padre Benoît aveva accesso facile in Vaticano e all’ufficio del Sostituto, che seguiva la sua attività. Ancora nel novembre 1943, padre Benoît sperava di poter ottenere un salvacondotto per gli ebrei immigrati a rischio di cattura. Aveva elaborato un testo di cui voleva ottenere la legalizzazione dall’ambasciata tedesca. Chiese a Montini una presentazione all’ambasciata. Ma la Segreteria prudentemente lo sconsigliò: «sarebbe pericoloso più che vantaggioso»6. In una nota della Segreteria, il 5 gennaio 1944 si legge: «Fin dall’arrivo in Roma di questo gruppo di ebrei, la Santa Sede se ne è occupata, fornendo al padre Benedetto... denaro e derrate alimentari»7.
Dove mettere tanti rifugiati in una città occupata? Sorani li fece sistemare in alberghi, pensioni, case private, conventi. C’erano conventi che appoggiavano la Delasem, come si legge nella relazione delle clarisse francescane: «la casa offrì asilo ad oltre una sessantina di ebrei e perseguitati e politici. In quel periodo fu centro di assistenza agli ebrei stranieri. Assistenza organizzata da padre Benedetto dei cappuccini di Via Sicilia. Si distribuiscono soccorsi e vi fu qui un ambulatorio per bambini e malati curati da un medico ebreo polacco»8. I profughi erano divisi in piccoli gruppi per evitarne l’individuazione9. Bisognava assisterli e sostenerli economicamente. Ma il problema essenziale era la fabbricazione di una nuova identità. A questo proposito padre Benoît operò a contatto con varie rappresentanze consolari e diplomatiche. Il cappuccino si era fatto dichiarare «presidente di un comitato di assistenza profughi in formazione» da un documento a firma di mons. Dionisi del Vicariato. Questo gli dava una parvenza di ufficialità.
Il consolato svizzero (che rappresentava gli interessi francesi), diretto da Marc Chauvet (con la consulenza legale di Sommaruga), rilasciò quattrocento e più «lettere di protezione» e biglietti a stampa da collocare sulla porta dell’abitazione, con lo stemma della Confederazione, per affermare che la casa era sotto protezione consolare. Anche Sommaruga operò per nascondere alcuni ebrei, tra cui Oscar Sinigaglia e sua moglie, sia nella sua casa che in una villa in sua custodia. Tramite lui furono fatti dei passi in Svizzera per Mafalda di Savoia10.
Per proteggere gli ebrei della Delasem furono anche fabbricati documenti francesi. Ci fu pure il contributo dell’ambasciatore di Romania, Grigorcea. Al rilascio dei documenti collaborò il consigliere consolare ungherese Vitéz Szász. Padre Benoît ricorda che il consolato ungherese era impegnato «à fabriquer des hongrois à tout vapeur»11. Un contributo importante fu dato dal conte De Salis che rappresentava il comitato internazionale della Croce Rossa a Roma, in contatto con la Delasem e con il Vaticano. Egli fece liberare un’ebrea polacca di sette anni da Regina Coeli grazie ai rapporti con i tedeschi. Così fece anche per altri ebrei12. Importante fu il lavoro della legazione jugoslava, guidata da Cyril Kotnik, pure arrestato dai tedeschi. Nella sua casa Settimio Sorani fu catturato per essere portato a Via Tasso, dove fu rilasciato: era andato a portargli un memoriale da consegnare al papa13. C’era un tessuto di diplomatici e consoli, un mondo di volenterosi, che andrebbe indagato per cogliere come contribuì a sostenere la rete clandestina. È un tessuto che si colloca in una Roma in cui un gruppo di persone da una parte manteneva un rapporto con le autorità occupanti o con i fascisti, ma dall’altra operava clandestinamente.
La fabbricazione delle carte d’identità e di altri documenti si svolgeva anche nel convento cappuccino di Via Sicilia sotto la direzione di padre Benedetto. Altrove furono fatte le carte annonarie, godendo pure dell’appoggio di impiegati comunali e della documentazione del Vicariato, firmata da mons. Dionisi14. Gli ebrei, arrivando a Via Sicilia, avevano la sensazione di un’organizzazione efficace. Mario Tagliacozzo, che aveva dovuto abbandonare il suo rifugio dopo l’invasione di San Paolo, aveva avuto esperienze deludenti. Era stato confortato dal biblista padre Ricciotti, il quale però non riuscì a procurargli un asilo. Quando arrivò in Via Sicilia fece un’esperienza positiva: «ci siamo accorti – scrive – che è una catena di indirizzi di religiosi che si allarga sempre più». Così si aprì la via di rifugio per lui e la famiglia15. La figura del cappuccino, come si vede anche dall’accoglienza entusiastica al Tempio maggiore dopo la liberazione di Roma, grandeggia nell’immaginario e nell’esperienza degli ebrei in quei mesi. Claire Mandel, un’ebrea aiutata da padre Benedetto, in una lettera dopo la liberazione, ringrazia per l’opera dei cappuccini: «bell’ideale di carità fraterna... verso tutti gli uomini, nel più puro spi...