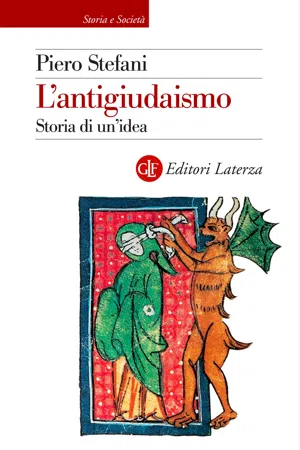Capitolo II
IL NUOVO TESTAMENTO:
UNA CHIESA FORMATA DI GIUDEI E DI GRECI
Vi sono alcuni grandi fattori che, sulle prime, sembrano indurre a rispondere senza esitazione in modo affermativo alla domanda se il Nuovo Testamento sia contraddistinto da un robusto antigiudaismo. In questo novero spiccano due constatazioni difficili da smentire: la prima è che questi scritti sono disseminati di affermazioni polemiche, e non di rado violente, nei confronti di gruppi ebraici; la seconda è che, nel corso dei secoli, tali passi hanno alimentato, se non pesantemente ispirato, le idee e le prassi antigiudaiche cristiane. Il ruolo di questi fattori è rafforzato dalla riproiezione sugli scritti neotestamentari del peso determinante assunto in epoca successiva dal rifiuto ebraico di Gesù Cristo. In maniera più o meno esplicita si dipana un ragionamento di questo tipo: premesso che per l’antigiudaismo cristiano la massima colpa ebraica consiste nel non aver accolto Gesù come Messia e constatato che nei vangeli, nelle lettere di Paolo e in altri testi neotestamentari si dà gran spazio a quest’accusa, si è obbligati a concludere che quegli scritti sono per la massima parte antigiudaici. Inoltre in certi brani neotestamentari sembra possibile individuare, in relazione a quel rifiuto, alcune delle motivazioni, compresi l’attaccamento letterale alla Legge e la presenza di una concezione messianica ebraica tutta terrena, che sarebbero state vere e proprie costanti dell’antigiudaismo cristiano. La legittimità o l’illegittimità dell’impiego antiebraico di passi neotestamentari dipende, in buona misura, dall’approvazione o dalla confutazione del nucleo argomentativo ora esposto.
In anni recenti, nei confronti di queste accuse, sono state adottate, pure in sede ufficiale, varie linee a un tempo di difesa e di precisazione. Innanzitutto si è rilevato che gli acuminati strali critici antiebraici contenuti nel Nuovo Testamento si rivolgono sempre a gruppi giudaici (per esempio gli scribi, i farisei o le gerarchie sacerdotali) e non alla totalità del popolo. Un secondo ordine di fattori individua nei contrasti evangelici tra Gesù e alcuni suoi contemporanei una proiezione all’indietro degli scontri e delle tensioni avvenuti tra comunità ebraiche e cristiane nello scorcio finale del I secolo. Infine, si pone in rilievo che un linguaggio violentemente accusatorio nei confronti degli ebrei è abbondantemente testimoniato anche nelle Scritture ebraiche (divenute Antico Testamento all’interno della Bibbia cristiana). Queste osservazioni, invero, sono sembrate troppo caute, specialistiche e in definitiva marginali a molti di coloro che colgono l’enorme portata storica e teologica di un problema arduo da risolvere con gli strumenti della pura acribia storico-critica. Articolare il discorso lungo le pur plausibili, e per più aspetti indispensabili, linee appena prospettate, resta operazione parziale se non ci si confronta con il nucleo fondamentale costituito dalla messianicità di Gesù e dal senso attribuito alla sua morte, alla sua resurrezione e al titolo di Figlio di Dio e di Signore (Kyrios) a lui riservato (cfr. Rm 1, 4).
Per affrontare a viso aperto il problema della presenza di una ipotetica o reale componente antigiudaica all’interno degli scritti del Nuovo Testamento occorre misurarsi, oltre che con la ricostruzione storica della loro genesi, anche e soprattutto con il loro statuto teologico. Il compito principale è quindi misurarsi con l’asserto radicale secondo cui l’accusa mossa agli ebrei di aver rifiutato Cristo costituisca sia «il braccio sinistro della cristologia»1, sia la genesi prima dell’antigiudaismo cristiano. In mancanza di tale operazione tutte le altre linee di condotta risultano semplici palliativi incapaci di intaccare il costitutivo antiebraismo neotestamentario. Se si vuole confutare questa ipotesi bisogna dunque prendere di petto la questione che si chiede se già negli scritti protocristiani sia presente una divaricazione insanabile tra fede in Gesù Cristo e appartenenza ebraica; in definitiva se, già allora si poteva affermare quanto in seguito sarebbe diventato un asse portante dell’antigiudaismo cristiano: considerare il colpevole rifiuto di accettare Gesù come Messia parte integrante della definizione di ebrei.
1. La nascita della Chiesa nell’orizzonte del variegato ebraismo del I secolo
È affermazione storicamente e teologicamente incontestabile che i primi credenti in Gesù Cristo morto, risorto e proclamato Signore a gloria di Dio Padre (cfr. Fil 2, 2, 1-11) fossero e si considerassero ebrei. Allo stesso modo è certo che l’ebraismo del I secolo d.C. fosse ricco di gruppi e correnti in aspra polemica reciproca. La galassia formata da scribi, sacerdoti, farisei, sadducei, zeloti, esseni, seguaci della comunità di Qumran2, apocalittici, ellenisti, movimenti battistici e così via indica la presenza all’interno del popolo ebraico di una varietà molto accentuata di orientamenti. Anzi, si è sostenuto che la caratteristica fondamentale del giudaismo nell’arco di tempo esteso dal III secolo a.C. al II secolo d.C. sia stato «il convivere di una pluralità di gruppi, movimenti e tradizioni di pensiero, in un rapporto dialettico talora anche aspramente polemico ma non separato»3. In quell’epoca la frammentarietà fu così marcata che a volte è sembrato un problema non piccolo indagare sull’esistenza di un «ebraismo comune», vale a dire individuare prassi e credenze da tutti condivise4. In questo contesto, a un numero crescente di studiosi pare ovvio concludere che il movimento nato attorno alla figura di Gesù, ebreo della Galilea5, possa essere considerato dal punto di vista storico-culturale una corrente giudaica di orientamento apocalittico. Un secolo fa risultava ardito parlare dell’ebraicità di Gesù e assurdo attribuirla a Paolo o Giovanni6; oggi, al contrario, appare sempre più improprio non estenderla anche all’epistolario paolino e alla scuola giovannea. All’interno dell’ebraismo di quel tempo c’è dunque posto anche per i nazirei (nozrim)7, termine con cui nel giudaismo dei primi secoli vennero in genere chiamati una parte dei seguaci di Gesù.
Questa operazione, incontestabile allorché individua la presenza di un marcato pluralismo interno al mondo ebraico, appare concettualmente troppo irenica quando scivola nell’implicito presupposto che una simile molteplicità di correnti fosse espressione più di un riconoscimento reciproco che di un duro scontro su chi dovesse essere qualificato come «vero figlio di Israele». Un simile contenzioso, tutt’altro che ignoto agli scritti neotestamentari, trova ampia rispondenza nell’intero ebraismo di quel tempo in cui in più luoghi si stava discutendo quali fossero le maniere per discernere l’autentica appartenenza alla stirpe di Abramo. Per quanto la fonte, dal punto di vista storiografico, vada assunta con cautela, il fatto che il vangelo di Matteo alluda a simili dibattiti in relazione a un confronto polemico tra Giovanni Battista (il Precursore) e i farisei e i sadducei («e non crediate di poter dire fra voi: Abbiamo Abramo per padre. Vi dico che Dio può far sorgere figli di Abramo da queste pietre», Mt 3, 9) costituisce una spia significativa della loro natura effettivamente intragiudaica. L’ambientazione narrativa scelta da Matteo lascia infatti trapelare che questi temi sono anteriori all’entrata in scena di Gesù e degli apostoli. Faceva, per esempio, parte dell’autocoscienza del gruppo di Qumran considerarsi l’unica espressione autentica dell’intero ebraismo.
Secondo autorevoli interpreti la confraternita qumranica va ritenuta una vera e propria setta, vale a dire una comunità che reputa se stessa l’unico, vero Israele mentre considera apostati tutti gli altri ebrei. Un partito, a differenza di una setta, pur essendo dotato di convinzioni e prassi specifiche, non sostiene invece di essere tutto Israele, cosicché i suoi membri costituiscono un gruppo entro il giudaismo comune piuttosto che un’alternativa a esso8. Adeguandoci a questa terminologia, ci si può chiedere se i primi seguaci di Gesù Cristo si considerassero in termini di setta o di partito o di altro ancora. A qualcuno pare necessario optare per la prima alternativa. Per quanto sia indubbio che i più antichi credenti in Cristo fossero e si considerassero ebrei, resta evidente che per loro l’evento decisivo era costituito dal riconoscimento che Gesù era il Messia. Da ciò sarebbe stata tratta una conclusione ben definita: «se Gesù è il Messia inviato da Dio al suo popolo Israele, e se una parte del popolo lo riconosce e un’altra no, allora quelli che lo riconoscono sono il ‘vero’ Israele, gli altri invece non lo sono o comunque non lo sono più»9. L’orizzonte in cui è formulata questa affermazione non corrisponde però alla dinamica attestata dal Nuovo Testamento. Infatti se è certo che i membri delle prime comunità cristiane – a iniziare dalla cosiddetta Chiesa madre di Gerusalemme – furono e si considerarono ebrei, è altrettanto sicuro che una caratteristica precocissima della predicazione evangelica fu di rivolgere il buon annuncio anche ai gentili (vale a dire ai non ebrei). Affermare ciò non significa sostenere che tutti i seguaci di Gesù si impegnassero in prima persona a portare l’annuncio ai non ebrei. Anzi, le modalità di questa missione, nella quale si distinsero i credenti in Cristo provenienti dal giudeo-ellenismo, furono motivo di aspri dibattiti tra i credenti. Rimane comunque indiscutibile che quanto distinse molte Chiese nascenti (le comunità avevano dimensione locale) da tutti gli altri movimenti ebraici coevi fu non tanto la presenza di novità dottrinali o etiche quanto il fatto che, in virtù dell’accoglimento di un evento messianico, si erano costituite comunità formate sia da ebrei sia da non ebrei. Proprio questa dimensione rende arduo considerare la nascita delle comunità sotto la categoria del «vero Israele», qualifica che sarebbe adatta a una Chiesa formata o da soli ebrei o da soli gentili che si pensano subentrati al popolo che ha rinnegato il suo Messia.
Molte varietà e differenziazioni si trovano pure nelle Chiese primitive; ed è stata soltanto l’opera uniformante del canone – stabilitosi non prima del III secolo – a far sì che gli scritti protocristiani raccolti nel Nuovo Testamento facciano parte di un insieme unitario. I libri neotestamentari differiscono tra loro sia per genere letterario (vangeli, atti, lettere, apocalisse) sia per epoca in cui furono composti (secondo le datazioni più consuete l’arco temporale si estende dalla metà del I secolo ai primi del II secolo). Per affrontare in modo storicamente corretto il problema di un presunto o reale antigiudaismo neotestamentario bisognerebbe quindi articolare il discorso su più piani e tener in gran conto anche i differenti scopi per cui furono redatti i vari scritti. Non è però illecito tentare una generalizzazione: per tutti, sia pure con diverse reciproche sfumature, resta sostanzialmente vero che il problema cruciale non s’incentra né sulla polemica contro un supposto legalismo farisaico, né su una ipotizzata responsabilità giudaica rispetto alla condanna a morte di Gesù (temi presenti, ma, in ultima analisi, non fondamentali). La questione davvero di fondo verte piuttosto sulle conseguenze da trarre dalla nascita di Chiese che radunavano in loro stesse ebrei e non ebrei.
2. L’orizzonte messianico
Per comprendere la portata attribuita alla presenza di comunità cristiane «miste» formate da ebrei e gentili bisogna abbandonare tanto l’idea che il loro sorgere costituisse la prima manifestazione dell’«universalismo cristiano», quanto la supposizione che questo rivolgersi ai non ebrei rappresenti una precoce manifestazione di «ellenizzazione» del cristianesimo. Lo schema concettuale entro cui va inteso l’annuncio alle Genti rimane quello della speranza messianica ebraica. Se la fonte dell’antigiudaismo consistesse nel muovere alla «massa» degli ebrei l’accusa di non aver avuto fede in Gesù Cristo morto e risorto non vi sarebbe dubbio alcuno che tutti gli scritti del Nuovo Testamento dovrebbero essere ritenuti la radice prima dell’ostilità cristiana nei confronti degli ebrei. Tale esito può apparire scontato se confrontato con una situazione storico-culturale in cui gli ebrei sono definiti appunto come coloro che non credono in Cristo, mentre i cristiani sono quelli che vi credono. Tuttavia questa situazione troverebbe un effettivo riscontro nei testi solo se già a quell’epoca tutti gli ebrei non avessero creduto in Cristo e tutti coloro che avevano fede in Gesù fossero stati non ebrei: ciò è esattamente quanto non avviene nel Nuovo Testa...