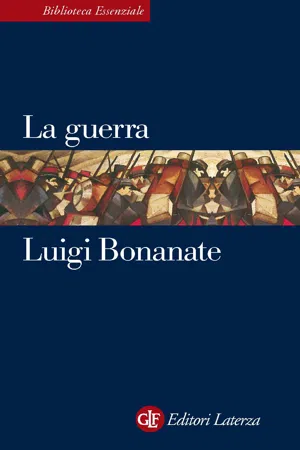
- 172 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
La guerra
Informazioni su questo libro
Cos'è la guerra? Come e perché si fa? Come funzionano le 'nuove guerre' e che relazione hanno con quelle del passato? Un'analisi antropologica, storiografica e filosofica sulle ragioni e il significato che la guerra ha nella storia dell'umanità.
Tools to learn more effectively

Saving Books

Keyword Search

Annotating Text

Listen to it instead
Informazioni
Che cosa significa la guerra
1. Un risultato deludente?
Nei tre capitoli precedenti abbiamo perseguito il progetto di comprendere a pieno il senso della guerra, utilizzando, per così dire, una tecnica di aggiramento: avevamo sperato che descrivendone storia, modalità e intreccio con le altre dimensioni dell’evoluzione delle società umane, saremmo giunti a qualche chiarimento; ci siamo poi chiesti se, osservandone le tecniche, ovvero le regole strategiche che ne guidano l’effettuazione, saremmo riusciti a cogliere un maggior numero di aspetti; ma comunque pensavamo che la riflessione sulle cause ci avrebbe infine soddisfatti: il «perché» non è pur sempre il modo più diretto per affrontare una questione? Ma nulla di definitivo è sgorgato, anche da questa ricerca. Possiamo ripeterci che, eppure, una qualche risposta deve esserci, o saremo indotti a riconoscere che la pagina della Repubblica in cui Platone (427-347 a.C.) si pone le stesse domande abbia ancora oggi lo stesso valore? Ecco l’opinione di Socrate:
a quanto sembra, non vogliamo soltanto sapere come nasce uno stato, ma uno stato gonfio di lusso. Forse però non è male, perché così vedremo probabilmente come nascono negli stati giustizia e ingiustizia. Lo stato vero è, a mio giudizio, quello di cui abbiamo parlato ora, uno stato sano. Ma se voi volete che consideriamo anche uno stato rigonfio, nulla ce lo impedisce. Ad alcuni, sembra, questo non basterà; né basterà questo genere di vita, ma vorranno inoltre letti e tavole e altre suppellettili e pietanze e incensi e profumi ed etère, e ciascuna di queste cose in grande varietà. […] Bisogna dunque ingrandire ancora di più lo stato, perché quello sano non basta: si deve accrescerlo di mole e riempirlo di una massa di gente la cui presenza negli stati non è più imposta dalla necessità […]. Avremo poi bisogno di un maggiore numero di servi […]. Tutto questo non c’era nel nostro stato di prima, non essendoci bisogno alcuno, ma occorrerà in quest’altro. […] E quel territorio che prima era sufficiente a nutrire i suoi abitanti, da sufficiente sarà diventato piccolo […]. E non dovremo prenderci una porzione del territorio dei vicini se vorremo avere terra sufficiente per pascolare e arare? e non dovranno essi pure prendersene del nostro, se covano anche loro sconfinata brama di ricchezza, oltre il limite del necessario? […] E allora, Glaucone, faremo la guerra? […] E facciamo pure a meno di dire, soggiunsi, se la guerra sia fonte di male o di bene. Contentiamoci di dire che ne abbiamo scoperto la genesi in quella che per gli stati è la massima fonte di mali privati e pubblici (La repubblica, II, 372 e-373 e).
È facile intuire quanto l’ironia platonica potrebbe ancora esercitarsi anche oggi nel descrivere la vanità e l’inutilità di quei nostri desideri, che finiscono quasi sempre per superare «il limite del necessario». Nella semplicità dell’argomentazione non sembra ritrovarsi una perentorietà che ci lascia senza parole, per la sua indiscutibilità? O dovremo riconoscerci ben più superbi di de Maistre che si rifugiava nell’inconoscibile e nell’imperscrutabile? Ascoltiamo la sua enfasi retorica:
la guerra dunque è divina in se stessa, poiché è una legge del mondo. La guerra è divina, inoltre, a causa delle sue conseguenze di ordine soprannaturale, sia generali sia particolari; conseguenze poco conosciute perché poco studiate, ma non per questo meno incontestabili. […] La guerra è divina nella protezione che accorda ai grandi condottieri […]. La guerra è divina per il modo in cui è dichiarata. […] La guerra è divina nei suoi risultati, che sfuggono totalmente alle speculazioni della ragione umana, perché possono essere completamente diversi anche per due nazioni per le quali l’azione della guerra si sia mostrata uguale. […] La guerra è divina per l’indefinibile forza che ne determina i successi (Le serate di Pietroburgo, pp. 399-401, passim)1.
O ancora perché non rassegnarci alla limpida premonizione hegeliana?
Dalle guerre risultano non soltanto rafforzati i popoli; ma nazioni, che sono in discordia in sé, acquistano, mediante guerre all’esterno, pace all’interno. Certamente, dalle guerre proviene la malsicurezza nella proprietà, ma questa malsicurezza è null’altro che il movimento, il quale è necessario. […] Ma, se questa malsicurezza viene realmente in campo, in forma di ussari con sciabole luccicanti, ed è, quindi, cosa seria, allora quella commossa edificazione che prediceva ogni cosa, si converte nel profferire maledizioni sopra i conquistatori. Però, malgrado ciò, le guerre hanno luogo quando esse siano nella natura della cosa; gli Stati crescono di nuovo rigogliosamente, e le chiacchiere ammutoliscono, dinanzi alle serie repliche della storia (Lineamenti di filosofia del diritto, Agg. 188 al § 324, p. 456).
Più sbrigativamente ci rifugeremo nella caustica replica nietzscheana, «voi dite che è la buona causa che rende santa persino la guerra. Io vi dico: è la buona guerra che rende santa qualsiasi causa» (Così parlò Zarathustra, p. 52)?2
Eppure, non tutti l’accetterebbero, e infatti, con un’ironia intonata in fondo a quella stessa di Platone, ma ancora più caustica, ecco Voltaire (1694-1778) ribellarsi:
popoli lontani, sentendo dire che si sta per battersi, che ci sono cinque o sei soldi al giorno da guadagnare per quelli che vogliono partecipare alla festa, si dividono subito in bande, come i mietitori, e vanno ad offrire i loro servigi a chiunque voglia assoldarli. […] Talvolta vi sono cinque o sei potenze belligeranti tutte insieme, tre contro tre, o due contro quattro, o una contro cinque, che si detestano egualmente le une e le altre, si uniscono e si attaccano volta a volta; e son tutte d’accordo in una sola cosa: di fare il maggior male che si può (Dizionario filosofico, p. 244)3.
Ma quasi un secolo prima il moralista francese La Bruyère (1645-1696) appariva già rassegnato:
la guerra ha dalla sua l’antichità; in tutti i secoli c’è sempre stata; la si è sempre vista riempire il mondo di vedove e di orfani, privare le famiglie di eredi e far perire i fratelli in una stessa battaglia. […] Dall’ingiustizia dei primi uomini, come da un’unica polla, è scaturita la guerra, nonché la necessità in cui si sono trovati di darsi dei padroni, che ne stabilissero diritti e pretese. Se, paghi del loro, fosse stato ad essi possibile astenersi dal desiderare la proprietà dei vicini, avrebbero goduto pace e libertà per sempre (I caratteri, p. 182)4.
Riassumiamo: a Platone la guerra appare prova di vanità, per de Maistre essa è divina (cioè prodotta da un disegno imperscrutabile), Hegel la giudica una necessità storica, Nietzsche (1844-1900) ne esalta la bellezza, Voltaire ne denuncia la stupidità, La Bruyère si limita ad ammetterne l’inevitabilità. Non sarà sfuggito a nessuno che tutti quanti muovono dal riconoscimento della guerra come dato elementare e strutturale della storia umana: nessuno ne ricercherà il superamento, ne sosterrà l’evitabilità, ne proclamerà l’obsolescenza? In verità, proprio quest’ultimo era stato il programma arditamente perseguito in secoli di redazione di progetti di pace perpetua: dal Grande disegno di Sully (1559-1641) al Nuovo Cinea di E. Crucé (1590-1648), dal Discorso intorno alla pace di W. Penn (1644-1718) al Progetto per rendere la pace perpetua in Europa dell’abate di Saint-Pierre (1658-1743), dal Progetto per una pace universale e perpetua di J. Bentham (1748-1832) al Per la pace perpetua di Fichte (1762-1814) o infine al modello di Riorganizzazione della società europea di Saint-Simon5. Ma la loro caratteristica comune – è noto – è l’utopismo e tanto ce ne allontana, per quella loro sufficienza nel trascurare la forza degli argomenti a favore della guerra e nell’esaltare irrealisticamente le prospettive della pace. Del tutto differente è l’impostazione di I. Kant, la cui idea della guerra è incomparabile rispetto a quelle ricordate; per lui essa ha infatti un ruolo da svolgere nella storia, essendo il vettore che dovrà «traghettare» l’umanità in una condizione altra rispetto a quella tradizionale:
La natura si è valsa della discordia degli uomini, e persino di quella delle grandi società e di quegli speciali enti che sono i corpi politici, come di un mezzo per trarre dal loro inevitabile antagonismo una condizione di pace e di sicurezza; cioè essa, mediante la guerra […], sospinge a tentativi dapprima imperfetti, e da ultimo, dopo molte devastazioni, rivolgimenti, e anche per il continuo esaurimento interno delle sue energie, spinge a fare quello che la ragione, anche senza così triste esperienza, avrebbe potuto suggerire: cioè di uscire dallo stato eslege di barbarie ed entrare in una federazione di popoli […]. Tutte le guerre sono quindi (non certo nell’intenzione degli uomini, ma in quella della natura) altrettanti tentativi per stringere nuovi rapporti tra stati (Idea di una storia universale dal punto di vista cosmopolitico, p. 131)6.
È noto quale sia il punto d’arrivo kantiano, la «pace perpetua», determinata dal fatto che
per gli stati che stanno tra loro in rapporto reciproco non vi è altra maniera razionale per uscire dallo stato naturale senza leggi, che è lo stato di guerra, se non rinunciare, come i singoli individui, alla loro libertà selvaggia […] e formare uno stato di popoli (Per la pace perpetua, p. 301)7.
Il ragionamento è chiaro e consiste in una drastica revisione del modello hobbesiano: mentre il filosofo di Malmesbury aveva destinato diversamente individui e stati, assegnando i primi alla società civile e i secondi allo stato di natura bellicoso, Kant sovverte il ragionamento prevedendo per gli stati un percorso analogo a quello degli individui. Anche gli stati percepiranno, a un certo punto dello sviluppo delle loro forme di distruzione reciproca, l’insostenibilità di tale situazione ed entreranno in una qualche forma di organizzazione pacifica (che questa dovesse poi essere una vera e propria federazione o più semplicemente una confederazione o un mero accordo internazionale, è una questione che qui non ci interessa). Ma non è soltanto questo che rende unica la posizione kantiana, bensì una sua semplice considerazione, a lungo trascurata, e che soltanto da pochissimi anni è stata rivalutata e posta (come vedremo tra po...
Indice dei contenuti
- Premessa
- Che cosa è la guerra
- Come si fa la guerra
- Perché si fa la guerra
- Che cosa significa la guerra
- Bibliografia
- L’autore
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Scopri come scaricare libri offline
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 990 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Scopri la nostra missione
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Scopri di più sulla funzione di sintesi vocale
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS e Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app
Sì, puoi accedere a La guerra di Luigi Bonanate in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Filosofia e Filosofia politica. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.