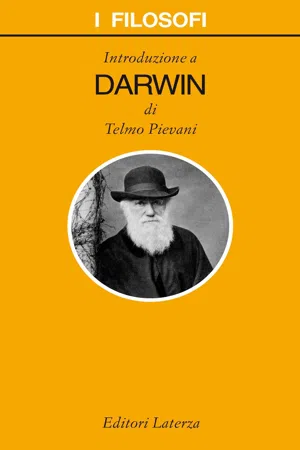1. Un romanzo di formazione
1. Due famiglie intrecciate
Charles Robert Darwin nacque a Shrewsbury, quinto dei sei figli di Susannah Wedgwood, nello stesso anno, il 1809, in cui in Francia veniva data alle stampe la Philosophie zoologique di Jean-Baptiste Lamarck, e nello stesso giorno, il 12 febbraio 1809, in cui nasceva Abraham Lincoln. Il suo contesto domestico fu condizionato dalle storie intrecciate di due famiglie molto diverse fra loro, ma profondamente legate. Il lato paterno era dominato dalla figura possente del nonno Erasmus Darwin, spirito mordace, anticlericale, illuminista, ammiratore delle rivoluzioni francese e americana. Era amico del nonno materno di Darwin, Josiah Wedgwood, che invece era di religione unitariana, di quel cristianesimo operoso ridotto all’osso, senza Trinità e senza necessità di sovrannaturale in natura. Erasmus – medico, sostenitore delle nuove tecnologie industriali come Wedgwood, filantropo e libertino, avversario della schiavitù come lo sarà il nipote – accettava la parentela comune fra tutte le creature (a partire da un primo minuscolo «filamento») e l’ipotesi di un moto graduale e progressivo della vita sulla Terra, idee che aveva raccolto nel 1796 in un saggio proto-evoluzionistico dal titolo Zoonomia, ovvero le leggi della vita organica.
Erasmus difese la sua tesi, come più tardi fece anche Charles, osservando che gli animali addomesticati potevano essere modificati attraverso l’incrocio selettivo e che i resti fossili indicavano i cambiamenti subiti nel tempo dalle specie. Era convinto dell’ereditarietà dei caratteri acquisiti da un animale durante la sua vita. Considerato un’autorità della medicina d’Inghilterra, Erasmus fu invitato a diventare il medico personale di re Giorgio III. Era un prolifico inventore, i cui successi includevano un mulino a vento orizzontale che forniva energia alla fabbrica degli Wedgwood, e un noto poeta e filosofo naturale le cui idee, si suppose, ispirarono il romanzo di Mary Shelley Frankenstein.
Il lato materno era costituito invece da grandi industriali della ceramica, pragmatici e devoti, ottimisti e liberali, avanguardie intellettuali di una borghesia in ascesa. La figlia di Josiah, Susannah, incontrò il figlio di Erasmus, Robert Waring, a Etruria, il moderno stabilimento di ceramiche della famiglia Wedgwood, che includeva quartieri residenziali per i lavoratori, una chiesa e una scuola, frequentata da entrambi i genitori di Charles quando erano bambini. In entrambe le famiglie era radicata la convinzione che le donne dovessero ricevere un’istruzione pari a quella degli uomini. Tra gli amici di famiglia c’era il poeta Samuel Taylor Coleridge, che gli Wedgwood finanziavano affinché potesse concentrarsi unicamente sulla scrittura. Josiah Wedgwood ed Erasmus Darwin si incontravano periodicamente alle riunioni di un gruppo di riformatori di idee simili, chiamato Lunar Society. I membri della società si facevano chiamare «lunatici» e pianificavano i loro incontri mensili in modo da poter tornare a casa sotto la luna piena. James Watt, l’inventore della macchina a vapore, era un componente, mentre Benjamin Franklin e Linneo apparvero come ospiti.
Erasmus nel 1783 manda a Edimburgo a studiare medicina il figlio minore Robert, che sarà padre di Charles e diventerà un rinomato e assai benestante medico dello Shropshire, esperto in malattie mentali. Nel 1817 muore la moglie di Robert per un tumore e Charles viene accudito ed educato dalle sorelle maggiori. Frequenta la ricca biblioteca paterna, dove trova molta buona filosofia della natura, ma gli studi classici che segue con il fratello maggiore Erasmus (come il nonno) lo annoiano terribilmente. È un collezionista accanito, raccoglie e osserva di tutto: minerali, uova, conchiglie, farfalle, ma soprattutto coleotteri. Va spesso a caccia e si appassiona a esperimenti (talvolta azzardati) di chimica casalinga.
2. Un giovane naturalista nella camera di Paley
Nel 1825 il padre – figura discreta e autorevole, ottimo amministratore degli averi di famiglia – lo sottrae in anticipo alla scuola e agli ozi spensierati della caccia, mandandolo a studiare medicina insieme al fratello maggiore a Edimburgo, città attivissima e fervente di innovazioni, l’Atene del Nord, una tradizione di famiglia, come del resto la lettura di David Hume. Charles ha ben presto in odio l’anatomia e le dissezioni di cadaveri, nonché le operazioni chirurgiche, allora senza anestesia. Impara però l’arte della tassidermia da un nero liberato, John Edmonstone, al Museo di Edimburgo, legge voracemente la Zoonomia di suo nonno, frequenta le società studentesche e la Plinian Society, fucina di storia naturale e di un certo materialismo scientista e anticlericale.
Charles dedica quasi tutto il suo tempo a collezionare insetti, piante, minerali, coralli, spugne e molluschi. Il suo mentore è Robert E. Grant, biologo marino, un evoluzionista convinto che gli fa conoscere i grandi naturalisti francesi Georges-Louis Leclerc de Buffon, Jean-Baptiste Lamarck e Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Frequenta il corso di geologia di Robert Jameson e impara a leggere gli strati rocciosi, prendendo dimestichezza con l’eventualità che la Terra sia molto più antica di quanto si pensi e che gli esseri viventi si siano trasformati nel corso del tempo. Grant è una figura spesso sottovalutata nelle ricostruzioni della prima formazione scientifica di Darwin, ma ebbe probabilmente un’influenza decisiva nell’esporlo a concezioni trasformiste della natura. Fu attraverso il nonno Erasmus e Grant che il giovane naturalista inglese esplorò in particolare le idee di Lamarck, verso il quale per tutta la carriera esprimerà un freddo distacco nelle opere pubbliche (citandolo solo dove strettamente necessario) e un aperto scherno nelle lettere private, mascherando forse in questo modo il suo reale debito verso il francese.
La lettura della Zoonomia e le escursioni sulle spiagge scozzesi insieme a Grant crearono probabilmente il contesto favorevole, nella mente di Darwin, per la discussione di idee evoluzionistiche negli anni a venire. Grant era interessato in particolare alle forme di vita marine primitive come le spugne e i briozoi – letteralmente, «animali muschio» – perché pensava che tutte le piante e gli animali provenissero da un unico antenato marino primitivo. Anche Darwin si appassionò a questo lavoro sul «punto di origine» in cui animali e piante si confondono e nel 1827 presentò a un gruppo di studenti un articolo su un briozoo chiamato Flustra. Fu la sua prima, informale, pubblicazione scientifica, dedicata a un tema che rimarrà poi sempre centrale nelle sue riflessioni: la continuità delle forme viventi che si manifesta in organismi primordiali il cui aspetto sembra fare da ponte tra grandi raggruppamenti moderni.
Nell’aprile del 1827 torna a casa, senza la laurea: per il padre è un fallimento, ma intanto era cominciata la sua formazione intellettuale. Viene mandato a Cambridge per acquisire il Bachelor of Arts, primo passo della carriera ecclesiastica. A Oxford e Cambridge, a differenza della Edimburgo popolata da pensatori radicali, dominava il creazionismo più stretto e la teologia naturale rappresentava la visione dominante nei libri di testo. Era però possibile anche seguire molti corsi di scienze naturali, ed è ciò che Charles si mise immediatamente a fare. Si convinse che gli ordini sacri erano l’unica strada che aveva per intraprendere una carriera naturalistica, la sua unica vera passione. Ironia della sorte – alla luce di ciò che accadde dopo – volle che al diciannovenne, giunto nel 1828 insieme al fratello maggiore in una Cambridge oppressa dal conformismo anglicano e percorsa da incombenti sedizioni, fosse assegnata proprio la stanza al primo piano del Christ’s College che un tempo era stata occupata da William Paley, autore dei libri di testo adottati dall’università, come The Principles of Moral and Political Philosophy del 1785.
La Natural Theology, pubblicata da Paley nel 1802 tre anni prima della morte, era una lettura apologetica pressoché obbligata a Cambridge. La sua prosa ricercata perseguiva il pio obiettivo, già di molti altri grandi della scienza inglese, di mostrare le «evidenze dell’esistenza e degli attributi della divinità raccolti dalle manifestazioni della natura». Paley presentava differenti versioni del cosiddetto «argument from design» – formalizzato da Tommaso d’Aquino e sostenuto da autorità indiscusse della scienza britannica come John Ray e William Derham, ma soprattutto da Robert Boyle e da Isaac Newton nell’Opticks – cioè la deduzione dell’esistenza di Dio a partire dall’evidenza di un progetto insito nel mondo naturale. Si trattava, nella sostanza, di un’argomentazione per analogia. Se camminando per una brughiera, spiegava Paley, noi incappiamo in un artefatto, per esempio un orologio di pregiata fattura, siamo portati a ritenere, in virtù della sua forma e delle relazioni complesse fra le sue componenti, che sia esistito un orologiaio che lo ha progettato e costruito. Sappiamo cioè che si tratta del prodotto di un’attività intenzionale. Se invece inciampiamo in una pietra, siamo autorizzati a pensare che essa si trovasse lì da sempre e senza alcuna ragione particolare.
Se non esiste un congegno senza un inventore, un ordine senza un ordinatore, un progetto senza un progettista, quando volgiamo lo sguardo all’universo ci accorgiamo della sua straordinaria armonia e articolazione, ben superiore a quella di un orologio. Non possiamo che dedurne, a maggior ragione, l’esistenza di una mente suprema che ha progettato l’universo, proprio come l’orologiaio ha progettato il suo meccanismo. Lo stesso ragionamento possiamo adesso avanzare osservando le ingegnose opere della natura sul nostro pianeta, gli adattamenti perfetti delle specie, le splendide forme degli animali: la loro armonia di forme e funzioni non può essere il prodotto di una dinamica naturale casuale come il rotolare insulso di una pietra. A differenza di quella continentale, basata principalmente su «leggi della forma» interne, la teologia naturale britannica puntava proprio sull’adattamento e sulla funzionalità come prove della progettazione divina. Darwin rimase affascinato come molti suoi contemporanei dalla lettura di Paley e dalle sue minuziose, appassionanti descrizioni degli ingegneristici adattamenti di piante e animali. Certo non avrebbe immaginato, in quella cameretta del Christ’s College, che il destino gli teneva in serbo il ruolo di colui che confuterà per via scientifica la dottrina della teologia naturale e renderà superfluo il ricorso a ipotesi sovrannaturalistiche e teleologiche per comprendere la diversità, le trasformazioni e gli adattamenti degli esseri viventi.
3. Battesimo geologico e oceanico
Tra una battuta di caccia e l’altra, passò l’esame di medio termine abbastanza bene e così quello dell’anno successivo: risultati buoni, conquistati a fatica, uniti ad altri arricchimenti come la frequentazione in famiglia del filosofo morale James Mackintosh e la lettura del Preliminary Discourse on the Study of Natural Philosophy di John Herschel. All’università di Cambridge l’interesse di Darwin per la storia naturale divenne molto più che un hobby. Entrò a far parte di un circolo elitario di eminenti professori ai quali si ispirava e divenne il pupillo del reverendo John S. Henslow, botanico brillante e carismatico. Henslow gli presentò Adam Sedgwick, uno dei più importanti geologi britannici, che portò Darwin con sé in una spedizione geologica attraverso il Galles e le sue antichissime conformazioni. Sedgwick lo impressionò perché leggeva il paesaggio roccioso come un libro di storia, traendo da una manciata di indizi conclusioni generali.
Almeno da quando il geologo scozzese James Hutton alla fine del Settecento aveva ricostruito i lunghi e lenti processi di formazione delle scogliere di arenaria di Siccar Point, i geologi avevano ormai documentato che la Terra non era statica: nel tempo aveva subito vasti cambiamenti – erosioni, subsidenze, sollevamenti, inclinazioni – i quali, di fatto, erano ancora in corso. La Terra dunque era molto più vecchia di quanto suggerissero i testi biblici, poiché i processi di trasformazione della superficie terreste avevano richiesto milioni e milioni di anni, senza «vestigio di un inizio, né prospettiva di una fine» aveva sentenziato Hutton. Queste idee, allora dibattute pubblicamente in Inghilterra con vasto seguito, ebbero una duratura influenza sul pensiero di Darwin, che terrà sempre a definirsi un geologo ancor prima che un naturalista.
Nell’agosto del 1831 Darwin, per interessamento di Henslow, ricevette un invito inaspettato che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita: unirsi all’equipaggio del brigantino della Marina inglese «Beagle» per un viaggio intorno al mondo durante il quale avrebbe potuto compiere liberamente osservazioni naturalistiche. Da mesi sognava di visitare i tropici. Riuscì a vincere le diffidenze del padre verso quel «progetto insensato», grazie all’intervento pragmatico dello zio Wedgwood, e quelle del capitano del vascello, Robert FitzRoy, un giovane aristocratico di talento, futuro meteorologo, di impetuoso carattere e di vedute conservatrici con il quale i rapporti saranno sempre piuttosto tesi.
Salpato da Plymouth il 27 dicembre 1831, il Beagle effettuò rilevamenti lungo la costa del Sud America, permettendo a Darwin di esplorare liberamente la terraferma e le isole. Riempì dozzine di taccuini con meticolose osservazioni geologiche e biogeografiche, con descrizioni morfologiche e funzionali di animali e di piante. Nell’Autobiografia Darwin descrisse il viaggio sul Beagle come «l’avvenimento di gran lunga più importante della mia vita», la svolta della carriera. Quando partì, ventiduenne, era un giovane laureato, ancora intento a pianificare una carriera da parroco di campagna e da collezionista dilettante. Quando tornò, era un affermato geologo e naturalista viaggiatore, molto conosciuto a Londra per via della strabiliante collezione spedita prima del ritorno. Il viaggio sul Beagle gli fornì un’enorme quantità di esperienze su cui riflettere per decenni, ma anche i primi semi di una teoria a cui avrebbe lavorato per il resto della sua esistenza.
Su un brigantino lungo poco più di ventisette metri, soffrendo quasi ininterrottamente il mal di mare, Darwin compie una circumnavigazione del globo di cinque anni, dalla fine del 1831 all’autunno del 1836, restando però per gran parte del tempo in Sudamerica e passando due terzi del viaggio a terra. Le soste più rilevanti furono a Capoverde, Fernando de Noronha, Salvador de Bahia, Rio de Janeiro, Montevideo, in Patagonia, sulle isole Falkland, in Terra del Fuoco, in Cile e Perù, sull’arcipelago delle Galápagos, a Tahiti, in Nuova Zelanda e Tasmania, a Sydney, sulle isole Keelings o Cocos, a Mauritius, poi Città del Capo, e infine l’ultima traversata dell’Atlantico toccando di nuovo la costa brasiliana e poi le Azzorre. Mentre la nave misurava sistematicamente le profondità dell’oceano e il capitano FitzRoy – eccellente cartografo, inventore poi di barometri e di strumenti di navigazione adottati dalla Marina britannica, e precursore dei moderni sistemi di previsione meteorologica – verificava linee di costa, percorribilità delle rotte e affidabilità dei porti, Darwin scendeva a terra per esplorare e raccogliere esemplari.
4. Tutte le isole del mondo
Il suo lavoro, formalmente in qualità di gentiluomo accompagnatore del capitano, fu un successo sotto tutti i punti di vista. Darwin spedì in Inghilterra esemplari di oltre 1500 specie diverse, centinaia delle quali del tutto sconosciute in Europa, e al suo rientro diventerà una celebrità per questa impresa di viaggiatore naturalista. La scoperta delle scomodità della vita in mare e l’impossibilità di scendere a Santa Cruz di Tenerife a causa di una quarantena contro il colera furono le prime delusioni, ben presto però ripagate dall’incontro con l’arcipelago di Capoverde, che diventa un’iniziazione alle dimensioni sconfinate, ed elusive, del tempo della Terra.
La geologia rappresentò la competenza primaria di Darwin e lo sfondo indispensabile per la nascita delle sue idee sulla «trasmutazione» delle specie. Fu della geologia di allora la consapevolezza dello sfondamento all’indietro degli eoni del tempo, l’idea che la vita attuale galleggiasse sopra una distesa sterminata di epoche passate, sottile pellicola alla sommità di strati temporali abitati da altre creature e sconvolti da inusitate potenze telluriche. Ma è della geologia anche la percezione dell’instabilità attuale della crosta terrestre, attraversata da scosse, da eruzioni (come quella del vulcano Osorno, alla quale Darwin assiste in Cile) e da trasformazioni che sono il frutto delle stesse forze che accumulano i loro effetti nel tempo. Proprio in questa instabilità del contesto fisico, e poi ecologico, si sviluppa il gioco dell’evoluzione e il tempo della Terra fa da palcoscenico ai tempi plurali della vita, alla diversificazione, moltiplicazione ed estinzione delle specie.
Ma la geologia («materia in cui entra in gioco il ragionamento», scriverà Darwin nell’Autobiografia) fu anche altro. Dai primi saggi giovanili sulle isole vulcaniche e sulla formazione degli atolli corallini fino all’ultima opera sulle attività degli umili e gloriosi lombrichi, fu per Darwin un modello epistemologico di scienza naturale rigorosa, capace di estrapolare dalle sue osservazioni meticolose quelle regolarità e quelle strutture del tempo che si ripetono fedelmente in ogni parte del globo, permettendo di scovare gli «schemi ripetuti di eventi», o pattern, che emergono come filigrane dalla storia (Eldredge, 1999, 2006). Il giovane naturalista si ripromise di scrivere libri di geologia, ma anche di tradurre nelle scienze della vita il metodo di indagine della geologia: non più solo classificazioni e raccolte di descrizioni, ma «connessioni tra fatti sparsi», scriverà nei Taccuini. In più, le scienze della Terra erano discipline in fase di trasformazione, pervase da correnti di pensiero contrapposte (plutonisti e nettunisti, catastrofisti e uniformisti) e da sempre nuove scoperte: il contesto fluido ideale affinché un giovane ambizioso potesse mettere alla prova le autorità dei maestri e l’attualità dei dibattiti scientifici del momento.
Oltre a tutto ciò, la geologia permise anche a Darwin di percepire per la prima volta il carattere non finalistico delle manifestazioni naturali, la loro indifferenza verso le sorti degli umani, la loro brutale e solenne indipendenza dalle nostre personalizzazioni provvidenzialistiche. Questa congerie di significati si condensa nel battesimo geologico di Darwin sull’isola di Santiago, nell’arcipelago di Capoverde, prima sosta del 16 gennaio 1832. Dalle note grezze di quei giorni (il «Manoscritto di Santiago», il «Manoscritto di Quail Island» e il Diario di Bordo originale, che poi Darwin rielaborerà al ritorno), si scorgono nelle sue ambivalenze teoriche, nei passi falsi, nelle insicurezze del neofita i prodromi del corpo a corpo con l’immensità del tempo e con le trasformazioni che in essa si realizzano. A tratti anticipa il suo caratteristico...