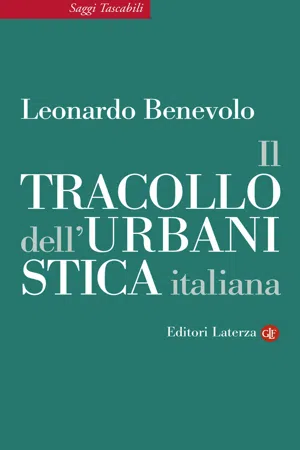I. Le vicende dell’urbanistica italiana negli ultimi settant’anni
Il trapasso dal fascismo alla Repubblica (1945-1960)
Il corso di studi della facoltà di Architettura di Roma, quando mi sono iscritto nel 1941, era stato istituito da pochi anni e il corpo docente comprendeva – insieme a illustri insegnanti di scienze e materie tecniche provenienti dalle facoltà d’Ingegneria – i più importanti architetti del tempo, cresciuti nell’acquario del fascismo e rimasti a lungo isolati dalla cultura e dalla pratica europee. In questo e in altri campi la committenza più importante, di origine pubblica, faceva capo a Giuseppe Bottai, ministro dell’Educazione Nazionale dal 1936 al 1943.
La sua egemonia mentale, imposta in quel breve intervallo di tempo, ha avuto per noi un particolare rilievo. Ha prodotto gli strumenti legali più importanti per il nostro mestiere, sopravvissuti fino ad oggi: le due leggi del 1939 sulla «protezione delle cose d’interesse artistico e storico» e sulla «protezione delle bellezze naturali» e la legge urbanistica generale (apparsa nell’agosto del 1942, mentre si combatteva la battaglia di Stalingrado).
Il regime, nel frattempo, aveva intrapreso il programma di «modernizzazione» del centro storico di Roma, nell’ambito del quale vennero compiuti gli sventramenti di vaste parti del tessuto antico e gli «isolamenti» di alcuni monumenti di Roma millenaria, i cui risultati avrebbero condizionato tutta la storia successiva.
L’E42 – l’Esposizione Universale avviata da Bottai, governatore di Roma dal ’35 al ’36 – era in avanzata costruzione, e gli incarichi edilizi erano stati affidati a un gruppo ristretto di progettisti, comprendente i docenti universitari in carica e alcuni probabili successori: Piacentini, Foschini, Morpurgo, Marconi, Lapadula, Piccinato, Vietti, Pagano, Moretti, Quaroni, Muratori, Libera, i BBPR. Gran parte dei cantieri erano ancora aperti, sebbene la data prevista della manifestazione fosse stata tacitamente accantonata per l’imprevista durata della guerra. Alcuni insegnanti e allievi sparivano di tanto in tanto per lontane destinazioni di guerra, temporaneamente o per sempre.
Il fattore unificante di tutte quelle esperienze, appartenenti alla disciplina civile e militare, era la nozione politica del potere, che aveva la sua origine nel movimento futurista da cui Bottai proveniva – la «sfida alle stelle» nella conclusione del manifesto del 1909 – e che lo stesso Bottai ebbe occasione di additare subito dopo la sua caduta politica: non la tradizionale «arte del possibile», ma «l’arte dell’impossibile» perseguita da una volontà incondizionata.
Questo mondo gerarchico, che comprendeva anche le nostre materie scolastiche, era stato scompaginato dalla crisi istituzionale del 1943-1945, ma la sua conformazione intellettuale è sopravvissuta con sorprendente integrità nel dopoguerra, per una combinazione di motivi che ho raccontato altrove. Alcuni fra noi hanno riconosciuto tragicamente l’aberrazione comune fra i due campi di obbedienza – la guerra e il mestiere –, andando spesso incontro alla morte; altri, per sopravvivere meglio, hanno preferito attenersi strettamente all’impegno professionale, basato sulla nozione del «progetto»: un disegno di scala appropriata, dove sintetizzare gli apporti «scientifici» e «artistici» provenienti dai rispettivi campi. Le indicazioni del «movimento moderno» erano già apparse utilizzabili in quella trafila, impiegando a tale scopo la valenza del «potere» fascista, e sembrava che si potesse far lo stesso col nuovo potere democratico della Repubblica, anche perché dentro il «moderno» la discussione precoce fra due o più tendenze alternative – quella «razionalista», quella «organica» e le loro varianti individuali e collettive, contrapposte nel lungo dibattito successivo – rafforzava l’interpretazione eclettica delle scelte progettuali, limitando l’estensione della responsabilità verso gli utenti e lasciando ad altri operatori specializzati la padronanza del processo esecutivo.
In campo urbanistico la discussione sui rapporti fra le scelte disegnate e i mezzi di attuazione non era mancata al tempo di Bottai. Nel primo congresso nazionale di urbanistica del 1937 la relazione generale di Virgilio Testa e Armando Melis criticava la rendita fondiaria privata e vi contrapponeva un controllo pubblico «razionale» del territorio, comprendente la formazione di una rete di piani regionali e urbani, la formazione di un demanio di aree fabbricabili pubbliche e una nuova tassazione degli incrementi di valore dei terreni privati. L’obiettivo era «l’attesa legge urbanistica, con la quale si doveva creare il nuovo diritto urbanistico del Regime Fascista». Virgilio Testa, il nostro insegnante universitario di «materie giuridiche», aveva organizzato l’esproprio di tutta l’area dell’E42 (430 ettari, individuati in partenza e resi così disponibili senza problemi), che aveva permesso un’esecuzione sollecita e permetterà ancora nel dopoguerra l’agevole trasformazione di quell’area in un quartiere cittadino (Testa rimase poi commissario straordinario dell’EUR fino al 1973).
Nel primo semestre del 1942 la rivista «Critica Fascista» di Bottai pubblicava una serie di articoli di Michelucci, Piacentini e Testa sulla «funzione sociale dell’urbanistica». La legge urbanistica – approvata a ferragosto, due mesi prima della rotta di El Alamein – prevedeva una serie completa di piani territoriali, intercomunali, comunali e particolareggiati, e due percorsi alternativi di attuazione: l’esproprio preventivo delle aree di trasformazione, da cedere poi ai vari operatori pubblici e privati (art. 18), oppure i vincoli urbanistici non indennizzabili, valevoli a tempo indeterminato (art. 40).
Nel clima del dopoguerra il discorso sugli strumenti di attuazione si spegne quasi subito (le ultime iniziative compaiono a Milano nel 1945: un rapporto dell’ingegnere capo del Comune, Antonio Cecchi, e una relazione di Giovanni de Finetti nel primo convegno sulla ricostruzione, che propongono l’acquisizione pubblica preventiva delle aree d’intervento).
Mentre i progressisti fuggono in avanti sul veicolo mentale del progetto, i conservatori – saldamente insediati nelle posizioni dominanti e muniti di un superiore scetticismo – retrocedono in pochi anni dalle proposte monumentali d’anteguerra adottando una eclettica neutralità sulle tendenze stilistiche, e assistono i nuovi governanti nelle loro scelte «liberali».
I «piani di ricostruzione», istituiti nel ’45, accelerano le procedure e finanziano le esecuzioni con erogazioni pubbliche a fondo perduto, evitando di alterare l’assetto delle proprietà. Anche la politica economica di Luigi Einaudi lascia indisturbata la competizione speculativa sui terreni nella ricostruzione edilizia (in una delle Prediche della domenica, il 5 febbraio 1961, l’illustre economista divenuto presidente della Repubblica afferma: «speculare vuol dire semplicemente ‘prevedere’, ‘antivedere’, ‘anticipare’ gli avvenimenti futuri»).
Il «piano di incremento dell’occupazione operaia», presentato dopo le decisive elezioni politiche del 1948 dal ministro del Lavoro Amintore Fanfani, promuove un vasto programma di case economiche, da costruire con i contributi dei lavoratori e dei datori di lavoro gestiti dall’INA, e conferma esplicitamente le consuetudini in voga: le aree occorrenti si acquistano volta per volta sul mercato; si preferiscono le tecniche di costruzione tradizionali; si accantona ogni forma di pianificazione d’insieme. Il direttore tecnico del piano, Arnaldo Foschini, distribuisce da Roma gli incarichi agli architetti di ogni tendenza, confermando così la loro equivalenza e la centralità del suo eclettismo di base. Alle iniziative del piano INA-Casa parteciparono molti dei protagonisti del movimento architettonico, tra cui Diotallevi, Ridolfi, Valori, Aymonino, Albini, Figini e Pollini, i BBPR e altri.
Le associazioni private che riuniscono gli architetti «moderni» – l’APAO (Associazione per l’architettura organica, a Roma); l’MSA (Movimento per gli studi di architettura, a Milano) – sono battute da questa manovra, e si sciolgono subito dopo. Si cerca ora una base istituzionale per poter discutere con l’apparato pubblico e viene scelto a questo scopo l’Istituto nazionale di urbanistica (INU), fondato in epoca fascista da un importate gerarca, Alberto Calza-Bini. Gli architetti «moderni» vi si iscrivono in massa nel 1951, designano alla presidenza Adriano Olivetti e alla segreteria Bruno Zevi. Le adunate annuali dell’INU scelgono come argomenti i vari tipi di piano definiti dalla legge del 1942, e iniziano un dialogo con i ministri dei Lavori Pubblici del tempo, a cui non seguono iniziative concrete ma modesti finanziamenti per progetti dottrinali svincolati dagli ancoraggi ufficiali e dai calcoli esecutivi, presentati nei successivi congressi e convegni dal ’52 al ’60. La loro attuazione è rimandata a un atto risolutivo futuro, richiedente un’iniziativa speciale del potere politico continuamente invocata: una nuova versione della legge urbanistica e/o una legge per un nuovo regime dei suoli.
Nella realtà, i nuovi piani regolatori comunali fondati sulla legge del ’42 che riescono a diventare vigenti sono in numero limitato, progettati in buona parte dai medesimi accademici d’anteguerra, di cui le amministrazioni cittadine di destra e di sinistra subiscono ancora il prestigio.
La direzione generale dell’Urbanistica presso il ministero dei Lavori Pubblici, che è nell’apparato pubblico italiano un corpo particolarmente efficiente, gestisce dal centro l’approvazione di tutti i piani regolatori italiani e agisce solo di rimessa; ma intanto assicura per tempo una procedura razionale promuovendo nel 1952 la «legge di salvaguardia», che attribuisce ai piani adottati una valenza provvisoria in attesa dell’approvazione, ed entra in merito alla natura delle loro previsioni opponendosi con fermezza alla pratica degli sventramenti.
Così, nel 1952, si ottiene il ritiro del piano particolareggiato per l’allargamento di via Vittoria nel centro di Roma, contro cui hanno protestato i più illustri intellettuali del tempo; nel 1954 viene respinto il piano di Brescia, che è un rifacimento tardivo del piano del 1941, con gli sventramenti proposti negli anni Trenta da Piacentini. In fase esecutiva le scelte pressoché unanimi delle città interpretano in modo ancora riduttivo le alternative della legge del 1942: fra i due percorsi attuativi della legge del ’42 si sceglie il secondo (art. 40) e si accantona il primo (art. 18), orientando una volta per tutte l’intera vicenda futura.
La durata indefinita e la non indennizzabilità dei vincoli, sebbene promettano difficoltà per il futuro, non compromettono infatti la pratica tradizionale finché i piani regolatori sono pochi, ampiamente permissivi e l’attuazione segue a breve distanza di tempo. Invece l’esproprio, praticato negli altri paesi europei, dovrebbe avvenire preventivamente, la nuova legge del ’42 non contiene un regolamento sulle procedure, e si teme a ragione una strenua resistenza dei proprietari impegnati nella ricostruzione. Di fatto, l’art. 18 non sarà mai applicato e finirà per cadere ad opera delle leggi riformiste degli anni Settanta, come si dirà in seguito.
La più rilevante operazione urbanistica del tempo, il nuovo piano regolatore di Roma, viene intrapresa per iniziativa di un autorevole esponente liberale: Enzo Storoni. L’illustre uomo politico diventa assessore all’urbanistica del Comune di Roma nel 1953 e nel medesimo anno comincia il lavoro di progettazione del piano. I coordinatori dell’ufficio di pianificazione, Ludovico Quaroni e Luigi Piccinato, sviluppano il lavoro e concretizzano i principali elementi del piano: la decompressione dell’area centrale – appesantita dall’accumulo delle funzioni sovrapposte – per mezzo della creazione di una nuova centralità nella zona orientale della città, completata da una nuova armatura stradale e infrastrutturale, incentrata sulla creazione di un asse attrezzato, per aprire la città verso le grandi vie di comunicazione nazionali.
L’avvicendamento amministrativo del 1958 apre la strada alla bocciatura del piano e nel 1959, appena prima delle Olimpiadi a Roma, viene sviluppato un nuovo progetto (il cosiddetto piano Lombardi-D’Andrea) che pareggia le opportunità edilizie nelle varie direzioni, comprendente una «via Olimpica» a ovest del Tevere fra i campi sportivi del Foro Italico. Subito dopo, Italo Insolera, Michele Valori, Mario Manieri-Elia, Manfredo Tafuri ed io, d’intesa con Quaroni e Piccinato, preparammo tre numeri consecutivi, 27, 28 e 29 della rivista dell’INU «Urbanistica», per sostenere la prima soluzione (330 pagine complessive, con un’ampia esposizione della storia passata, un resoconto minuzioso dei recenti lavori e un imponente corredo illustrativo).
La caduta del governo Tambroni nel 1960 e la svolta politica del centro-sinistra rendono possibile redigere (con il coordinamento di una commissione composta da Piccinato, Lugli, Passarelli, Fiorentino e Valori), sulla scorta della prima soluzione, un progetto conclusivo che viene adottato, pubblicato e riceve le osservazioni dei cittadini. Ma la giunta comunale va in crisi e il commissario prefettizio rifiuta di sottoscrivere il documento, che fra il 1961 e il 1962 è finalmente assentito, clamorosamente, con un atto del Parlamento.
Si chiude così una vicenda che riempie le cronache del tempo e comprende anche una vertenza giudiziaria fra il settimanale «L’Espresso» e la Società generale immobiliare durata dal 1955 al 1957. L’oggetto principale delle critiche è la «speculazione fondiaria», ma il bersaglio è incerto: si biasimano gli imprenditori privati per le loro iniziative, non le amministrazioni locali che non intervengono, perché i rimedi radicali di ordine legislativo si attendono dalle amministrazioni superiori. L’INU dedica il suo ottavo congresso, nel 1960, al «codice dell’urbanistica» (il titolo imita il «codice della strada», uscito in quegli anni) e presenta un suo progetto di legge con questo nome, che riunisce e mette in ordine tutte le procedure di questo settore. Una volta tanto, nell’euforia della nuova maggioranza di centro-sinistra al governo, la lunga aspettativa è raccolta per tempo dal ministro democristiano ai Lavori Pubblici Fiorentino Sullo, che nel 1962 presenta una legge di riforma del regime dei suoli, immediatamente sconfessata dal governo. I successivi ministri socialisti Pieraccini e Mancini promettono una nuova legge emendata, che non arriverà mai.
La ricerca di un’urbanistica praticabile (1960-1980)
La difficoltà principale, non collocata nella progettazione del piano ma nel passaggio dal progetto all’esecuzione, sfuggiva allora a quasi tutti noi. L’insistenza sugli aspetti formali del disegno e sui risvolti politico-sociali delle previsioni urbanistiche (la cui interpretazione creava contrapposizioni insolubili) non permettevano di cogliere l’elemento di vulnerabilità dell’intera operazione pianificatoria.
Le leggi affidavano il processo attuativo ai «piani particolareggiati», che in mancanza di iniziative e di risorse venivano rimandati a un futuro indeterminato. Nel 1964 la notizia che in sede di approvazione del piano regolatore di Roma il ministro Mancini aveva ottenuto la destinazione a parco pubblico dell’intero territorio della via Appia Antica (2.500 ettari) viene accolta come un successo definitivo, senza verificare gli strumenti e i costi per ottenere quel risultato (l’effettiva disponibilità pubblica di quel territorio manca ancor oggi in buona parte).
La stessa vicenda si ripete nelle città che subirono le inondazioni dell’autunno del ’66. Nel 1962 viene adottato il piano regolatore di Firenze progettato da Edoardo Detti e si apre a Venezia un’accanita discussione sul piano regolatore promosso da Wladimiro Dorigo. Il primo dei due viene pubblicato nel 1967, un anno dopo l’alluvione; il secondo non supera il dibattito in sede comunale; l’uno e l’altro poi, alla prova dei fatti, rimarranno in buona ...