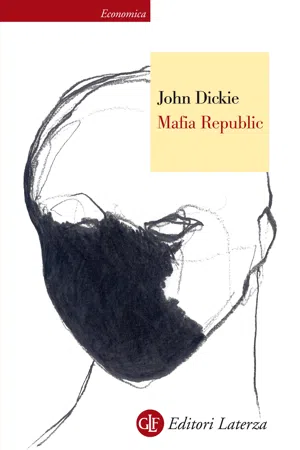1.
Scurdammoce
’o passato
Sicilia: minacce, terrorismo, omicidi, incendi dolosi, sequestri di persona e disordini
Nelle prime ore del 10 luglio 1943, mezzi da sbarco americani e inglesi approdarono sulle spiagge siciliane, riversando sulla battigia il loro carico di truppe e carri armati. Cinque settimane e mezza più tardi, il 17 agosto, le ultime navi che evacuavano dall’isola soldati ed equipaggiamento delle forze dell’Asse uscirono sotto una pioggia di bombe dalla baia ricurva del porto di Messina: la Sicilia era caduta nelle mani degli Alleati.
Appena liberata, l’isola scivolava già verso il caos. L’Amgot (Governo militare alleato nei territori occupati) dovette farsi carico di dare da mangiare a una popolazione affamata e al contempo cercare di arginare l’esplosione di contrabbando, banditismo, evasioni carcerarie, regolamenti di conti ed estorsioni. Già nel settembre del 1943 il «New York Times» riferiva che la mafia siciliana giocava un ruolo di primo piano nell’ondata di criminalità che aveva fatto seguito alla liberazione.
All’inizio degli anni Trenta, il fascismo aveva proclamato a gran voce la sconfitta della mafia, realizzata a suon di rastrellamenti e processi di massa. L’opinione pubblica, in gran parte del mondo, aveva preso quei proclami per buoni. Nel 1938 l’autore siculo-americano di una guida turistica spiegava che la mafia era «ufficialmente estinta»: «L’eliminazione di questo cancro è l’evento di gran lunga più significativo nella storia recente dell’isola».
Da parte loro, le autorità militari angloamericane prima dell’invasione erano consapevoli che i proclami della propaganda fascista sulla scomparsa della mafia erano esagerati. Ma non erano in grado di dire con esattezza in quali condizioni versasse la fratellanza criminale, anche perché Mussolini aveva dimostrato la fondatezza della sua vittoria sulle cosche nel solo modo che conosceva: vietando ai mezzi di informazione italiani di pubblicare articoli su episodi legati alla criminalità organizzata. Dietro questo blackout informativo, la verità – che è emersa solo recentemente dagli archivi – era che la mafia siciliana negli anni Trenta era più forte che mai. Era una fratellanza criminale segreta, in cui si entrava pronunciando un giuramento e che era strutturata sul modello della massoneria: i suoi membri si definivano «uomini d’onore». Aveva filiali, chiamate «famiglie», in quasi in tutte le città e paesini della parte occidentale dell’isola. Nella provincia di Palermo, dove si concentrava circa metà della sua forza, i capi dell’organizzazione, chiamati formalmente «rappresentanti», ubbidivano a una «Commissione» presieduta da un «presidente generale» o «capo dei capi». Il fascismo aveva combattuto la mafia siciliana lanciando contro di essa due grandi campagne repressive, ma alla fine il regime del duce, come tutti i governi che lo avevano preceduto in Italia, aveva imparato a conviverci.
Nel caos che seguì alla liberazione, l’inquietante sagoma della mafia tornò a farsi visibile. L’Amgot aveva urgente necessità di capire con cosa aveva a che fare e nell’ottobre del 1943 commissionò all’intelligence militare un rapporto riservato, al punto da essere consegnato da un messaggero personale al quartier generale delle forze alleate ad Algeri, sull’altra sponda del Mediterraneo. Il suo autore, il capitano William Everett Scotten, era un diplomatico di carriera di trentanove anni, originario di Pasadena, in California, e convertitosi recentemente in ufficiale dei servizi segreti militari dell’Esercito degli Stati Uniti. Il rapporto giungeva alla conclusione che la mafia era un «sistema criminale» che mirava «a compiere impunemente estorsioni e furti», usando metodi «che andavano dalle minacce e dal terrorismo agli omicidi, gli incendi dolosi, i sequestri di persona e i disordini».
Scotten proseguiva spiegando come, nelle settimane successive all’invasione del luglio 1943, il sistema criminale avesse dato agli Alleati una lezione di come ci si infiltra in un apparato di governo. Quando in Sicilia lo Stato fascista si dissolse, l’Amgot si trovò ad aver bisogno di persone del posto in grado di garantire il mantenimento di una parvenza d’ordine. Il capitano Scotten riferì che molti dei siciliani che si proclamavano vittime del fascismo ed erano stati nominati sindaci dall’Amgot in realtà erano malavitosi o loro burattini. Mafiosi siciliani con esperienza dell’America si erano anche offerti come interpreti volontari, procurandosi in questo modo posizioni di potere. Il capitano Scotten era a conoscenza anche di «numerosi casi» di personale alleato che per «legami familiari o antenati negli Stati Uniti era stato attirato direttamente nella sfera d’influenza della mafia». Non solo: perfino funzionari onesti si erano fatti raggirare da aristocratici siciliani legati alle cosche (il «livello più alto» della mafia, per citare le parole di Scotten).
La mafia aveva accresciuto anche il proprio potere economico. L’Amgot in teoria aveva stabilito che il grano doveva essere requisito e conservato in magazzini per essere distribuito attraverso un sistema di tessere annonarie. Il capitano Scotten aveva scoperto che la mafia, oltre a gestire il vasto mercato nero del grano, in alcuni posti aveva usato i propri contatti politici a Palermo per mettere le mani anche sulle banche del grano gestite dal governo: sia il mercato illegale sia il mercato legale dei prodotti agricoli erano nelle mani della criminalità. Insomma, nel giro di poche settimane dall’inizio dell’occupazione alleata, la mafia aveva già stretto la sua morsa intorno alla gola della Sicilia. Gli armamenti rimasti sul terreno nel corso degli scontri armati le avevano garantito un arsenale formidabile: «Mitragliatrici, mortai, perfino cannoni leggeri, mine antiuomo, radio da campo e ampie scorte di munizioni», secondo il capitano Scotten. La mafia siciliana era pronta e armata per sfruttare qualunque opportunità di affari potesse offrire il prosieguo della guerra.
Nel frattempo, su a Roma, l’invasione della Sicilia da parte degli Alleati aveva messo in moto una reazione a catena. Il duce Benito Mussolini fu defenestrato e arrestato su ordine del re. Poi, l’8 settembre 1943, l’Italia dichiarò la capitolazione. Il re, i suoi ministri e parte dello stato maggiore si diedero alla fuga. L’apparato statale si dissolse, lasciando a soldati e cittadini disorientati l’onere di trovare da soli un modo per sopravvivere alla guerra che continuava. Nelle prime ore del mattino successivo, le forze alleate sbarcarono nella parte meridionale della penisola, a Salerno. La Germania inviò altre truppe in Italia per fronteggiare l’avanzata alleata: i tedeschi ora erano occupanti, non più camerati. L’Italia era tagliata in due: gli Alleati al Sud, i tedeschi al Centro e al Nord. Il resto del conflitto sul fronte italiano si trascinò faticosamente nella parte continentale del paese. Nel frattempo, nelle retrovie dell’Italia occupata dai nazisti, partigiani e fascisti irriducibili si fronteggiavano in una guerra civile.
Nella Sicilia liberata, l’Amgot fu sciolto alla fine di febbraio del 1944 e l’isola passò sotto l’autorità della coalizione di forze antifasciste che prendevano parte al nuovo governo civile italiano, insediato in quella parte di penisola sotto il controllo degli Alleati.
Nei due anni successivi, l’Italia completò la transizione dalla guerra alla pace e dalla Liberazione alla democrazia, una transizione segnata da quattro passaggi fondamentali:
1. Aprile 1945: finisce la guerra in Italia, appena qualche giorno prima del suicidio di Hitler.
2. Giugno 1946: la monarchia viene abolita e nasce la Repubblica.
3. Marzo 1947: il presidente Harry Truman annuncia che gli Stati Uniti prenderanno misure per tenere a freno l’espansione globale dell’Unione Sovietica. In Italia, il Partito comunista italiano si era guadagnato un grande prestigio grazie al ruolo giocato nella Resistenza e prometteva di creare una sezione del partito per ogni campanile. La penisola si trovava sulla linea del fronte nella nascente guerra fredda.
4. Aprile 1948: nelle prime elezioni politiche democratiche in Italia, la Democrazia cristiana, sostenuta dagli americani, riporta una vittoria netta e i comunisti subiscono una sconfitta altrettanto netta.
In nessun’altra regione d’Italia la transizione del dopoguerra fu turbolenta come in Sicilia. In nessun’altra regione d’Italia la criminalità organizzata fu coinvolta così a fondo in queste turbolenze. Certe aree del Sud erano roccaforti del crimine organizzato ormai da generazioni. Nella Calabria meridionale e in Campania, come vedremo, ’ndranghetisti e camorristi riuscirono a ritagliarsi una loro nicchia nell’assetto del dopoguerra, ma in Sicilia la mafia aveva mire più ambiziose. Molti siciliani considerano inappropriata l’etichetta di «crimine organizzato» per la mafia. I mafiosi sono dei criminali e lo sono sempre stati, ma dei normali criminali, per quanto organizzati, non possono contare neanche lontanamente sul tipo di amicizie politiche di cui i mafiosi più potenti hanno sempre goduto. Indirizzare i destini istituzionali della propria terra, come cercarono di fare i mafiosi siciliani dopo il 1943, è qualcosa che va molto, molto al di là dell’orizzonte mentale di un malvivente qualsiasi.
Fra le attività criminose in cui era coinvolta la mafia, la più eclatante e sanguinosa era il brigantaggio. Nel momento di massima espansione del fenomeno, nel 1945, per le campagne siciliane giravano centinaia di gruppi di banditi, in molti casi con una potenza di fuoco sufficiente ad avere la meglio nel caso di scontri a fuoco con poliziotti e carabinieri. Rapine, estorsioni, rapimenti e borsa nera garantivano a questi fuorilegge cospicui guadagni. Come tradizione, invece di unire le forze con queste bande i mafiosi preferivano, dove possibile, «coltivarle» attraverso scambi di favori: per esempio i banditi potevano versare una quota dei loro introiti alle cosche, che in cambio gli fornivano indicazioni su bersagli redditizi per rapimenti o rapine, li avvisavano in anticipo delle retate della polizia e facevano da intermediari per trattare il pagamento di un riscatto con la necessaria discrezione.
Poco dopo l’invasione alleata, i mafiosi si diedero da fare per ripristinare il loro tradizionale controllo sulla «protezione», il noleggio e la gestione dei terreni agricoli nella Sicilia occidentale. Molti dei più importanti proprietari terrieri siciliani vivevano a Palermo in uno sfarzo decadente, lasciando la gestione delle loro vaste tenute agricole a brutali intermediari della mafia. Perciò, dopo la guerra, i possidenti affittarono o affidarono in gestione le loro terre a uomini destinati a diventare boss di mafia tra i più famigerati degli anni Cinquanta e Sessanta: gente come Giuseppe Genco Russo di Mussomeli e il ventenne killer Luciano Liggio, della cittadina agricola di Corleone, in provincia di Palermo. ( Liggio aveva già un mandato di arresto spiccato a suo nome quando, dopo la misteriosa morte del suo predecessore, divenne «gabellotto» della tenuta di Strasatto, nel 1945.)
Il business dei terreni agricoli attirò inesorabilmente la mafia verso la politica. In ogni fase di turbolenza politica, nella storia siciliana recente, i contadini avevano chiesto a gran voce contratti più equi, o addirittura una quota delle proprietà terriere detenute dall’aristocrazia siciliana. La risposta definitiva alle rivendicazioni dei contadini, alla fine, l’aveva sempre data la mafia.
La questione agraria era destinata a riemergere passata la guerra, e quando questo avvenne i proprietari terrieri e i mafiosi trasformarono il terrore in uno strumento politico. Con pistole, mitragliatrici e bombe a mano si impegnarono a fondo per eliminare fisicamente i militanti agrari e intimidire i loro sostenitori. La spaventosa serie di omicidi di sindacalisti e militanti di sinistra cominciò nell’estate del 1944 e continuò per almeno dieci anni. Per esempio, nell’autunno del 1946 a Belmonte Mezzagno, vicino Palermo, i contadini formarono una cooperativa per rilevare la gestione della terra di una tenuta vicina. Il 2 novembre uno squadrone della morte composto da tredici uomini si presentò in un campo dove molti membri della cooperativa erano intenti a lavorare: i fratelli Giovanni, Vincenzo e Giuseppe Santangelo furono portati via e giustiziati uno dopo l’altro, con un colpo alla nuca.
Tanto i proprietari terrieri quanto la mafia temevano che un nuovo governo democratico a livello nazionale sarebbe stato costretto a fare concessioni ai comunisti, e di conseguenza al movimento contadino siciliano. Per questo motivo, già a partire dal 1943 mafia e proprietari terrieri patrocinarono un movimento separatista. La via all’indipendenza della Sicilia fu tracciata attraverso una serie di incontri negli anni successivi. Rampolli di alcune delle famiglie di più antico lignaggio dell’isola accolsero nelle loro sfarzose ville di campagna i capi criminali più potenti di Sicilia. In uno di questi vertici, nel settembre del 1945, i boss stipularono un accordo per aggregare una parte dei gruppi di briganti alle milizie separatiste. A Salvatore Giuliano, il capo della banda più famigerata, fu offerta una grossa somma di denaro, il grado di colonnello e la promessa di un’amnistia una volta raggiunta l’indipendenza dell’isola. Seguì una serie di assalti contro caserme dei carabinieri, finalizzate a preparare il terreno per un’insurrezione.
Alla fine non ci fu nessuna insurrezione. Le autorità dispersero lo sgangherato braccio armato del movimento, ma soprattutto tagliarono l’erba sotto i piedi alla sua leadership politica, garantendo alla Sicilia, nel maggio del 1946, l’autonomia e un proprio Parlamento regionale, ma all’interno dell’Italia. I mafiosi che avevano sostenuto il movimento separatista cominciarono a cercarsi altri soci politici.
Se il separatismo, nel 1946, era in declino, l’emergenza criminale sull’isola era più grave che mai. Gruppi di banditi, che spesso agivano sotto l’egida della mafia, effettuavano furti e rapimenti a tutto spiano. La polizia e i carabinieri inviavano a Roma dovizia di informazioni, e al centro di quel quadro a tinte fosche c’era la mafia. Come il capitano Scotten prima di loro, anche le forze dell’ordine non si facevano nessuna illusione sulla natura della mafia, come mostra chiaramente questo rapporto dell’ottobre 1946:
La mafia, organizzazione interprovinciale occulta, con tentacoli segreti che affiorano in tutti gli strati sociali, con obbiettivo esclusivo l’indebito arricchimento a danno degli onesti e degli indifesi, ha ricostituito le sue cellule o «famiglie», come qui vengono chiamate in gergo, specialmente nelle provincie di Palermo, Trapani, Caltanissetta, Enna ed Agrigento.
Questi furono quindi gli anni violenti che decisero del futuro della Sicilia. Non a caso, furono anche gli anni in cui i governanti italiani decisero di dimenticare tutto quello che sapevano sulla famigerata «organizzazione occulta» siciliana. La dimostrazione più illuminante di questo processo di oblio non è un massacro di mafia o un rapporto segreto. Per capire come funzionava davvero la mafia siciliana alla fine degli anni Quaranta, per comprendere la sua capacità unica di svanire nel nulla e allo stesso tempo di infiltrarsi nell’apparato statale, dobbiamo andare a vedere il primo film di mafia nella storia del cinema italiano.
Sicilia: «In nome della legge»
È il settembre del 1948, ma le brulle distese dell’entroterra siciliano che si stendono di fronte alla cinepresa sembrano fuori dal tempo. Un giovane in doppiopetto, il volto cesellato semicoperto da un cappello floscio di feltro, sta ritto in sella. Improvvisamente si gira a guardare un paesaggio lunare di rocce e polvere e vede otto figure a cavallo emergere dalla cima di una collina, stagliate contro il cielo.
«La mafia». Il g...