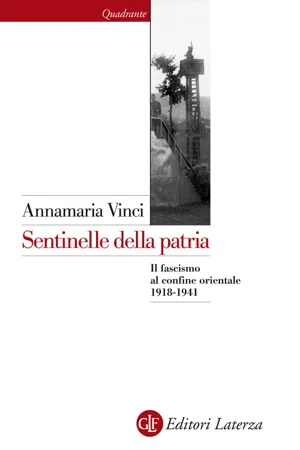1. Terre redente/terre occupate
1. «Beata cecità»
Prima che il tempo fascista cominci ad essere scandito, la furia della guerra devasta con eguale intensità luoghi, comunità, assetti amministrativi e istituzionali dall’una e dall’altra parte del vecchio confine del 1866. È il tragico inizio di una nuova epoca che ristruttura gli spazi geografici e mentali.
Litorale austriaco, Venezia Giulia, Litorale sloveno: sono molte le denominazioni (ufficiali e non) che, dalla seconda metà dell’Ottocento e almeno fino alla fine del conflitto mondiale, insistono sulla stessa area territoriale che aveva il suo fulcro nella città-porto di Trieste e le sue propaggini nel Friuli orientale (con Gorizia) e nell’Istria. I nomi segnano il sovrapporsi di storie, di aspirazioni e di idealità diverse tra loro, con diversi percorsi che spesso tuttavia si confondono, si mescolano. L’idea di tolleranza e di libertà che il glottologo goriziano Graziadio Isaia Ascoli racchiude nel 1863 nel nome inventato di Venezia Giulia, pur dichiaratamente costruito intorno ai miti della latinità e delle glorie veneziane, muta radicalmente di senso e di significato nell’età dei nazionalismi e ben presto la dizione religiosa di terre «irredente» diventa assoluta e totalizzante. Litorale sloveno è una denominazione che col tempo incalza, segnando la nascita e lo sviluppo di nuove consapevolezze nazionali.
Il Litorale austriaco è a sua volta l’unità amministrativa che congiunge unità territoriali disomogenee, regolando il rapporto centro-periferia in questa parte dell’Impero. Esso non è un semplice contenitore: rappresenta un solido punto di riferimento istituzionale, spesso un esempio di buon governo e di attiva mediazione tra popolazioni plurietniche e mistilingui. Solo quando il fermento delle aspirazioni nazionali degli italiani, degli sloveni e dei croati del Litorale cresce, mentre altri e più aggressivi nazionalismi fremono nel vecchio corpo dell’Impero, una simile forma politico-amministrativa sembra un abito troppo stretto.
Il nodo dell’irredentismo e dei contrasti nazionali tra i diversi gruppi etnici conviventi nel Litorale è stato ed è oggetto di attenta riflessione critica in chiave comparativa, nel quadro più ampio della storia europea e della vicenda asburgica a partire dalla seconda metà dell’Ottocento. Soprattutto sul versante italiano, subito dopo la creazione dell’unità nazionale, il fenomeno si presta a letture discordanti.
Scrive Elio Apih:
L’irredentismo era dunque ambivalente: per un verso esprimeva natura risorgimentale e cioè volontà di Stato nazionale unitario, e per altro verso era fenomeno asburgico, aspra competizione nazionale, con tendenze pure alla sopraffazione. Traccia di questo duplice profilo si rinviene anche nel mondo slavo. Era scaduta a concezione territoriale e municipale.
Di più: l’idea e la convinta consapevolezza che quell’assetto istituzionale e, più in generale, la sovranità asburgica fosse funzionale al forte sviluppo della città-porto di Trieste era ben chiara presso i gruppi economici dirigenti del Litorale, mentre più attente riflessioni mettevano in guardia dal perseguire idealità politiche (l’italianità come appartenenza territoriale ad un nuovo Stato) che entrassero in rotta di collisione con il destino economico del grande porto dell’Impero.
A cavallo del secolo, intanto, i contrasti nazionali esplodono; l’ardore patriottico diventa odio verso il nemico di diversa nazionalità. Formulata con grande lucidità dal giovane nazionalista giuliano, Ruggero Fauro Timeus, si fa strada l’idea della trasformazione in senso imperialista della conquista di Trieste. Da Trieste verso i Balcani. Ma un altro tragico segnale di trasformazione si affaccia:
La lotta nazionale – scrive Timeus – è una fatalità che non può avere il suo compimento se non nell’annientamento di una delle due razze che si combattono.
Sono i giovani e i giovani studenti, soprattutto, che si buttano nelle lotte nazionali con un radicalismo diverso e un culto prepotente dell’attivismo, della ribellione e della violenza; all’insegna di nuove parole d’ordine (l’Università italiana a Trieste) e con una nuova capacità di riorganizzazione associativa e di mobilitazione sembrano già pronti a cogliere i frutti della svolta che si profila.
Un piccolo ma significativo episodio è ricordato dal poeta Biagio Marin, ad anni di distanza. Impegnato insieme ad altri studenti di nazionalità italiana a rivendicare la creazione di una Università italiana a Trieste e studente a Vienna, nel maggio del 1914, deve sostenere un confronto serrato con il rettore di quella Università, dopo aver urlato di «voler la guerra all’Austria».
«Giovane uomo – interloquisce il rettore – ma Lei è consapevole della gravità di quanto ha detto?». Il resto della narrazione si gioca intorno a questa frase e nel contrasto tra il vecchio pacato e preveggente e il giovane baldanzoso e «cieco». «Noi batteremo l’Austria», replica Marin e si getta di nuovo nella mischia, serbando tuttavia nelle pieghe della coscienza quell’espressione al momento incomprensibile.
La Grande guerra svela in realtà la tragica illusione di chi a quell’«inutile strage» aveva partecipato sperando di rifondare la fratellanza dei popoli europei, una volta sconfitti gli Imperi, su basi più moderne, su un’idea della nazione come nucleo organico di una più ampia e aperta comunità internazionale, all’insegna di un federalismo da costruire. Gli stessi principi dell’autodeterminazione dei popoli, nel quadro più ampio dell’elaborazione del wilsonismo, si mostrano vuoti di significato per la pace europea.
Le lacerazioni nazionali, le pulsioni aggressive di esclusione e di rivalsa che avevano trovato una palestra perfetta negli spazi aperti dall’insorgere dei nazionalismi, non si placano. Alla fine, la contrapposizione è fra Stati sovrani, che sono alla ricerca affannosa di nuove collocazioni nell’Europa prostrata dal conflitto e che, proprio dalle esasperazioni nazionaliste, traggono spesso linfa vitale per la compattezza interna, sulla scorta delle nuove elaborazioni simboliche scaturite dal mito dell’esperienza di guerra. La tragica spirale dell’intolleranza e dell’odio ora agisce sia dentro gli Stati, nel confronto con la presenza forte delle minoranze nazionali, sia lungo i confini tracciati, incerti, contesi, violati. Il processo di brutalizzazione cui la guerra abitua, si innesta poi nelle politiche della ricostruzione e della ricerca di pace.
Le periferie territoriali e politiche a volte funzionano, com’è ben noto, non da semplici depositi delle decisioni prese dall’alto o da centri politici o economici di rilievo: interagiscono invece in un rapporto di fitta reciprocità, diventando laboratori di scelte e di orientamenti decisivi per aree e per ambiti molto più vasti. Così per la Venezia Giulia conquistata; così per il Friuli, già parte del Regno d’Italia.
Il dopoguerra, inquieto e travagliato per tutta Italia, qui diventa l’epicentro di un terremoto che nuovi studi e nuove acquisizioni documentarie stanno ora svelando in tutta la sua portata. Il bilancio delle distruzioni e dei danni provocati dalla guerra «in casa» è pesantissimo: lunghi anni di assalti e ritirate sul Carso, paesi del Friuli orientale e Gorizia stessa, occupati e liberati più volte dagli eserciti in lotta, la rotta di Caporetto, devastazioni, bombardamenti sulle case e sulle fabbriche, saccheggi.
2. In fuga
Un fenomeno legato alla guerra e destinato a moltiplicare negli anni i suoi effetti è poi quello degli spostamenti di popolazione, degli sradicamenti forzati, delle fughe precipitose che spopolano intere zone, aprendo le vie della profuganza e dei ritorni, tra spaesamenti e rabbia.
Giovani irredenti mettono in gioco, da volontari, la loro vita per l’Italia, sulla base di motivazioni profonde o di scelte di colleganza amicale, all’interno di un gruppo abbastanza folto e molto variegato, tenuto tuttavia insieme da aspetti di iniziazione generazionale, secondo modelli che si stavano manifestando in tutta Europa. Altri giovani, vicini all’età di leva, vengono portati in Italia nell’estate del 1914 direttamente dalle famiglie, impaurite dal rischio del conflitto. A volte sono le stesse famiglie a lacerarsi di fronte alle scelte dei «giovani uomini»; per i padri il richiamo della lealtà verso il vecchio Impero è parte di un universo di valori intangibili. In alcuni casi condannano pubblicamente la ribellione dei figli; in altri, cercano tortuose soluzioni. Iginio Brocchi, importante esponente liberal-nazionale di Trieste, destinato ad una prestigiosa carriera nell’Italia del dopoguerra, facilita, ad esempio, la fuga del figlio negando tuttavia tale scelta a se stesso, mobilitato nell’esercito austriaco, per non aver voluto «mancare alla parola data, anche se data al nemico».
Molti irredentisti diventano a loro volta punto di coagulo della rivolta della minoranza che agita le piazze italiane a favore dell’intervento, contro le titubanze del Parlamento: spesso sono loro a creare con i comizi, la stampa e una fitta produzione di proclami e libelli, una spinta emozionale che coinvolge l’opinione pubblica quanto meno nella sua dimensione urbana. Per una più grande Italia: di frequente dai fuoriusciti irredenti, la missione «redentrice» della patria verso i suoi «figli in catene» è evocata come predizione di ambiziosi progetti imperiali da nuova potenza europea in gestazione. Altrettanto spesso i fuoriusciti meno giovani entrano nei gangli della politica estera italiana per condurre la battaglia nelle retrovie politiche e diplomatiche.
Su un altro versante si dispongono poi coloro che, pur vivendo e lavorando da anni nel Litorale (la crescita economica e demografica di Trieste a cavallo del secolo era stata travolgente tanto che la popolazione passa da 104.707 abitanti, nel 1859, a 229.500 nel 1910), non hanno tuttavia ancora acquisito, per i più diversi motivi, diritti di cittadinanza nel vecchio Impero e diritti di pertinenza nei comuni in cui avevano il domicilio.
Così le partenze, accompagnate da musiche e canti, dei molti militari che l’esercito austriaco invia dal Litorale al confine orientale dell’Impero, sul fronte della Galizia, si incrociano...