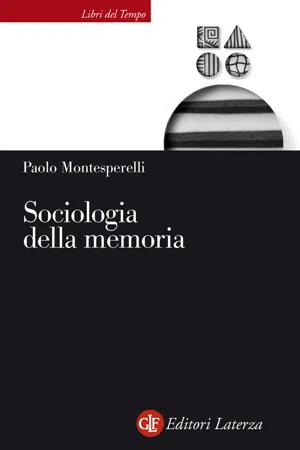
- 178 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Sociologia della memoria
Informazioni su questo libro
Un viaggio lungo i tortuosi sentieri della memoria, fra le antiche 'mnemotecniche' e le attuali risorse ermeneutiche. Come la memoria si fa identità individuale e storia collettiva, fascino e minaccia, legittimazione e conflitto.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Sociologia della memoria di Paolo Montesperelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Scienze sociali e Sociologia. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
Scienze socialiCategoria
Sociologia1. La memoria come oggetto
1.1. La memoria collettiva
In un suo racconto Voltaire (1775) immagina una controversia fra Descartes e Locke: per il primo la memoria è insignificante sul piano metafisico, perché tutte le idee sono nell’anima fin dalla nascita; per il secondo la memoria è al contrario molto importante, perché immagazzina le impressioni dei sensi. Intorno ai due protagonisti le opinioni si dividono: gli ondivaghi luminari della Sorbona condannano ora l’una ora l’altra tesi, mentre la «umanità pensante» – che, secondo Voltaire, costituisce la centomillesima parte del genere umano – si schiera a favore di Locke.
Per dirimere la contesa intervengono le muse – figlie di Mnemosyne, dea della memoria –, le quali ricorrono a un experimentum crucis: cancellano per qualche giorno ogni forma di memoria, gettando l’umanità in un caos ancora peggiore di quello scoppiato a Babele (cfr. infra, par. 3.1). La gente dimentica le nozioni più elementari (ad esempio, come fare per assumere cibo e per eliminarlo); così come smarrisce ogni inibizione, compresi i divieti di rubare e di fornicare. In breve, la stessa sopravvivenza della società è in grave pericolo.
Dimostrato il loro punto, le muse ripristinano la memoria e tutti (tranne forse Descartes) riconoscono la fondatezza della tesi di Locke: senza memoria nulla può funzionare.
Come ci suggerisce questo racconto, la memoria è indispensabile per governare ambiti vastissimi: dai gesti quotidiani dei singoli fino alle norme sociali di intere collettività. Interessarsi alla memoria, dunque, significa affrontare un tema cruciale «non solo per la sua ampia polisemia, ma perché ciascuno dei significati rinvia comunque ad un valore strategico della nebulosa memoria entro la sfera scientifica nel suo insieme» (Le Goff 1979, p. 1068).
Nelle prossime pagine non ripercorrerò sistematicamente i molteplici significati cui allude Le Goff; ma farò uso tuttavia – e fin da ora – della distinzione fra memoria e ricordo1. Quest’ultimo costituisce una specie di «memoria privata» ritagliata sul vissuto del singolo individuo, mentre il concetto di memoria non si esaurisce entro i confini della soggettività individuale.
Secondo Halbwachs (1924), infatti, il ricordo individuale è sorretto e organizzato dalla «memoria collettiva», ossia da un contesto sociale di cui fanno parte il linguaggio, le rappresentazioni sociali del tempo e dello spazio2, le classificazioni degli oggetti e della realtà esterna al soggetto, i rapporti che l’individuo intrattiene con la memoria degli altri membri di uno stesso ambiente sociale ecc.3. «Non basta ricostruire pezzo a pezzo l’immagine di un avvenimento passato per ottenere un ricordo. Bisogna che questa ricostruzione sia fatta a partire da dati o da nozioni comuni che si trovano dentro di noi tanto quanto negli altri, perché passano senza sosta da noi a loro e reciprocamente; questo è possibile solo se tutti fanno parte, e continuano a far parte, di una medesima società. Soltanto così si può comprendere come un ricordo possa essere contemporaneamente riconosciuto e ricostruito» (Halbwachs 1949/1996, pp. 45-46).
Per questa ragione se, ad esempio, «non ricordiamo la nostra prima infanzia, è in effetti perché le nostre impressioni non si possono attaccare a nessun rapporto, e non siamo ancora degli esseri sociali» (Halbwachs 1949/1996, p. 49). Per converso, «i fatti e le nozioni che facciamo meno fatica a ricordare sono di dominio comune, almeno per qualche ambiente sociale. Questi ricordi sono dunque in una certa misura “di tutti”, ed è per il fatto che possiamo basarci sulla memoria degli altri che siamo capaci di riportarli alla mente in ogni momento e quando lo vogliamo» (Halbwachs 1949/1996, p. 59). Sicché ricordare significa rievocare attraverso l’interazione sociale, il linguaggio, le rappresentazioni collettive, le classificazioni ecc., ossia riattualizzare la memoria del gruppo sociale di appartenenza (Halbwachs 1924; cfr. Jedlowski 1996, p. 20).
L’influenza che Halbwachs attribuisce alla dimensione collettiva potrebbe apparire deterministica4, ma è difficile negare che essa giochi un ruolo importante, almeno nel dettare i criteri di plausibilità e di significatività dei ricordi: «se qualcosa non è plausibile – cioè realistico, sensato, simile o coerente con altre cose dette da altri – diventa difficile per me stesso prestarvi fede. Quando non è la plausibilità a essere in gioco, lo è quanto meno la rilevanza di ciò che ricordo: ciò che nessuno intorno a me conferma o menziona tende a scomparire e, se non sparisce, tende a diventare irrilevante» (Jedlowski 2000a, p. 22, corsivi dell’autore; cfr. Schütz 1970).
Attraverso quel fondo comune di ricordi, e grazie anche alle interazioni sociali necessarie per fissarli, ordinarli gerarchicamente e rievocarli, la memoria collettiva contribuisce alla coesione e all’identità sociali (Schütz 1971-1973/1979, p. 134). In particolare il suo contributo riguarda la rappresentazione del passato: per questo motivo può essere intesa come «ciò che resta del passato nel vissuto dei gruppi, oppure ciò che questi gruppi fanno del passato» (Nora 1978, p. 59).
Il riferimento ai gruppi e non all’intera società mi pare utile a richiamare la presenza di identità, culture, interessi, ceti, istituzioni entro una stessa società. A questa molteplicità di categorie sociali corrisponde la pluralità di memorie collettive entro un medesimo sistema sociale (Halbwachs 1949). In tal senso la memoria collettiva è intesa come «la selezione, l’interpretazione e la trasmissione di certe rappresentazioni del passato a partire dal punto di vista di un gruppo sociale determinato. Ma poiché ogni società comprende più gruppi, i cui interessi e i cui valori possono differire tra loro, dovremo aggiungere che la memoria collettiva è sempre intrinsecamente plurale: è il risultato, mai definitivamente acquisito, di conflitti e di compromessi tra volontà di memoria diverse. Il luogo in cui queste volontà si confrontano è la sfera pubblica, l’arena in cui gruppi diversi competono per l’egemonia sui discorsi plausibili e rilevanti all’interno della società nel suo insieme» (Jedlowski 2000a, pp. 32-33).
Tornerò più avanti su quella pluralità e sulla memoria come posta in gioco nella competizione per l’egemonia (cfr. infra, par. 1.3); per ora mi limito a sottolineare che ciascuno attraversa «realtà plurime» e «stili cognitivi» variegati (Schütz 1971-1973), incontra altre persone, si imbatte in oggetti diversi che, comunque, custodiscono segmenti di memoria. Questi possono essere differenti fra loro, come vedremo meglio successivamente; ma, seppur diversi, hanno una caratteristica in comune: sono prodotti umani esterni al singolo e accessibili alla collettività. In altri termini la memoria non è solo un bagaglio di conoscenze interno a ciascun individuo; essa si proietta all’esterno (esteriorizzazione), diviene collettiva perché condivisa, intersoggettiva, accessibile oltre l’hic et nunc (oggettivazione: cfr. Berger, Luckmann 1966/1969, pp. 57 sgg.).
La società crea «protesi» esterne che sollecitano o potenziano le capacità mnemoniche dei singoli: testi, immagini, testimonianze, archivi, tecniche di memorizzazione ecc. (Leroi-Gourhan 1964-1965; Yates 1966).
Altri elementi, pur non avendo direttamente questo scopo, possono sollecitare comunque la memoria. Persino l’aspetto fisico di una persona può conservare un ricordo, un passato riconosciuto, una tradizione mantenuta, un’eredità che si trasmette da generazione a generazione. In alcune pagine commosse e profonde Marcel Proust descrive come, nelle settimane che seguirono la morte della nonna, gli sembrasse che all’improvviso, nei suoi tratti, nell’espressione, in tutto il suo aspetto, sua madre venisse a identificarsi con colei che scompariva, mostrandogliene l’immagine come se, attraverso le generazioni, si riproducesse la memoria di un medesimo tipo umano5.
I frammenti del passato si imprimono anche attraverso certi luoghi fisici, ad esempio nel tessuto urbano di una città, che talvolta ha capacità evocative maggiori delle celebrazioni ufficiali: «In ogni epoca c’è uno stretto rapporto tra gli abitanti, lo spirito di un gruppo e l’aspetto dei luoghi in cui vive. C’è stata una Parigi del 1860, la cui immagine è strettamente legata alla società ed ai costumi di allora. Non basta, per evocarla, cercare le targhe che commemorano le case dove hanno vissuto o sono morti dei personaggi celebri di allora, e nemmeno leggere una storia delle trasformazioni di Parigi. È nella città e nella gente di oggi che un osservatore attento può cogliere molti tratti di allora» (Halbwachs 1949/1996, p. 78).
Anche l’architettura sembra svolgere la funzione di «preservare il passato in forma solida» (Kern 1983/1995, p. 54). Proust nota come, ad esempio, una chiesa è uno spazio composto da quattro dimensioni, di cui la quarta è il tempo; considerarli congiuntamente gli suscita preziosi ricordi dell’infanzia e richiama «il dramma della storia». Osservazioni analoghe affiorano nei pensieri di Simmel (1911) di fronte ad alcune rovine.
Le sensazioni di Proust o di Simmel sono ricordi individuali che però, oltre a essere presumibilmente condivisi da altri, vengono esteriorizzati, resi accessibili a tutti grazie al linguaggio. Fra le modalità che consentono a un’espressione soggettiva, quale può essere un ricordo, di oggettivarsi spicca proprio il linguaggio (cfr. infra, par. 3.2): infatti «le convenzioni verbali costituiscono il quadro contemporaneamente più stabile e più elementare della memoria collettiva [...]; ragionare per costruire un ricordo significa collocare in uno stesso sistema di idee le nostre opinioni e quelle del nostro ambiente; significa scorgere in quello che ci capita un’applicazione particolare di fatti di cui il pensiero sociale ci rammenta in ogni momento il senso e la portata che hanno per lui [...]. Così i quadri della memoria collettiva racchiudono e uniscono gli uni agli altri i nostri ricordi più intimi» (Halbwachs 1924/1997, p. 82; cfr. Berger, Luckmann 1966/1969, pp. 60 sgg.)6. «Ancorati al linguaggio, pensieri – e quindi esperienze ed impressioni – che, una volta passati, sarebbero destinati a sbiadire e perdersi, restano invece a portata di mano [...]. Esplicitato nel linguaggio, il pensiero si oggettivizza» (Marradi 1994, p. 180).
Per questo rapporto fra linguaggio e pensiero, i mutamenti del primo possono ripercuotersi nella sfera del secondo, nelle modalità di organizzazione della memoria, nelle espressioni di una cultura. Nelle scienze sociali7 Ong (1973; 1982) è uno degli studiosi che più ha insistito sulla storicità del pensiero e della memoria, quando egli ricostruisce lo sviluppo diacronico dalle culture orali primarie, nelle quali cioè la scrittura era (quasi) del tutto assente, alle culture nelle quali la scrittura ha conquistato la preminenza.
Le culture orali non hanno testi in cui custodire la memoria collettiva; dispongono solo delle abilità mnemoniche degli anziani che si affinano con l’esercizio e per questo loro monopolio godono di grande prestigio (cfr. Yates 1966).
Nell’antica Grecia la cultura orale resta a lungo preminente, non solo in tempi arcaici. Le ragioni più profonde risalgono all’organizzazione della società – come testimonia un famoso passo della Politica di Aristotele: «Uno Stato composto di troppi non sarà un vero Stato per il semplice motivo che non può avere una vera costituzione. Chi può essere il generale di una massa tanto smisurata? E chi può esserne l’araldo se non Stentore?» (1326b 3-7)8.
Come nota Finley, è illuminante il riferimento all’araldo, o banditore, perché sta a indicare una caratteristica importante: «Il mondo greco era innanzitutto il mondo della parola parlata, non scritta. Gli affari pubblici venivano diffusi dall’araldo [...], dai rapporti verbali e dalle discussioni delle varie commissioni e assemblee che costituivano la macchina governativa». La conduzione stessa del potere si affidava prevalentemente all’oralità: «La democrazia ateniese – continua Finley – era diretta, non rappresentativa, in un duplice senso: ogni cittadino poteva partecipare all’assemblea sovrana e se escludiamo alcuni addetti, schiavi di proprietà dello Stato che curavano le registrazioni indispensabili (copie di trattati e di leggi, elenchi di contribuenti morosi e simili), non esisteva alcuna forma di burocrazia. Perciò il governo era “del popolo” nel senso più letterale dell’espressione. L’assemblea, che aveva la parola definitiva sulla guerra e sulla pace, sulla finanza, sui trattati, sulla legislazione, sulle opere pubbliche, in breve sull’intera gamma dell’attività governativa, era una riunione di massa all’aperto di tutte quelle migliaia di cittadini di età superiore a 18 anni che in quel dato giorno potevano e volevano parteciparvi. Si riuniva frequentemente nel corso dell’anno, almeno quaranta volte, e di norma raggiungeva la decisione sull’oggetto in discussione con un dibattito di un solo giorno al quale, in linea di principio, ciascuno dei presenti aveva diritto di partecipare salendo in tribuna. Gli scrittori greci usavano talvolta come sinonimo di “democrazia” il termine isegoria, il pari diritto di rivolgersi all’Assemblea» (Finley 1972/1973, pp. 18-19).
È di origine orale, e quindi presta grande attenzione all’abilità mnemonica, anche la tradizione poetica, che nell’antica Grecia riveste un ruolo così importante nella socializzazione. I greci considerano la memoria una componente genetica nella produzione artistica: è Mnemosyne, sorella di Crono, a generare le muse9.
Per sopperire alla difficoltà di ricordare la trama e i versi, la poesia epica ricorre frequentemente (molto più spesso che nelle epoche successive) alla «schematizzazione caratteriale»: l’intenso pathos, i tratti forti si incidono in maniera più duratura nella memoria. Se invece il poeta adottasse tinte più tenui e sfumate, i versi cadrebbero più facilmente nell’oblio. In base al principio secondo cui un profilo semplice e netto, anziché sfumato e complesso, è più facile da ricordare, le figure eroiche tendono alla tipizzazione: il saggio Nestore, l’impulsivo Achille, l’astuto Ulisse ecc. (Ong 1982/1986, p. 103). Analogamente per le figure bizzarre: è più facile ricordare il Ciclope che non un mostro con due occhi, o Cerbero piuttosto che un cane con una sola testa (cfr. Yates 1966).
Anche alcuni vincoli formali (quali la rapsodizzazione, la scansione in versi, il parallelismo fra versi consecutivi, il metro, le metafore, le similitudini ecc.) svolgono la stessa funzione di facilitare la memorizzazione. Ne sono un esempio l’Iliade e l’Odissea: esse hanno origine orale e si sono tramandate per molto tempo senza ricorrere a testi scritti né alla memoria letterale10.
Nel passaggio dalla poesia in versi alla prosa si perde il sostegno del metro, della rapsodizzazione e della rima. Nel mondo classico la prosa più nobile si usa nell’oratoria. Colui che deve tenere un discorso in assemblea non può giovarsi di appunti, poiché sarebbe considerato un oratore mediocre (Weinrich 1997/1999, p. 106). Per pronunciare lunghi discorsi a memoria con infallibile accuratezza, l’oratore si affida alle «mnemotecniche» che costituiscono una componente essenziale della retorica (cfr. Yates 1966; Blum 1969).
Un espediente molto usato consiste nel fissare i ricordi attraverso «luoghi» e «immagini». Probabilmente il primo a teorizzarlo fu il poeta Simonide di Ceo (vissuto sul finire del VI secolo a.C.): egli si rese conto che una disposizione ordinata è essenziale per una buona memoria. L’ordine si ottiene attraverso la spazializzazione della memoria, considerata una vera e propria «arte dello spazio» (topica): in pratica si tratta di immaginare una costellazione fissa di «luoghi» (topoi), nei quali l’oratore depone i...
Indice dei contenuti
- Introduzione
- 1. La memoria come oggetto
- 2. La memoria come limite
- 3. La memoria come risorsa
- Riferimenti bibliografici