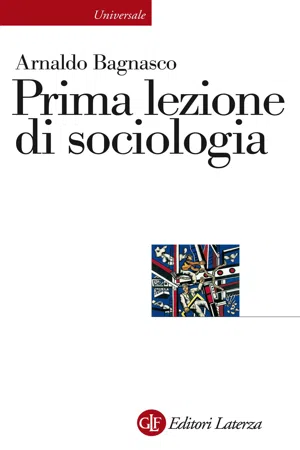1. Un’idea di sociologia
1.1. L’immaginazione sociologica
In questa lezione parlerò della sociologia, in realtà di un insieme composito di programmi scientifici che sono intesi con questa parola. In tale varietà, l’aria di famiglia si avverte nel fatto che chi la pratica riconosce ascendenze comuni, risalenti a un periodo di fondazione fra Ottocento e primo Novecento. Riconoscere una eredità classica è un modo per mantenere oggi i confini con l’esterno e insieme per far convivere, all’interno, approcci che restano diversificati: diversificati al punto che ha forse ragione chi dice che sarebbe meglio parlare di sociologie piuttosto che di sociologia.
C’è però anche un altro modo per individuare una relativa unitarietà, riferendosi all’esperienza di lavoro di chi si pensa come un sociologo. Di un sociologo si può dire che professionalmente coltiva, sviluppa, applica a fini di conoscenza, diffonde immaginazione sociologica, sia pure con sensibilità e in modi diversi.
Questo termine è stato introdotto da Charles Wright Mills, un sociologo americano che la tradizione classica ha frequentato e che negli anni del secondo dopoguerra si è impegnato in importanti ricerche; nel 1959 egli pubblicò un libro sullo stato e sulle prospettive della disciplina nel suo paese, appunto con quel titolo. Per Mills (1962: 15-20), l’immaginazione sociologica è una particolare qualità della mente; chi la possiede è capace di fare un certo ordine nell’ambiente sociale che lo circonda, è capace, come lui dice, di percepire l’ordito della società e la trama tessuta su questo da uomini e donne che spesso si fanno un’idea falsa della loro posizione; è in grado di riconoscere la sua condizione come simile a quella di altre categorie di persone, con le quali condivide problemi e prospettive; riesce a distinguere difficoltà personali, circoscritte all’ambiente immediato e in questo affrontabili, da problemi pubblici che nascono nella più grande organizzazione della società e nel funzionamento delle sue istituzioni; questa capacità di connettere questioni private a problemi pubblici, comprendendone le ragioni, è l’essenza dell’immaginazione sociologica.
L’immaginazione sociologica, in sostanza, è dunque la capacità di comprendere, per quanto si riesce, come la società è fatta e funziona, nell’ambiente prossimo e più generale, perché in essa diventi possibile vivere con consapevolezza e, in certa misura almeno, autodeterminazione. L’argomento principale di Mills è che ci sia un bisogno crescente di immaginazione sociologica nelle complesse società della nostra epoca, e che appunto la sociologia ne sia, dalle sue origini, un sistematico produttore. A ben vedere, si tratta sia di produzione di informazioni allargate e attendibili su fenomeni sociali di cui sempre meno si ha esperienza diretta, sia di interpretazioni e spiegazioni delle loro cause e della loro possibile evoluzione; informazioni e interpretazioni che devono essere a uso di ciascuno, in quanto diffuse nell’intero corpo sociale (su questo insiste in particolare Mills), ma evidentemente anche necessarie per orientare l’azione di governo della società.
Spostare l’attenzione dalla sociologia all’immaginazione sociologica permette osservazioni importanti. Anzitutto, in quanto qualità della mente, l’immaginazione sociologica non è patrimonio esclusivo dei sociologi; con questa definizione si può ammettere che la sociologia è solo uno dei modi in cui si conosce la società, e che da sempre storici, filosofi, geografi, pittori, poeti, moralisti, romanzieri ci hanno fatto conoscere aspetti della società del loro tempo o modi di concepire la vita di relazione così come nel loro tempo era possibile. La Comédie humaine o la Recherche non sono forse fonti inesauribili di documentazione e interpretazione della società francese dell’Ottocento e del primo Novecento? E la loro lettura non ci aiuta a distinguere cosa è utile osservare di una società per capirla, e non sviluppa la nostra sensibilità a intuire come gli uomini e le donne la vivono, la subiscono, ma anche si adattano e la plasmano?
Ma c’è di più. È certamente vero che spesso le persone si fanno un’idea falsa della società. Ma è anche vero che senza una certa dotazione di immaginazione sociologica nessuno potrebbe vivere in società, e che ognuno applica quella di cui dispone. È un punto, questo, che va preso molto sul serio. Non solo significa che esiste una sociologia per così dire personale, più o meno consapevole e ricca; significa anche che una sociologia professionale deve fare i conti con le idee che, della situazione sociale in cui si trovano, le persone si fanno. Questo corrisponde a un principio che i sociologi chiamano il teorema di Thomas: una situazione definita dagli attori come reale ha conseguenze reali; ovviamente, anche se non lo era. Il sociologo, con la sua immaginazione addestrata, potrà chiarire le cose in casi come questi; e dovrà anche mettere in conto che molte volte la comprensione sociologica di una situazione o di un processo da parte delle persone che applicano la loro dose di immaginazione sociologica non è affatto sprovveduta: rivela intelligenza e capacità adattive, dalle quali derivano comportamenti e conseguenze da considerare.
Quante volte etichettiamo sbrigativamente come abitudinario, irriflessivo, irrazionale un comportamento che in realtà è ben consapevole dei vantaggi di una certa pratica tradizionale, e del fatto che, dati i vincoli della situazione, non ci sono soluzioni migliori, e che dunque sarebbe troppo costoso e incerto (irrazionale) cambiare? A non tener conto dell’immaginazione sociologica delle persone, e delle conclusioni pratiche che queste ne derivano, molti sociologi hanno commesso molti errori. Sociologi poi che pensino per principio di poter sapere quale sia l’interesse delle persone, anche se le persone tale interesse non riconoscono, sono pericolosi: lo pensava anche Mills. Il quale poi ammette che possono esserci modi diversi di coltivare e applicare immaginazione sociologica, ma è piuttosto radicale nelle critiche ai colleghi. Vedremo più da vicino, a suo tempo, il genere al quale appartiene l’immaginazione sociologica propria di Mills, e non saremo così radicali nei confronti di altri. Dobbiamo però tornare ora dall’immaginazione sociologica alla sociologia.
La sociologia nasce come progetto di un campo di studi dove vengano applicati canoni del metodo scientifico alla conoscenza sistematica dell’organizzazione sociale e dei modi in cui le persone la generano e ne sono condizionate. L’idea è proprio quella di una possibile scienza della società, che stabilisce dunque, almeno nelle intenzioni, confini abbastanza chiari con forme di conoscenza non scientifica di questa.
Più complicata, anche nelle intenzioni, è la questione di altri confini, ovvero dello spazio che la scienza della società può conquistarsi, perché quando la sociologia entra sulla scena, già altre scienze sociali hanno cominciato a definire e coltivare ambiti particolari di conoscenza che riguardano differenti aspetti della società.
Tutte le scienze sociali sono figlie della modernizzazione e del bisogno di conoscenza in un’epoca di grandi trasformazioni. L’onda del cambiamento si è formata nel tempo, con la transizione demografica e l’aumento della popolazione, la crescita delle città, lo sviluppo del capitalismo e la rivoluzione industriale, la comparsa di forme democratiche di governo, l’affermarsi di nuovi costumi e nuove idee, in particolare la fiducia nella ragione e nella possibilità che questa aiuti l’uomo a prendere in mano il proprio destino.
Il positivismo è la corrente filosofica che esprime nel modo più esplicito la fiducia nella scienza che si diffonde in Europa all’inizio dell’Ottocento, a seguito dei suoi grandi successi. Auguste Comte, che ne è il principale esponente, pensa che la conoscenza positiva permetta di superare quella tipica di stadi precedenti dell’evoluzione sociale: la conoscenza teologica, prima, e la metafisica, poi. Ponendosi solo problemi affrontabili con riferimento diretto a fatti concreti, il mondo diventa davvero comprensibile e spazi bui saranno gradatamente illuminati; le scienze hanno liberato la conoscenza da tutele improprie e con i loro metodi possono anche riorganizzare le teorie sociali. «In avvenire – questa la conclusione – costituiranno, una volta sistematizzate, la base spirituale permanente dell’ordine sociale, finché durerà sulla terra l’attività della nostra specie» (citato in Aron 1972: 13).
È in questo clima, positivo e profetico insieme, che Comte immagina una fisica della società, che poi chiamerà sociologia, intesa come «regina delle scienze»; questa si occupa infatti del più complesso dei sistemi, superiore per complessità a quelli di cui si occupano le altre, in una gerarchia sino alla biologia; la sociologia, scienza dell’umanità, è anche in grado di organizzare e dare un senso alle altre scienze, perché può orientarne lo sviluppo al servizio dell’uomo. Nell’ordine naturale, più si sale in complessità, più le leggi diventano imprecise, ma aumenta anche la modificabilità dei fenomeni. Conoscere le leggi dei fatti sociali consente allora di constatare le direzioni in cui si muove naturalmente l’umanità e permette di assecondare le tendenze, per rendere il cambiamento più facile e vantaggioso.
Nessuno pensa più oggi a una sociologia così ambiziosa, ma neppure si trova chi ancora condivide l’ottimismo di Comte a proposito della scienza. La sociologia per crescere ha dovuto liberarsi di molte idee di Comte; quanto alle possibilità di un ordine sociale scientificamente costituito, anche a costo di dure lezioni della storia abbiamo imparato che le cose sono un po’ più complicate. Un punto da notare è che Comte in Francia, ma anche Herbert Spencer in Inghilterra, pensano all’inizio a un’unica scienza della società. Come anche a un’unica scienza della società, incaricata di cambiare radicalmente il mondo e di farlo uscire dalla sua preistoria, pensava Karl Marx.
Riflessioni sistematiche sulla società sono germogliate in paesi diversi ben prima della sociologia, e confluiranno in modi diversi di intendere una possibile scienza della società. Alcuni programmi si sforzeranno di rimanere più vicini possibile alle scienze naturali, altri si faranno subito carico delle differenze rilevanti che derivano dal fatto che la società è composta di uomini, esseri che pensano e che hanno comportamenti meno prevedibili di quelli dell’acqua a 100 gradi di temperatura a livello del mare, o anche di un topo che pure impara a evitare trappole elementari per arrivare al formaggio. Presto comunque sono diventati chiari i molti problemi connessi al tentativo di sviluppare una scienza della società.
Anzitutto la questione dei confini. Piuttosto che destinata a un non discutibile ruolo regale, la sociologia si è trovata, come si è detto, a farsi largo fra altre scienze sociali che avevano definito e occupato prima un proprio spazio specializzato, e fra altre che lo avrebbero trovato: l’economia, prima scienza sociale, da tempo in cerca dei principi della ricchezza delle nazioni secondo la formula di Adam Smith, che nel Settecento si era reso conto di come una intera economia stesse rapidamente crescendo, regolata da una specie di mano invisibile – il mercato – capace di coordinare in un effetto complessivo e inatteso una miriade di atti individuali, attenti ognuno a un tornaconto particolare; l’antropologia, che aveva cominciato a conquistare il suo spazio scientifico, emancipata dalla filosofia, a seguito delle esplorazioni di paesi lontani, e che marcherà una distanza dalla sociologia fino a quando conserverà la vocazione allo studio delle culture «altre», ma che si avvicinerà in modo pericoloso successivamente, in quanto capace di affrontare temi dei costumi e della cultura contemporanea; la scienza politica, anche questa precedente alla sociologia, specializzata nello studio di un ambito cruciale dell’organizzazione sociale; e l’elenco potrebbe continuare, aggiungendo la geografia sociale, per esempio, la demografia, la linguistica, o anche la psicologia; quest’ultima emancipata come disciplina autonoma a partire da radici filosofiche, mediche e pedagogiche (Collins 1996: 21).
Il progetto originario è dunque manifestamente impossibile e sempre più si svilupperanno diverse e anche nuove scienze sociali, confinanti e con rapporti da stabilire e continuamente ricercare, senza che una sola scienza sociale, la sociologia, possa pretendere di comprenderle in un unico progetto.
E tuttavia qualcosa dell’idea di Comte e Spencer resterà nella sociologia, quella di una possibile scienza generale, anche se ormai non unica, della società. Cosa può significare questo, nelle condizioni che abbiamo visto? Come è possibile pensare una conoscenza sistematica dell’organizzazione sociale, già sapendo che punti di vista specifici e differenziati sulla società sono pertinenti ed efficaci? Di che cosa bisogna precisamente occuparsi, e come? Sono queste le domande che, riproponendosi di continuo, definiscono i problemi e le opportunità della sociologia.
Di fatto, nell’ambiente affollato in cui la sociologia si è mossa, possono essere individuati differenti tipi di adattamento a partire dalle pretese iniziali. Resterà tuttavia una vocazione della sociologia a provare a connettere aspetti diversi dei fenomeni sociali, da altri separati; a trovare punti di vista che lo permettano; a fare da ponte fra prospettive differenziate; a criticare modelli di altre scienze sociali diventati troppo autoreferenziali e, per così dire, senza spessore sociale; a restituire immagini ricomposte della società. È difficile dire fino a che punto sia riuscita in questo, ma è vero che ha dato il meglio di sé in questi tentativi, e che si tratta di interessi conoscitivi rilevanti. Le teorie che hanno cercato di rispondere a questa vocazione costituiscono la sociologia come scienza generale della società.
Ci si può chiedere se questa vocazione alla ricomposizione del sociale non sia già specifica della storia. È il problema di un altro confine. È vero che, per contenuti e metodi, sociologi e storici – o per lo meno alcuni di loro di entrambe le tradizioni – si sono trovati a volte vicini. Tuttavia le differenze esistono e sono percepibili. Gli storici sono consapevoli della complessità della realtà e della unicità di ogni avvenimento e vicenda, puntano quanto più possibile al concreto, ricostruiscono concatenazioni di fatti ed eventi con una intenzione individualizzante. Anche i sociologi sono consapevoli della complessità del reale, ma in modo esplicito semplificano, con l’obiettivo di costruire modelli astratti, di individuare tipi di società messe a confronto in riferimento a caratteri ritenuti essenziali, di trovare regolarità, anche se non leggi del divenire; in questi termini, si può dire che producono piuttosto strumenti per l’analisi storica che non analisi storiche, e che poi osservano la realtà per quello che tali strumenti permettono di vedere.
La vera fondazione della sociologia avviene ad opera di un insieme di pensatori e ricercatori sociali che Raymond Aron ha chiamato la «generazione fra due secoli». Émile Durkheim è il primo a ottenere in Francia una cattedra universitaria con il nome della nuova disciplina, ma soltanto nel 1913, dopo anni di insegnamento e con il titolo «scienza dell’educazione e sociologia».
Una volta riconosciuto che ci sono domande che la scienza può e deve porre e altre no, fin dove arrivano le domande proponibili sulla società? Durkheim pensa che i fatti sociali vadano pensati come «cose» e debbano essere spiegati solo con altri fatti sociali che ne sono le cause, accertabili da corre...