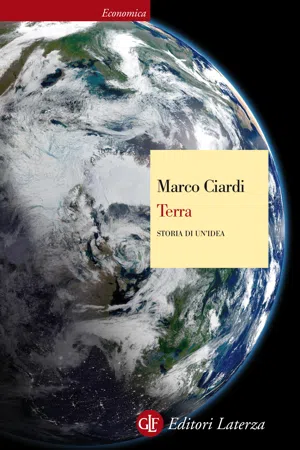1.
La fine delle stelle fisse
L’idea che nel Medioevo si ritenesse la Terra piatta rappresenta un clamoroso mito storiografico: «è solo in tempi recenti (diciamo meno di due secoli)», ha scritto Umberto Eco, «che si inizia ad attribuire al Medioevo quella strana credenza». Infatti, «il pensiero laico ottocentesco, irritato dal fatto che la Chiesa non avesse accettato l’ipotesi eliocentrica, ha attribuito a tutto il pensiero scolastico l’idea che la Terra fosse piatta». La storia è sempre più complessa delle spiegazioni che noi vorremmo attribuirle. Ad esempio, John Holywood (meglio noto come Giovanni Sacrobosco), che insegnò all’Università di Parigi, realizzò nella prima metà del Duecento un trattato, dall’emblematico titolo De sphaera mundi, destinato ad avere una grande fortuna, in cui era chiaramente enunciata la concezione sferica della Terra. Del resto, la sfericità della nostra casa era già ben nota agli antichi, da Aristotele fino a Eratostene, direttore della famosissima biblioteca di Alessandria d’Egitto, il quale riuscì a determinare in maniera accurata la misura delle dimensioni del globo terrestre.
Diversamente dalla questione della terra piatta, le opinioni cambiavano completamente se si iniziava a parlare della posizione del pianeta nell’universo. Secondo la tradizione, infatti, la Terra si trovava immobile al centro del cosmo. Era tutto il resto che le girava intorno. Già, ma come facevano i corpi celesti a restare sospesi in aria? Gli antichi non conoscevano la forza di gravità e furono costretti a inventarsi una soluzione plausibile: i pianeti (tutti rigorosamente sferici come la Terra) erano incastonati in vere e proprie sfere solide e concentriche. Come mai le sfere non risultavano visibili dalla Terra? Semplice: perché erano formate di etere, una sostanza trasparente, inalterabile e incorruttibile, tipica dei corpi divini. Perché invece i pianeti e le stelle, pur essendo fatti di materia perfetta (detta anche quintessenza), potevano essere osservati? Anche in questo caso le risposte non mancavano: per spiegare la differenza tra gli astri e il resto del cielo era sufficiente ipotizzare variazioni nella densità della materia celeste, differenze di grandezza fra un corpo ed un altro, e così via.
Le idee sull’universo formulate nell’antichità trovarono una mirabile sintesi nel sistema fisico e cosmologico di Aristotele, vissuto fra il 384 e il 322 a.C. Secondo Aristotele, esistevano sette «stelle mobili» (o pianeti), fra cui il Sole e la Luna, collocate su sette sfere distinte, tre delle quali si trovavano al di là della sfera del Sole, e tre al di qua. Partendo dalla Terra, l’ordine dei pianeti era questo: Luna, Mercurio, Venere, Sole, Marte, Giove, Saturno. Un’ultima sfera, quella delle «stelle fisse», rappresentava il limite ultimo dell’universo. Il cosmo, dunque, era chiuso e finito. Il «primo mobile» trasportava le stelle fisse (che erano tutte alla stessa distanza dalla Terra), producendo il movimento che si trasmetteva alle altre sfere. Il «motore immobile», invece, rappresentava l’essere onnipotente che controllava il movimento dei cieli. Completamente differente era la condizione del nostro pianeta, sede dell’imperfezione e del mutamento. La materia terrestre, molto meno nobile di quella celeste, risultava composta da quattro elementi base: aria, fuoco, acqua e terra. Queste sostanze possedevano particolari qualità, che permettevano la trasformazione di un elemento nell’altro: ad esempio, il fuoco poteva diventare aria per mezzo del calore, oppure l’aria riusciva a trasformarsi in acqua grazie all’umidità.
Il sistema aristotelico venne progressivamente assorbito all’interno della visione cristiana del mondo. L’universo descritto da Dante Alighieri nella Divina Commedia rappresenta una delle migliori esemplificazioni di questa integrazione, dove alle varie sfere celesti corrispondono le potenze angeliche. Nel Medioevo (e per buona parte dell’età moderna), la Bibbia non rappresentò soltanto il testo contenente le più alte verità religiose e spirituali, ma un vero e proprio manuale scientifico, che parlava della storia e della costituzione dell’universo, della Terra e degli uomini. Per tutto ciò che riguardava il tema della creazione, era sufficiente leggere il libro della Genesi, mentre per avere informazioni sulla fine del mondo, alcuni ritenevano che si dovessero decifrare i segreti contenuti nell’Apocalisse. Relativamente alla struttura del cosmo, la sintonia tra i testi sacri e il sistema aristotelico era perfetta. Tra i passi più celebri, quello tratto dal libro di Giosuè (X, 10-15) sembrava chiarissimo sulla questione della centralità della Terra e della mobilità del Sole:
Il Signore mise lo scompiglio in mezzo a loro dinanzi ad Israele, che inflisse loro in Gàbaon una grande disfatta, li inseguì verso la salita di Bet-Coron e li batté fino ad Azeka, e fino a Makkeda. Mentre essi fuggivano dinanzi a Israele ed erano alla discesa di Bet-Coron, il Signore lanciò dal cielo su di essi come grosse pietre fino ad Azeka e molti morirono. Coloro che morirono per le pietre della grandine furono più di quanti ne uccidessero gli Israeliti con la spada. Allora, quando il Signore mise gli Amorrei nelle mani degli Israeliti, Giosuè disse al Signore sotto gli occhi di Israele:
«Sole, fermati in Gàbaon
e tu luna, sulla valle di Aialon».
Si fermò il sole
e la luna rimase immobile
finché il popolo non si vendicò dei nemici.
Non è forse scritto nel libro del Giusto: «Stette fermo il sole in mezzo al cielo e non si affrettò a calare quasi un giorno intero. Non ci fu giorno come quello, né prima né dopo, perché aveva ascoltato il Signore la voce di uomo, perché il Signore combatteva per Israele»?
Poi Giosuè con tutto Israele ritornò all’accampamento di Gàlgala.
Fig. 2. Andreas Cellarius, Il sistema copernicano con i satelliti di Giove, 1660.
La visione del mondo aristotelico-cristiana (sarebbe necessario parlare anche di Tolomeo, il più famoso astronomo dell’antichità, ma rimandiamo i lettori ad ulteriori, personali approfondimenti) fu più o meno accettata senza particolari problemi fino al 1543, quando venne pubblicato a Norimberga un testo destinato a cambiare in maniera radicale la storia del mondo. Il titolo del libro era De revolutionibus orbium coelestium (Le rivoluzioni delle sfere celesti), l’autore un astronomo di nome Niccolò Copernico, nato a Toruń, in Pomerania, il 19 febbraio 1473. Si narra che Copernico, canonico di Frauenburg, abbia ricevuto una copia dell’opera il giorno stesso della sua morte, il 24 maggio 1543. Copernico, che aveva studiato e lavorato a Bologna, Roma, Padova e Ferrara, riproponeva un’idea già avanzata nel III secolo a.C. da Aristarco di Samo: il Sole è al centro dell’universo, la Terra è uno dei pianeti che gli ruota attorno. Copernico ipotizzò un triplice moto per la Terra: rotazione intorno al proprio asse, rivoluzione attorno al Sole, movimento rispetto al piano dell’eclittica. Poi, non andò oltre. I grandi cambiamenti, soprattutto nella scienza, non si fanno in un giorno. Così, il cosmo di Copernico continuò ancora ad essere fatto di sfere solide e cristalline. E, soprattutto, restò chiuso, segnato da un limite invalicabile. Era infatti delimitato dalla «prima e suprema sfera delle stelle fisse, che contiene se medesima e tutte le cose, che pertanto è immobile ed è il luogo dell’universo al quale si rapportano il moto e la posizione di tutte le altre stelle».
Nonostante ciò, la teoria di Copernico andava irrimediabilmente a colpire una delle certezze più importanti nella storia dell’umanità: la centralità della Terra. È vero, la Terra non rappresentava né il luogo della perfezione né della divinità, ma era pur sempre stata collocata da Dio al centro dell’universo. Sì, perché l’universo era stato creato per l’uomo. E poco importava se gli esseri umani non avevano ricevuto in dono la perfezione. Sicuramente esisteva un buon motivo per questo, la volontà divina non poteva essere messa in discussione.
Una delle persone incaricate di sorvegliare la stampa del De revolutionibus, il teologo luterano di nome Andreas Osiander (poi definito da Giordano Bruno come «un asino ignorante e presuntuoso»), intuendo le potenzialità eretiche del libro, introdusse nel testo una prefazione in cui avvertiva i lettori di considerare la teoria di Copernico solo come una ipotesi matematica. La vera costituzione dell’universo continuava ad essere quella descritta da Aristotele. Questo gesto non servì a molto. Le conseguenze rivoluzionarie del copernicanesimo non avrebbero tardato a manifestarsi. Spostando la Terra dal centro dell’universo, non ci volle molto perché si iniziasse a mettere in dubbio la millenaria distinzione, tipica della fisica aristotelica, fra mondo celeste e mondo terrestre. Se la Terra era un pianeta, forse allora anche gli altri corpi celesti che giravano intorno al Sole assomigliavano alla Terra. Forse le sfere cristalline non esistevano. Forse l’universo non era finito. Forse le stelle fisse potevano costituire altrettanti soli simili al nostro, posizionati a distanze estremamente variabili rispetto al nostro pianeta, e circondati a loro volta da sistemi planetari. Forse gli uomini non erano gli unici abitatori intelligenti dell’universo. Giordano Bruno, che si rifaceva alle speculazioni filosofiche di Nicola Cusano (vissuto nel Quattrocento), pensò e cercò di dimostrare che tutto questo era possibile.
Il 17 febbraio 1600, Bruno, ritenuto blasfemo, venne arso vivo in Campo de’ Fiori a Roma. L’accusa specifica era di aver negato la trinità e la transustanziazione (sulla quale torneremo nel secondo capitolo), ma certamente anche le sue tesi cosmologiche non avevano messo di buon umore gli apparati ecclesiastici. Il suo principale accusatore, il cardinale Roberto Bellarmino, fu uno dei protagonisti negativi della rivoluzione scientifica e, in seguito, avrebbe fatto passare non pochi guai anche a Galileo Galilei. Tuttavia, c’era una profonda differenza tra il modo di argomentare di Bruno e quello dello scienziato toscano. Infatti, mentre Bruno incarnava ancora, per molti versi, il personaggio di un mago rinascimentale, Galileo avrebbe dato un contributo essenziale alla formazione di una nuova figura, fino ad allora inesistente nella cultura europea: lo scienziato moderno.
Galileo e gli altri protagonisti della rivoluzione scientifica furono pressoché concordi nel denunciare i rischi presenti nella concezione di un sapere che, come quello magico, era per definizione segreto, intuitivo, occulto, profetico, riservato soltanto ad eletti e iniziati. E, in più di un’occasione, evidenziarono i pericoli (fra cui la propensione al fanatismo e all’intolleranza) insiti nell’utilizzazione di discipline ambigue ed oscure, costruite talvolta intenzionalmente per ostacolare la comprensione e proteggere l’accesso alla conoscenza del mondo, come la cabala, l’astrologia, l’alchimia e l’ermetismo. Naturalmente, come tutti gli storici sanno (un po’ meno gli scienziati), non sarebbe corretto sostenere che la scienza moderna sia nata in maniera indipendente da queste discipline e dai loro oggetti di studio. Al contrario, i legami fra i due ambiti di ricerca furono notevoli. La diversità fondamentale fra la scienza e le altre forme di sapere stava nel modo di concepire l’accesso alla conoscenza: riservata soltanto agli eletti e agli iniziati nel caso del sapere magico, disponibile per tutti secondo gli scienziati, che in quel periodo si chiamavano ancora «filosofi naturali» (il termine «scienziato» è di origine ottocentesca).
Gli scienziati si schierarono a favore della diffusione della cultura e di un sapere pubblico, controllabile e verificabile da tutti, perché universale e fondato sul principio dell’uguaglianza delle intelligenze. «Tutti possono conoscere tutto» era lo slogan del grande educatore Jan Amos Komenský (cioè Comenio), il cui pensiero sarà ripreso dalla moderna pedagogia. Per questo motivo, fin dal tempo di Galileo, la diffusione del sapere scientifico ha avuto forti valenze politiche, contribuendo enormemente allo sviluppo delle idee di tolleranza e democrazia, come ci ricorda John Dewey nel suo splendido Democrazia e educazione, scritto nel 1915. Naturalmente su questi temi (che non sono l’argomento di questo libro) sono state scritte ormai migliaia di pagine autorevoli ed esaurienti. Ai lettori che vogliano approfondire le questioni legate al rapporto scienza-magia e scienza-democrazia consigliamo di partire da un paio di libri, Il tempo dei maghi (2006) di Paolo Rossi, e Scienza, quindi democrazia (2011) di Gilberto Corbellini.
Pur rifiutando le modalità di accesso alla conoscenza tipiche del mondo magico, gli scienziati non dimenticarono certo che l’immaginazione e la fantasia costituivano strumenti indispensabili per lo studio e la comprensione della natura.
La prima formazione di Galileo, nato a Pisa il 15 febbraio 1564, fu quasi interamente umanistica e artistica. Il padre, Vincenzo Galilei, fu un famoso teorico musicale, autore dell’importante Dialogo della musica antica, et della moderna (1581) e notevole musicista della Camerata dei Bardi. Se stiamo alla testimonianza di Vincenzo Viviani, allievo e primo biografo di Galileo, pare che il figlio suonasse il liuto ancora meglio del padre: «con l’esempio et insegnamento del padre suo, pervenne a tanta eccellenza, che più volte trovossi a gareggiare co’ primi professori di que’ tempi in Firenze et in Pisa, essendo in tale strumento ricchissimo d’invenzione, e superando nella gentilezza e grazia del toccarlo il medesimo padre; qual soavità di maniera conservò sempre sino alli ultimi giorni». Galileo amava moltissimo i classici e gli autori moderni, fra cui il poeta Francesco Berni, maestro della poesia burlesca e satirica, al quale si ispirò per scrivere alcuni dei suoi componimenti, come il celebre capitolo in terza rima Contro il portar la toga, scritto nel periodo dell’insegnamento all’Università di Pisa (1589-92), in polemica con il decreto del Rettore che imponeva ai professori di vestire la toga anche al di fuori delle attività accademiche. Galileo, inoltre, dedicò molto tempo a commentare l’opera del Petrarca, del Tasso e dell’Ariosto, per il quale aveva una particolare predilezione.
Fu proprio grazie al suo amore per la letteratura, la poesia e l’arte che Galileo riuscì a sviluppare quella capacità di immaginazione che poi gli sarebbe stata utilissima per compiere una straordinaria rivoluzione in campo astronomico. Nel capitolo Contro il portar la toga si legge (naturalmente non dimenticando che dietro queste parole c’è un doppio senso tipicamente bernesco, vietato ai minori):
Perché, secondo l’opinion mia,
a chi vuol una cosa ritrovare,
bisogna adoperar la fantasia
e giocar d’invenzione e ‘ndovinare,
e se tu non puo...