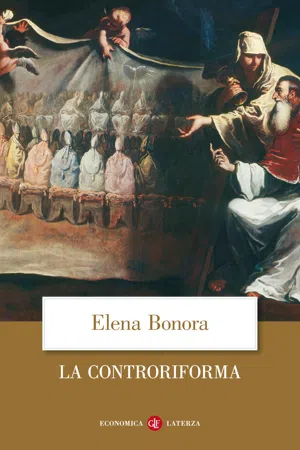I soggetti istituzionali
1. Il centralismo romano: papa, congregazioni cardinalizie e nunzi
Sul finire del Cinquecento, Roma era ormai in grado di proiettare un’immagine diversa da quella della screditata, umiliata e sconfitta capitale della fine degli anni Venti. Era la sede di un potere con un ruolo internazionale di primo piano, la fonte di legittimazione per l’autorità dei prìncipi cattolici, il centro di elaborazione delle certezze religiose e delle norme di comportamento che dovevano indirizzare la società. «Ella non è patria solamente di se medesima o della sola Italia, ma forma, per così dire, un mondo spirituale che la fa generalmente divenire patria commune di tutte le battezzate nazioni», affermerà il cardinale Guido Bentivoglio nelle Memorie scritte tra il 1640 e il 1644, ricordando la capitale della sua giovinezza. La corte di Roma era anche il «gran teatro del mondo» dove si costruivano carriere ecclesiastiche e fortune familiari, dove si aprivano le possibilità di accesso «alle prelature alle mitre alle porpore e alle supreme tiare».
In occasione delle solenni cerimonie e delle liturgie papali, l’oratoria sacra celebrava il rinnovato prestigio della monarchia pontificia e della capitale. Il cattolicesimo militante e trionfante ispirava la predicazione, la letteratura, l’arte, ed era l’ideologia dell’istituzione e dei suoi membri: delle potenti congregazioni cardinalizie, dei nunzi che come ambasciatori rappresentavano il papa nelle corti europee, dei recenti attivissimi ordini religiosi come i gesuiti, dei missionari che con la conquista spirituale e il martirio testimoniavano la fede cattolica in tutto il mondo conosciuto. Le incertezze, la ricerca creativa e le inquietudini originate in Italia dalla crisi spirituale e istituzionale del primo Cinquecento e dal confronto con la Riforma avevano lasciato il posto alla rigida organizzazione gerarchica, agli ordinati modelli disciplinari e ai dogmatici quadri dottrinali di fine secolo.
La curia romana era nuovamente in grado di attirare i migliori intellettuali dell’epoca, i quali si presentavano con una fisionomia radicalmente diversa rispetto al passato. Roberto Bellarmino e Cesare Baronio furono entrambi membri di ordini religiosi, entrambi cardinali, entrambi impegnati a Roma sia sul fronte della repressione (come membri delle congregazioni dell’Inquisizione e dell’Indice) sia su quello dell’elaborazione culturale, attraverso la redazione di catechismi, di martirologi e dei due monumenti ideologici della Controriforma, le Controversiae e gli Annales Ecclesiastici. Imponenti sforzi di sistemazione rispettivamente della teologia e della storia, arsenali dell’ortodossia sul piano dottrinale e su quello della memoria, le due opere – pubblicate nell’ultimo scorcio del Cinquecento – rappresentano il punto d’arrivo di una cultura egemone che aveva espunto il dissenso equiparandolo all’eresia, nella convinzione che stabilire quale fosse la verità in tutti i campi del sapere spettasse esclusivamente alla Chiesa. La condanna di Galileo Galilei non è certo un errore, se inserita in questo quadro. Nell’insieme si trattava di un progetto grandioso, radicato nella certezza che «libertas credendi nihil aliud est quam libertas errandi» (la libertà di fede non è altro che libertà d’errare), come scrisse Bellarmino nelle Controversiae; un progetto capace, nello stesso tempo, di proporre nuovi contenuti e di trasformare le idee della tradizione «in compatti sistemi di significato che le riqualifica[ssero]» (A. Biondi).
Sarebbe però un errore appiattire l’immagine della Chiesa della Controriforma su quella apologetica della Chiesa trionfante ignorando gli scontri, le oscillazioni e gli insuccessi che accompagnarono il processo di dispiegamento del controllo ecclesiastico sulla cultura, sulla vita religiosa e sulla società italiana. Ovviamente, accanite lotte per il potere s’intrecciavano alla corte romana, governata da una monarchia di carattere elettivo, particolarmente esposta, quindi, ai condizionamenti delle fazioni politiche e familiari, alle pressioni delle grandi potenze europee, alle precarie alleanze che si formavano in vista dei conclavi. Le reti di clientele e di patronage si disgregavano e si ricostituivano in una sorta di spoils-system che accompagnava il passaggio dall’uno all’altro pontificato, mentre nuovi orientamenti curiali in politica estera si coagulavano ogni volta intorno al neoeletto pontefice e al suo entourage, di cui massimo esponente era il cardinal nipote. I conflitti a cui però si intende fare riferimento, non riguardano interessi personali o di fazione, ma la gestione stessa del disegno di riforma dell’istituzione e di disciplinamento dei fedeli che qualifica la Chiesa della Controriforma: un problema nello stesso tempo politico e religioso sul quale si scontrarono i soggetti istituzionali ecclesiastici – e anche gli uomini – che di volta in volta si candidarono all’attuazione di tale progetto.
Per meglio chiarire questo quadro complesso occorre, in via preliminare, prendere in considerazione le trasformazioni che, all’interno del processo di rafforzamento dell’assolutismo pontificio, condussero dopo la metà del secolo alla creazione di nuovi centri istituzionali di potere: le congregazioni cardinalizie romane. I cardinali erano dopo il papa il livello più alto della gerarchia ecclesiastica. Il Sacro Collegio – o Concistoro, nelle riunioni celebrate in presenza del papa – era stato per secoli il massimo organo di governo della Chiesa a fianco di quel particolare sovrano che era il pontefice, al tempo stesso capo spirituale della cristianità e principe temporale dello Stato della Chiesa. Alla morte del papa i porporati si riunivano in conclave e non ne uscivano prima di aver scelto tra loro il successore.
In passato erano stati formulati vari progetti di riforma per porre fine allo sfarzo sfrenato dei «prìncipi della Chiesa»; alla crescita spropositata delle loro «famiglie», cioè delle corti cardinalizie i cui membri godevano di esenzioni e privilegi; allo scandaloso cumulo di benefici (in particolare quelli episcopali) nelle mani della stessa persona. Erano state persino avanzate proposte di perequazione delle rendite, ossia di fissazione di un’entrata uguale per tutti i porporati. Le trasformazioni di cui venne investito il Collegio cardinalizio nel corso del Cinquecento, però, non furono ispirate da esigenze di riforma di questo tipo, ma da ragioni politiche connesse al crescere dell’assolutismo della monarchia papale a scapito delle aspirazioni oligarchiche e dei poteri di condizionamento e di controllo che potevano formarsi entro il Sacro Collegio.
L’erosione del suo peso politico era stata avviata già nel Quattrocento con l’allargamento del numero dei cardinali che in questo modo, sul piano economico, si trovavano a dipendere in misura maggiore dal favore del papa. Dai diciotto porporati del pontificato di Eugenio IV (1431-1447) si giunse ai settantasei sotto Pio IV sino al tetto massimo di settanta stabilito nel 1586 da Sisto V. Nell’ultimo scorcio del secolo lo svuotamento dei poteri di quello che un tempo era considerato l’antico Senato del pontefice era un fatto compiuto. Le sue riunioni furono sempre più rade e convocate per consultazioni puramente formali, per cerimonie e allo scopo di attribuire i benefici concistoriali. L’ultima voce che cercò di rivendicare per il Sacro Collegio un ruolo di co-governo con il pontefice e l’autonomia politica contro le tendenze assolutistiche papali fu quella di un uomo legato alle grandi aspirazioni di riforma del passato e all’eredità tridentina, il cardinale e vescovo di Bologna Gabriele Paleotti, autore del De Sacri Consistorii consultationibus pubblicato nel 1592 tra le perplessità e le caute critiche di amici curiali.
A metà Cinquecento i centri del potere politico si trovavano in altri luoghi: nelle congregazioni cardinalizie nate nella prima metà del secolo come commissioni ristrette e temporanee, interne al Sacro Collegio, per l’esame di problemi specifici, poi divenute commissioni permanenti direttamente dipendenti dal papa, cui spettava la nomina e la rimozione dei loro membri. Tale linea di tendenza era stata avviata nel 1542 con la creazione della congregazione romana dell’Inquisizione. Sul modello di questa ne furono istituite altre: la congregazione del Concilio nel 1564, incaricata dell’applicazione (e in seguito, sotto Sisto V, anche dell’interpretazione) dei decreti disciplinari del tridentino; la congregazione della Stamperia Vaticana sorta lo stesso anno per la pubblicazione dei testi ufficiali di patristica, dei dottori della Chiesa e, nel 1566, del Catechismo romano; la congregazione dell’Indice istituita nel 1571, cui era affidato il controllo sulla produzione libraria; la congregazione dei Vescovi e dei Regolari, nel 1601, con competenze sulle questioni più disparate riguardanti sia il governo episcopale delle diocesi italiane sia gli ordini religiosi, risultato della fusione tra quella dei Vescovi funzionante dal 1573 sotto Gregorio XIII, e quella dei Regolari istituita nel 1586; la congregazione dei Riti cui erano affidati il controllo sulla liturgia, sul culto dei santi e le procedure di canonizzazione; la congregazione del Cerimoniale, istituita come la precedente nel 1588, che si occupava delle precedenze tra ecclesiastici, tra dignitari laici, nonché delle cerimonie solenni celebrate nella cappella papale; la congregazione De propaganda fide (ossia per la propagazione della fede) nel 1622 – ma il tentativo di istituire una commissione cardinalizia permanente su queste materie risaliva a Pio V – cui spettava di regolare le questioni riguardanti la fondazione di missioni, di collegi per la formazione dei missionari e la stampa di libri da diffondere tra le popolazioni da convertire.
Nel 1588 papa Sisto V Peretti (1585-1590), francescano ed ex inquisitore, con la bolla Immensa aeterni Dei aveva riorganizzato l’intero sistema in quindici congregazioni: sei erano deputate al governo temporale dello Stato pontificio (congregazione Navale, dell’Università Romana o Sapienza, dell’Annona o Abbondanza dello Stato, degli Sgravi, delle Acque e Strade, Supremo Tribunale della Consulta); le rimanenti nove erano deputate al governo spirituale della Chiesa, nonostante le due sfere non fossero nettamente distinte. Venivano così fissate le linee di fondo di un ordinamento delle strutture della curia che si sarebbe mantenuto per secoli. La preminenza su tutte era assicurata alla congregazione dell’Inquisizione, presieduta direttamente dal papa che solitamente partecipava alle riunioni del giovedì, in questo caso tenute coram sanctissimo (cioè davanti al santo padre).
Entro un quadro istituzionale talmente mutato, cambiò anche la figura del cardinale. Esperienza curiale, preparazione giuridica, affidabilità politica diventarono i criteri di reclutamento dei porporati che, da prìncipi della Chiesa rinascimentale, cominciarono a somigliare sempre di più ad altissimi funzionari della burocrazia papale, ai membri di un’aristocrazia cortigiana dipendente dal sovrano pontefice, per i quali l’accesso al cardinalato si poneva quale coronamento di una carriera solitamente spesa entro l’apparato ecclesiastico di governo. Come già si è avuto modo di osservare, a essere insigniti del cappello cardinalizio dai papi della Controriforma non furono più laici e prestigiosi letterati come il Bembo, ma uomini nuovi, talvolta di bassissima condizione, che alle spalle avevano un passato di fedeli collaboratori del pontefice: nella direzione dei dicasteri curiali, nella diplomazia, nel governo dello Stato pontificio e nell’intransigente lotta contro l’eresia. Tutto questo aveva anche ragioni finanziarie precise. La promozione al cardinalato di membri dell’alta burocrazia curiale e romana non solo consentiva al pontefice di circondarsi di uomini fidati, ma anche di recuperare l’ufficio che essi avevano acquistato (e al quale al momento della nomina cardinalizia dovevano rinunciare) per inserirlo nuovamente nel sistema delle venalità.
Un altro aspetto di questo processo di centralizzazione e riorganizzazione della monarchia pontificia fu l’italianizzazione del Sacro Collegio e degli ufficiali e dignitari curiali, fenomeno in cui si rifletteva la saldatura d’interessi tra la Santa Sede e i ceti dirigenti della penisola italiana, per i quali le carriere all’ombra della Chiesa e una vita di corte adeguata al modello nobiliare rappresentavano una soluzione soddisfacente alle scelte imposte dai processi d’aristocratizzazione dei patriziati cittadini, dall’incremento demografico, dal problema della sistemazione dei cadetti, dalla ricerca di clientele romane in grado di assicurare vantaggi all’intero clan familiare. Parallelamente cresceva la clericalizzazione dell’apparato di governo dello Stato pontificio i cui esponenti furono scelti sempre più spesso tra gli ecclesiastici: figure come quella di Francesco Guicciardini, governatore di Modena e Reggio, presidente della Romagna e vicelegato di Bologna, il quale rimase un funzionario laico, scomparvero nel secondo Cinquecento.
Altre istituzioni possono essere considerate espressione del centralismo romano. Durante il pontificato di Gregorio XIII Boncompagni (1572-1585), le nunziature (rappresentanze diplomatiche presso le corti italiane e straniere) ricevettero stabile assetto e crebbero di numero. In Italia, nunziature apostoliche permanenti si trovavano a Venezia, Napoli, Torino e Firenze. A quelle già esistenti in Spagna, Portogallo, Francia, Polonia e alla corte imperiale di Praga, Gregorio XIII ne aggiunse altre: a Lucerna per la Svizzera, a Colonia per il Nord-Ovest tedesco, a Graz per l’Austria interna e a Bruxelles per la Fiandra. Il nunzio rappresentava un elemento di collegamento tra Roma e il principe presso cui era accreditato, tra Roma e i vescovi dello Stato in cui svolgeva le proprie funzioni. Era una figura istituzionale dotata di ampissimi poteri, direttamente in contatto non solo con il cardinal nipote (e in seguito con la segreteria di Stato), ma anche con le congregazioni cardinalizie; le sue facoltà potevano spaziare dal campo diplomatico ai problemi di governo pastorale, dai conflitti tra le autorità ecclesiastiche locali sino alla lotta contro l’eresia.
Nel corso della seconda metà del Cinquecento, l’affermazione del primato papale in polemica con le tesi riformate sul piano dottrinale e il consolidamento dell’autorità pontificia su quello politico, furono quindi accompagnati da importanti trasformazioni istituzionali – sistema delle congregazioni e rete delle nunziature – orientate verso una strutturazione gerarchica e centralistica della Chiesa. L’individuazione di tali fenomeni pone un problema che occorrerà affrontare tra breve: quale fu il rapporto tra questi processi e le linee d’intervento emerse dal concilio di Trento? Come si articolò il contrasto tra le tendenze centralizzatrici romane e la candidatura alla gestione del progetto di controllo politico e religioso avanzata dai vescovi, ossia dai massimi rappresentanti delle Chiese locali, all’indomani della chiusura del concilio, che proprio nella funzione episcopale aveva individuato il fulcro dell’opera di rinnovamento ecclesiastico? Quale fu, in altre parole, il ruolo del tridentino nella Chiesa della Controriforma?
L’assemblea conciliare rivestì un ruolo centrale come luogo di elaborazione delle linee di riforma disciplinare dell’istituzione, di fissazione di verità dottrinali, di formazione di un nuovo spirito. Al di là del mito del tridentino che la stessa cultura della Controriforma e la storiografia successiva hanno costruito, emergono, però, le difficoltà incontrate dall’opera di rinnovamento dei vescovi proprio a causa della politica romana e del progressivo svuotamento condotto dalla Santa Sede delle soluzioni e degli strumenti operativi emersi dai dibattiti conciliari.
Questo complesso di considerazioni ha condotto, sul piano storiografico, a una visione più articolata del problema dell’applicazione del tridentino nel contesto della penisola e parallelamente a un ridimensionamento del ruolo del clero secolare nell’Italia della Controriforma. Entro tale prospettiva, come si vedrà alla fine di questo capitolo, si colloca la maggior attenzione recentemente accordata alla funzione degli ordini regolari. Lungi dall’essere eclissati dal rilancio postridentino della funzione episcopale e della parrocchia, conventi e monasteri conservarono un’importanza centrale nella cura delle anime e nella vita religiosa. La trattazione del progetto ecclesiastico, politico e religioso della Chiesa della Controriforma e delle trasformazioni istituzionali che ne resero possibile l’articolazione deve quindi tener conto anche del ruolo degli ordini religiosi: della continuità della presenza di quelli di antica fondazione e dell’apporto delle nuove congregazioni di chierici regolari sorte in età tridentina.
2. Il concilio di Trento e il ruolo dell’episcopato nell’Italia postridentina
L’ultima fase conciliare – la più densa per quantità e qualità delle questioni affrontate – fu anche quella cui presero parte in numero maggiore i rappresentanti degli episcopati non italiani, in particolare francesi e spagnoli. Come nelle sessioni precedenti, parteciparono a pieno titolo i generali degli ordini mendicanti (francescani e domenicani dei rami conventuale e osservante, agostiniani, carmelitani e serviti) e, senza diritto di voto, i cosiddetti «periti», cioè consulenti teologi e canonisti. Gli ambasciatori e i rappresentanti delle potenze erano presenti in qualità di osservatori.
Sin dalla prima fase, il concilio si era rivelato un’assemblea strettamente controllata dal pontefice attraverso la figura dei legati papali incaricati di presiederla. Sul piano dottrinale, la rottura con il mondo riformato si era consumata ben presto. Contro la giustificazione sola fide dei protestanti, il decreto del 1547 ribadì il valore salvifico delle opere. Sulle fonti della Rivelazione, contro la sola Scriptura, si stabilì l’eguale importanza della tradizione ecclesiastica. Furono approvati i decreti sui sacramenti, confermati nel numero di sette (battesimo, cresima, eucaristia, penitenza, estrema unzione, ordine sacro e matrimonio) contro i due ammessi dalla dottrina luterana (battesimo ed eucaristia). Furono decretati il carattere di sacrificio della messa offerto per mezzo dei sacerdoti e la non convenienza dell’uso del volgare nella celebrazione del rito. Furono riaffermati l’esistenza del purgatorio, la validità delle indulgenze, il culto dei santi e della Vergine. Ma, soprattutto, l’autorità papale fu nel complesso rafforzata come mai in precedenza.
Dopo la conclusione ufficiale dei lavori e la solenne promulgazione dei decreti conciliari da parte della Santa Sede, la loro applicazione fu accettata dagli Stati regionali italiani, suscitando invece reazioni diverse tra i governi dei paesi cattolici europei. All’indomani della chiusura dell’assemblea e dell’emanazione nel 1564 della bolla papale di conferma (Benedictus Deus), solo i re di Spagna, Portogallo e Polonia acconsentirono a far applicare i decreti nei loro domini. In Francia, anche dopo la fine delle guerre di religione, la registrazione delle norme tridentine si scontrò con la radicata tradizione di autonomia e difesa delle «libertà gallicane» e con l’opposizione tenace dei parlamenti che interpretarono i decreti volti al disciplinamento ecclesiastico della società come pretese lesive delle proprie funzioni di «polizia» (intesa nell’ampio significato di controllo sociale che tale termine aveva in antico regime).
L’accettazione della normativa tridentina incontrò dunque in Francia il netto rif...