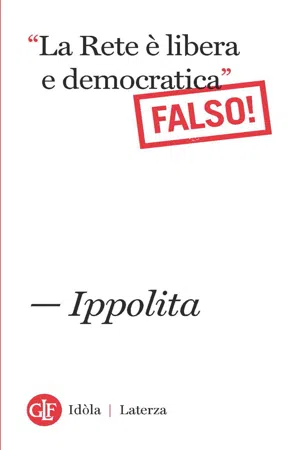1. argomento ontologico
1. Urbi et Orbi
La Rete non è un’entità dotata di una natura fissa e immutabile né di caratteristiche invarianti. È composta da macchine meccaniche (computer, cavi, router), da macchine semiotiche (codici e linguaggi) e da macchine biologiche (esseri umani) che interagiscono fra loro in maniera estremamente complessa. In termini tecnici, sono in atto meccanismi di retroazione cibernetica, cioè di auto-costruzione: le Megamacchine si nutrono e crescono secondo processi di autopoiesi.
La Rete è nata dalla sperimentazione e dallo sviluppo dell’informatica, la quale, a sua volta, non è semplicemente una tecnica per gestire l’informazione in maniera automatica, come suggerirebbe il termine5, ma possiede una logica propria e lavora e modifica continuamente le sue stesse fondamenta. È fisica teorica e sperimentale insieme: studia la formalizzazione del linguaggio (dunque formalizza la conoscenza), la applica ai componenti fisici dell’elettronica, ne ricava linguaggi che a loro volta influenzano le teorie della conoscenza. Si regge, cioè, su una dimensione ricorsiva del tutto particolare.
Questa complessità è spesso banalizzata, sia per mera ignoranza che per consapevole malafede. Come è logico, trattandosi di sistemi complessi e imbricati fra loro, le zone d’ombra sono molteplici. È quanto mai urgente e necessario articolare nuovi approcci etici, e ancor prima estetici, capaci di valutare la percezione di questi livelli di complessità e di discuterne in maniera ragionevole: invece di precipitarsi a magnificare ogni nuova web app, singoli individui e comunità intere dovrebbero fermarsi e riflettere sul grande cambiamento antropotecnico nel quale si è tutti coinvolti. È un processo globale di selezione e costruzione degli esseri umani, nel quale dovremmo cercare di distinguere il rumore di fondo delle pubblicità (altro idolum contemporaneo, vero carburante del capitalismo) dalla variegata struttura che chiamiamo Rete.
Ma il tempo fugge e l’imperativo tecnologico ci vuole immediatisti. Always on!, sempre aggiornati: la vita in tempo reale si dimentica di riflettere sulla realtà e si consacra volentieri alla cura del simulacro, ben più confortante ed eccitante. Migliaia di amici e di followers, centinaia di mail, squillini, like, sms, foto, tag, post: tutto scorre! Meglio lasciare ogni cosa online, per poterla ritrovare in ogni istante.
Come siamo arrivati a credere che la Rete sia portatrice sana di democrazia e di libertà, oltre che di prosperità economica?
2. La Rete non è il Web
La Rete di Internet non coincide con il World Wide Web, che è solo uno dei tanti servizi disponibili, anche se è certamente il più conosciuto, poiché permette di navigare in un insieme sempre più vasto di contenuti attraverso collegamenti (links) che formano ipertesti. Per distinguere il Web dal resto di Internet dobbiamo saper distinguere i vari protocolli che la compongono.
Un protocollo informatico è una sorta di accordo comunicativo fra macchine, definito in maniera il più possibile chiara e precisa in appositi documenti tecnici, gli Rfc (Request for Comments). Il protocollo che si identifica con il Web si chiama Http (Hypertext Transfer Protocol, Protocollo di Trasferimento di Ipertesti) e risale al 1991, anche se i primi siti web risalgono al 1996. Tutto ciò che non è Http non è Web: per esempio, non lo sono Skype, Torrent, Ftp e così via, che pure fanno parte di Internet, ma la cui suite di protocolli basici per la connessione fra terminali diversi si chiama Tcp/Ip ed è stata definita nel 1975.
I protocolli funzionano a livelli (per esempio, il Tcp/Ip copre due dei sette livelli previsti dal modello ISO/OSI, in larga parte teorico): l’utente «vede» solo l’ultimo (Http per il Web), ma tutti gli altri sono in azione contemporaneamente, a partire dal livello di connessione (fisico, wireless o cavo che sia), fino al livello di «manifestazione» delle interfacce sugli schermi. Il Web, quindi, possiamo immaginarlo come una pellicola che avvolge tutti i protocolli di rete e ci permette di fruirne in maniera molto semplice, ignorando cosa succede al di sotto di essa.
Se vi sembra complicato, è perché lo è. Anzi, è molto, molto più complicato di quanto possiamo immaginarci. Non occorre essere dei tecnici esperti per capire che è una semplificazione indebita definire «Rete» le complesse interazioni fra le miriadi di protocolli di rete, gli esseri umani e ciò che cercano di esprimere nei loro messaggi.
La Società della Rete come fenomeno di massa è stata resa possibile dall’espansione del Web e dalla facilità d’uso del protocollo Http e dei servizi derivati: in primo luogo i browser, quindi i motori di ricerca e infine le piattaforme di social networking. Poco più di vent’anni sono bastati a rimpiazzare praticamente tutti i software inventati per i computer (almeno quelli per il grande pubblico) con applicazioni Web (le web app di cui sopra).
L’idea stessa di personal computer è diventata obsoleta dal momento in cui ognuno sembra avere il proprio spazio web riservato dove archiviare anche i dati personali più sensibili: mail, foto, video, chat, documenti. All’inizio del XXI secolo gli utenti faticavano a comprendere come gestire il proprio file system e si perdevano fra cartelle e file; oggi questi oggetti sono stati risucchiati in uno spazio web non meglio precisato, le nuvole del Cloud computing, e gli utenti sono quasi completamente ignari della dispersione dei propri contenuti online. Chi sa dove stanno fisicamente le proprie mail? Certo non sul computer di casa, o non solo.
I dispositivi hardware servono ormai quasi esclusivamente per fruire del Web e dei suoi servizi: dalla stesura di testi alla fruizione di video attraverso lo streaming dei dati. Non «possediamo» più nulla, tutto è «condiviso» con le grandi multinazionali dell’Information technology che ci mettono a disposizione numerosi servizi senza farci pagare nemmeno un euro. L’informatica, per un utente comune, sfuma nell’insostenibile leggerezza del Cloud computing.
È facile comprendere, dunque, perché il concetto di Web e quello di Rete vengano comunemente sovrapposti, al punto da essere usati come sinonimi.
Questa Rete che non è solo Web ha i suoi padroni: Microsoft, Google, Amazon, Apple, Facebook e così via. Padroni, perché non solo posseggono i codici dei software che usiamo, le informazioni che regaliamo loro, la potenza di calcolo e la manodopera per mantenere il tutto in movimento (tra cui andrebbe calcolata anche la nostra manodopera gratuita di utenti). I nuovi padroni digitali hanno anche plasmato una mentalità, hanno promosso un’idea del mondo e annunciano ogni giorno la buona novella del Web 2.0.
A poco più di vent’anni di distanza dalla messa online del primo sito sul WWW ci troviamo adepti di una nuova religione di cui non conosciamo né origine né struttura, ma di cui applichiamo la liturgia con scrupoloso zelo quotidiano.
Ci siamo adattati progressivamente a tutte le interfacce e alle inserzioni pubblicitarie defilate ma onnipresenti; abbiamo adottato i servizi più disparati, e l’abitudine al loro utilizzo si è trasformata ormai in consuetudine; la fidelizzazione è arrivata allo sviluppo di vere e proprie dipendenze e credenze; abbiamo maturato nuove competenze digitali, soprattutto nel senso letterale delle dita, instancabilmente affaccendate su tastiere sempre più piccole e su schermi tattili. Ma metterci sopra le mani (hands on!, recita l’etica hacker) è tutta un’altra cosa.
3. «La democrazia sul Web funziona»
L’indicizzazione del Web da parte di Google è paradigmatica di questa forma di malafede costitutiva. Siccome l’ascesa di Google coincide con quella del Web, analizzeremo l’ontologia del motore di ricerca più diffuso al mondo per sbirciare un po’ dietro le quinte. Per ontologia intendiamo le caratteristiche fondamentali di un oggetto, quelle che vengono identificate con i suoi tratti essenziali.
La strategia dell’oggettività matematica è il principale alfiere attraverso cui si incunea l’idea bislacca che la democrazia e la libertà possano essere garantite dalle macchine. Molti hanno accettato l’idea che il colosso di Mountain View6, forse proprio perché percepito come colossale, contenga tutto il Web. Ne è testimone il bottone Mi sento fortunato, che ci catapulta direttamente alla pagina che stiamo cercando. Incredibile! Google sostiene di poter intercettare ed esaudire perfettamente i nostri desideri di ricerca.
Mi sento fortunato è l’esemplificazione della filosofia oracolare googoliana. Questa religione nascente presenta un bug concettuale, un errore di fondo. Google ritiene e proclama che il suo algoritmo per ordinare il mondo è oggettivo e democratico, come sostiene esplicitamente nella quarta delle sue Dieci Verità: «La democrazia sul Web funziona»7. L’algoritmo PageRank ordina i risultati in base al numero di link in entrata per ogni sito e in base all’importanza che questi siti a loro volta posseggono (il risultato è quindi pesato, nel senso di parte di un grafo pesato): più un nodo sarà connesso, più conquisterà posizioni di testa nella lista dei risultati. Google parla esplicitamente di «voto», perché nella sua visione ogni link equivale a un voto: un sito fortemente votato (linkato) si troverà in una posizione di vantaggio nel ranking rispetto a un altro meno conosciuto.
Scambiando la popolarità e il filtro tecnologico per democrazia, si può arrivare a definire Google una «democrazia elettronica». A Mountain View, infatti, sostengono che l’ordinamento viene formulato in base ai link e non ai contenuti di una pagina: sembra proprio di trovarsi di fronte a una tecnologia in grado di garantire l’oggettività di un risultato.
Il ragionamento sottinteso è che il PageRank, un algoritmo matematico, in quanto oggetto tecnologico, non giudica, non può mentire, non è deformato dalla lente delle ideologie. Peccato che questo meccanismo di assegnazione matematica di un valore sia doppiamente ideologico. Una tecnologia buona per natura, ecco la prima ideologia nascosta (ovvero credenza). La seconda convinzione di fondo, l’ideologia dello Spettacolo, è che «più saranno conosciuti più saranno famosi», un diktat del nostro tempo che in Italia conosciamo particolarmente bene. In questo modo è facile comprendere come Google legittimi «scientificamente» il primato di risorse che non hanno alcun merito se non quello di essere dei nodi fortemente connessi. La «risorsa» Paris Hilton avrà sempre un numero di risultati maggiore di quella di Angela Davis, vale di più e tenderà a valere sempre di più. In fondo sono solo due stringhe di codice...
4. La Repubblica degli algoritmi
Entriamo nel merito. Quest’idea del link come espressione di un voto positivo ha una sua precisa origine culturale. Si tratta, infatti, di una traduzione matematica del meccanismo di citazione scientifica: più un articolo scientifico viene accolto in maniera positiva da altri scienziati (che si suppone lavorino in maniera indipendente), più l’articolo stesso viene considerato importante e meritevole. Sergey Brin e Larry Page, i fondatori di Google, traslano nel proprio ca...