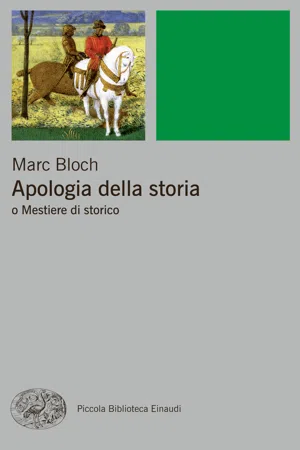![]()
1. Abbozzo di una storia del metodo critico.
Che i testimoni non debbano per forza esser creduti sulla parola1, i piú ingenui fra i poliziotti lo sanno bene2. Salvo poi a non ricavare sempre da questa conoscenza teorica le debite conseguenze. Parimenti, è molto tempo che ci si è resi conto che non si possono accettare ciecamente tutte le testimonianze storiche. Ce l’ha insegnato un’esperienza antica quasi quanto l’umanità: piú di un testo si spaccia3 di una provenienza diversa da quel che sia in realtà: non tutti i racconti sono veridici e persino le tracce materiali possono essere truccate. Nel Medioevo, dinanzi all’abbondanza stessa dei falsi4, [spesso] il dubbio fu come un riflesso naturale di difesa5. «Con l’inchiostro, chiunque può scrivere qualsiasi cosa», esclamava, nel secolo XI, un signorotto lorenese, in lite con dei monaci armati contro di lui di prove documentarie. La Donazione di Costantino – questa sorprendente elucubrazione che un chierico romano del secolo VIII attribuí al primo Cesare cristiano – fu, tre secoli dopo, contestata nell’ambiente del piissimo imperatore Ottone III. Si andò a caccia di false reliquie non appena vi furono delle reliquie.
Tuttavia, lo scetticismo di principio non è un atteggiamento intellettuale piú apprezzabile né piú fecondo della credulità, con la quale, d’altro canto, esso si combina facilmente in molti spiriti sempliciotti.
Durante l’altra guerra, ho conosciuto un bravo veterinario il quale, non senza qualche parvenza di ragione, negava sistematicamente fede alle notizie giornalistiche. E se un compagno occasionale6 versava nel suo orecchio attento le frottole piú sorprendenti? Il mio uomo andava in brodo di giuggiole.
[Anche la critica di semplice buon senso, che a lungo è stata la sola praticata, e che talvolta seduce alcuni spiriti, non poteva condurre lontano. In effetti, che cos’è, nella maggior parte dei casi, questo preteso buon senso? Nient’altro che una miscela di postulati irragionevoli e di esperienze frettolosamente generalizzate. È il mondo fisico ad essere in questione? Esso ha negato gli antipodi; e nega l’universo einsteiniano; ha dipinto come una leggenda il racconto di Erodoto il quale riferiva che i naviganti, circumnavigando l’Africa, vedevano un giorno passare dalla loro destra alla sinistra il punto in cui sorge il sole. Sono in questione le azioni umane? Il peggio è che le osservazioni, cui si dà cosí una validità eterna, sono tratte per forza da un momento brevissimo della durata: la nostra. In ciò è consistito il difetto principale della critica voltairiana, peraltro spesso cosí acuta. Non solo le bizzarrie individuali sono di tutti i tempi; piú d’uno stato d’animo poco fa condiviso ci sembra strano, dal momento che non lo sentiamo piú nostro. Il «buon senso», pare, vieterebbe di accettare che l’imperatore Ottone I abbia potuto sottoscrivere, a favore dei papi, concessioni territoriali inapplicabili che smentivano i suoi atti precedenti e di cui quelli seguenti non dovevano tenere alcun conto. Ciò malgrado, bisogna proprio credere che non avesse una mente fatta del tutto come la nostra – che, per essere piú precisi, al suo tempo si mettesse tra lo scritto e l’azione una distanza la cui ampiezza ci sorprende –, dal momento che il Privilegium è incontestabilmente autentico.]
Il vero progresso è venuto il giorno in cui il dubbio s’è fatto, come diceva Volney, «esaminatore»; quando, in altri termini, si sono via via elaborate delle regole [oggettive] che, tra la menzogna e la verità, permettono di effettuare una scelta. Il gesuita Van Papenbroeck, a cui la lettura delle Vite dei santi aveva ispirato un’incoercibile diffidenza verso l’eredità dell’[alto] Medioevo nella sua interezza, considerava falsi tutti i diplomi merovingi conservati nei monasteri. No, rispose in sostanza Mabillon; ci sono incontestabilmente diplomi interamente falsificati, rimaneggiati o interpolati; ma ce ne sono anche di autentici; ed ecco come è possibile distinguere gli uni dagli altri. In quell’anno – [il 1681,] l’anno di pubblicazione del De re diplomatica, una grande data, in verità, nella storia dello spirito umano – la critica dei documenti d’archivio fu [definitivamente] fondata.
[Quello fu peraltro, in ogni modo, il momento decisivo nella storia del metodo critico. L’umanesimo dell’età precedente aveva avuto le sue velleità e le sue intuizioni. Piú in là non era andato. Niente di piú tipico di un passo degli Essais. Ivi, Montaigne scusa Tacito per aver riferito dei prodigi. È di competenza di teologi e filosofi, egli dice, discutere le «comuni credenze». Gli storici non devono fare che «narrarle» cosí come le loro fonti gliele riportano. «Ci prospettino la storia piú come la recepiscono che come la giudicano». In altre parole, una critica filosofica, basata su una certa concezione dell’ordine naturale o divino, è perfettamente legittima; e si capisce, del resto, che Montaigne dal canto suo non accetti i miracoli di Vespasiano: non piú che molti altri. Ma per quanto riguarda la disamina, specificamente storica, di una testimonianza in quanto tale, chiaramente egli non coglie bene come la sua pratica potrebbe esser possibile. Una dottrina delle ricerche venne elaborandosi solo nel corso del secolo XVII di cui non sempre si coglie la vera grandezza là dove si dovrebbe, e segnatamente verso la sua seconda metà]7.
Gli uomini di quell’epoca ne ebbero essi stessi coscienza. Era un luogo comune8 fra il 1680 e il 1690, denunciare come moda del momento il «pirronismo della storia». «Si dice, – scrisse Michel Le Vassor, commentando quell’espressione, – che la dirittura mentale consiste nel non credere con leggerezza e nel sapere dubitare in parecchie occasioni». Lo stesso vocabolo ‘critica’ [, che fino a quel momento non aveva designato altro che un giudizio di gusto,] assume allora il senso di prova di veridicità. Non lo si azzarda, in un primo momento, se non scusandosene. Poiché «non è un uso propriamente corretto» – nel senso che esso si associa ancora a una tecnica. Eppure, guadagna via via terreno. Bossuet lo tiene prudentemente a distanza: quando parla dei «nostri autori critici», si intravvede la sua alzata di spalle. Ma Richard Simon lo include nel titolo di quasi tutte le sue opere. I piú avvertiti, [del resto,] non si sbagliano: ciò che questo nome annuncia, è proprio la scoperta di un metodo [, di applicazione quasi universale]. La critica, «questa specie di fiaccola che ci illumina e ci guida lungo le oscure vie dell’antichità, facendoci distinguere il vero dal falso»: cosí si esprime Ellies du Pin. E Bayle9, ancora piú nettamente: «Il Simon ha disseminato in questa nuova Réponse parecchie regole di critica che possono servire non solo per comprendere la Scrittura, ma anche per leggere utilmente altre opere».
Ora, confrontiamo alcune date di nascita. Papenbroeck – che, se si ingannò sulle carte, merita ugualmente il suo posto, in prima fila, fra i fondatori della critica applicata alla storiografia –, 1628; Mabillon, 1632; Richard Simon, i cui lavori dominano gli inizi dell’esegesi biblica, 1638. Si può aggiungere, al di fuori del gruppo degli eruditi propriamente detti10, Spinoza – lo Spinoza del Trattato teologico-politico, questo purissimo capolavoro di critica filologica e storica –, ancora 1632. È una generazione [nel senso pieno del termine] che si delinea cosí [, con una stupefacente nettezza,] dinanzi a noi. Ma occorre essere piú precisi: è, [per l’esattezza], la generazione che vide la luce nel momento in cui appariva il Discours de la méthode.
Non diciamo: una generazione di cartesiani. Mabillon, per citare lui solo, era un monaco devoto [, ortodosso con semplicità e] che ci ha lasciato, come ultimo scritto, un trattato su La mort chrétienne. Si può dubitare che abbia conosciuto da vicino la nuova filosofia [, a quei tempi cosí sospetta agli occhi di tanti spiriti pii]; e, piú ancora, che, se per caso ne ebbe alcuni lumi, vi abbia trovato molti motivi per approvarla. D’altro canto – checché paiano suggerire alcune pagine, forse troppo celebri, di Claude Bernard – le verità d’evidenza di tipo matematico, alle quali, in Descartes, il dubbio metodico ha il compito di aprire il cammino, presentano pochi tratti comuni con le probabilità sempre piú approssimate che la critica storica, come le scienze di laboratorio, si accontenta di svelare. Ma perché una filosofia impregni di sé tutta un’epoca, non è necessario né che vi si adegui supinamente, né che [la maggior parte del]le menti11 ne subiscano gli effetti solo per una specie di osmosi, spesso [a metà] inconscia. [Come la «scienza» cartesiana,] la critica della testimonianza storica fa tabula rasa della ‘credenza’. [Ancora come la scienza cartesiana,] essa non procede in questo implacabile sovvertimento di tutti gli antichi puntelli se non al fine di giungere per questa via a nuove certezze (o a grandi probabilità), ormai debitamente provate. [In altre parole,] l’idea che la ispira12 [suppone un capovolgimento quasi totale delle antiche concezioni del dubbio. Che i suoi morsi sembrassero una sofferenza o che invece vi si trovasse non so qual nobile dolcezza, sino a quel momento esso non era stato considerato quasi altro che come un atteggiamento mentale puramente negativo, come una semplice assenza. Si ritiene ormai che], razionalmente guidato, possa divenire uno strumento di conoscenza. È un’idea la cui apparizione si situa in un momento ben preciso della storia del pensiero.
Da allora le regole essenziali del metodo critico erano [definitivamente] stabilite13. La loro portata generale sfuggiva cosí poco che, nel secolo XVIII, tra gli argomenti proposti piú frequentemente dall’Università di Parigi al concorso di agrégation dei filosofi, si vede figurare questo, la cui stessa formulazione suona curiosamente moderna: «Della testimonianza degli uomini sui fatti storici». Non che le generazioni successive, certo, non abbiano14 apportato allo strumento15 molti perfezionamenti. Soprattutto, ne hanno generalizzato ampiamente l’uso ed esteso considerevolmente le applicazioni16.
Le tecniche della critica furono a lungo praticate, almeno in modo continuativo, quasi esclusivamente da un pugno di eruditi, di esegeti e di curiosi. Gli scrittori dediti a comporre opere storiche d’un certo respiro non si curavano affatto di famigliarizzarsi con quelle ricette [di laboratorio], a loro parere troppo minuziose, e a malapena consentivano a tener conto dei loro risultati. Ora, non è mai bene, secondo il detto di Humboldt, che i chimici abbiano paura «di rovinarsi le mani». Per la storia, il pericolo di uno scisma di tal fatta fra la preparazione e la messa in opera è duplice. [Esso riguarda anzitutto (è triste ammetterlo)] i grandi saggi di interpretazione. Questi, [con ciò, non] vengono meno [solo] al dovere primissimo della veridicità [pazientemente ricercata]; privati, inoltre, di quel perpetuo rinnovamento, di quella sorpresa sempre rinascente, che solo la lotta con il documento può procurare, non possono sfuggire a una17 oscillazione senza fine fra alcuni temi [stereotipati] che la routine impone. Ma lo stesso lavoro tecnico ne soffre non poco. Non essendo piú guidato dall’alto, rischia18 di impigliarsi indefinitamente in problemi insignificanti o mal posti. Non v’è spreco peggiore di quello dell’erudizione, quand’essa gira a vuoto, né superbia piú mal riposta dell’orgoglio dello strumento che si scambia per un fine in sé.
Contro questi pericoli, lo sforzo coscienzioso del secolo XIX ha valorosamente combattuto. [La scuola tedesca, Renan, Fustel de Coulanges, hanno restituito all’erudizione la sua dignità intellettuale. Lo storico è stato rinviato al banco da lavoro.] Ciononostante, la partita è stata del tutto vinta? Ci vorrebbe molto ottimismo per crederlo. [Troppo spesso il lavoro di ricerca continua a procedere a casaccio, senza una scelta ragionata dei suoi punti di applicazio...