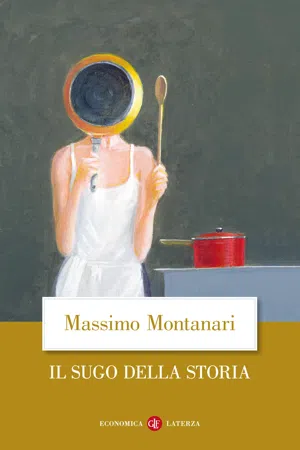Dammi la ricetta
L’idolo delle origini
«La quercia nasce dalla ghianda. Ma questa diviene e resta quercia soltanto mediante condizioni ambientali favorevoli, le quali non dipendono più dall’embriologia».
Questa semplice riflessione è contenuta nell’Apologia della storia (sottotitolo: o Mestiere di storico) di Marc Bloch, il più grande storico del Novecento. La metafora della quercia e della ghianda serve a Bloch per introdurre lo spinosissimo tema delle ‘origini’, che ovviamente interessano molto allo storico: si direbbero quasi il nocciolo del suo mestiere. E invece no, dice Bloch. Lo storico sa bene che le origini sono importanti, che nessuna quercia esisterebbe senza la ghianda da cui è nata. Ma allo storico interessa soprattutto il percorso di crescita, interessa capire come e perché la quercia si sia sviluppata, quale terreno, quali condizioni ambientali e climatiche abbiano consentito all’embrione di diventare e restare albero. In una parola, allo storico interessa la storia. Le origini, che nell’immaginario collettivo sono spesso chiamate in causa come spiegazione e motivazione dell’esistente (Bloch lo definisce «idolo delle origini»), in realtà allo storico importano pochissimo.
Queste considerazioni valgono anche quando si parla di cibo. Le ‘origini’ di un prodotto (geografiche e storiche) sono oggi diventate un vero mito. Quante volte il concetto viene speso per ‘proteggere’ i prodotti sul piano legislativo e commerciale? Tutto lecito, s’intende. A patto di non scambiare la ghianda con la quercia, l’origine del prodotto con i motivi della sua durata nel tempo. Un prodotto alimentare interessa allo storico soprattutto per i modi in cui è stato impiegato, interagendo con altri prodotti in accostamenti gastronomici o ricette che ne hanno decretato il successo. Facciamo un esempio: gli spaghetti al pomodoro, simbolo della cucina italiana.
Le origini dei nostri spaghetti risalgono agli Arabi, che nel Medioevo portarono in Sicilia la pratica della pasta essiccata. Questo ‘embrione’ si acclimatò perfettamente nel nostro paese, diventando, per via di successive trasformazioni economiche, sociali, tecnologiche, un tratto tipico della gastronomia italiana. Nel diciannovesimo secolo gli spaghetti incontrarono la salsa di pomodoro, che fino a un secolo prima si chiamava ‘spagnola’ perché gli spagnoli, per primi, l’avevano introdotta negli usi di cucina; ma gli indigeni d’America (da dove il pomodoro proveniva) la usavano da secoli. Quali ‘origini’ hanno dunque gli spaghetti al pomodoro? Allo storico, questa domanda interessa fino a un certo punto. Di più gli interessa evidenziare il circuito di scambi che ha consentito l’apparire, la crescita e lo sviluppo di questo piatto nella tradizione italiana, a partire da elementi di altre culture. Le origini non spiegano nulla, e nulla hanno a che fare – in cucina e altrove – con la costruzione delle identità.
Tutti i falsi sono veri
Ricette italiane nel mondo. Vere o false? Autentiche o inventate?
Attenzione: vero e falso, autentico e inventato sono concetti delicati. Rabbrividisco quando leggo, o sento, che una ricetta è ‘vera’, mentre altre sarebbero ‘false’ e quindi da scartare. Rabbrividisco perché nulla esiste, nella storia, che non sia stato inventato da qualcuno, in qualche luogo, in qualche tempo. I piatti celebri della cucina italiana hanno tutti una storia, radicata in precisi contesti geografici e cronologici. Fissare una data di nascita è quasi sempre impossibile (a meno che non si tratti di una ricetta ‘d’autore’). Esiste in compenso una ricca aneddotica, fatta di miti, leggende, fantasie, che attribuiscono a questo o a quel personaggio, a questa o a quella occasione la nascita del nuovo piatto. La maggior parte delle leggende ruota attorno al concetto-chiave della necessità che aguzza l’ingegno, dello stato di emergenza che fa scattare l’invenzione: il cuoco del tal principe si trova improvvisamente a corto di un ingrediente ed escogita una nuova vivanda per non deludere il palato del signore; una carestia fa mancare il cibo e i contadini sopperiscono con un cibo di ripiego.
Di fronte a queste improbabili leggende, lo storico ha almeno un paio di osservazioni da fare.
Primo. È curioso come spesso questa ‘aneddotica dell’invenzione’ si sposi con l’idea – evidentemente contraddittoria – che esistano ricette ‘vere’ e ricette ‘false’, le une rispettose della ‘tradizione’, le altre no. Contraddizione provocata da quello che Marc Bloch chiamava «idolo delle origini».
Secondo. Ogni falso in qualche misura è vero. Lo insegna lo stesso Bloch e vuol dire che, una volta accertata la falsità di un racconto, resta il fatto che il racconto (anche se falso) esiste, e che qualcuno lo ha inventato. Tutto questo è indubbiamente vero e in quanto tale interessa lo storico. Di fronte a un racconto che è solo leggenda, lo storico è certo che la leggenda (in quanto leggenda) è vera, e non può limitarsi a dire che non è verità, ma deve cercare di capire chi l’ha inventata, quando e perché. Così anche il falso diventa un ‘vero’ documento storico.
Vero e falso: concetti da maneggiare con cura.
Spaghetti alla bolognese
Una commedia di Arnold Wesker (The kitchen) rappresenta la vita frenetica che si svolge nella cucina di un grande ristorante londinese, in cui le vicende personali di cuochi e camerieri si incrociano con gli ordini che arrivano, la carne da tagliare, i dolci da rifinire. Nella concitazione generale a un certo punto una cameriera grida: «Spaghetti alla bolognese!», e un suo collega commenta: «È buona la cucina italiana...».
L’opera di Wesker, scritta più di mezzo secolo fa, riflette un luogo comune consolidato, che individua gli ‘spaghetti alla bolognese’ come tipico piatto ‘italiano’, uno dei più conosciuti e richiesti nel mondo. Lo si ritrova anche in aree ‘marginali’ dell’Italia, come le zone alpine di lingua tedesca o ladina, dove ogni rifugio che si rispetti non manca di proporlo a escursionisti e sciatori. Gli spaghetti con le polpette di carne ne sono una simpatica variante americana, immortalata anche da Walt Disney in una famosa scena di Lilly e il vagabondo.
Eppure, nella tradizione bolognese questo piatto non esiste. Esso è nato, come in un esperimento di laboratorio, dalla contaminazione fra due prodotti emblematici della tradizione gastronomica italiana, gli spaghetti di pasta secca (siciliani nel Medioevo, napoletani in età moderna) e il ragù di carne con cui a Bologna si condiscono le tagliatelle di pasta fresca all’uovo.
I puristi della cucina bolognese si stracciano le vesti, non esitano ad affermare che gli spaghetti alla bolognese ‘non esistono’, che sono ‘pura invenzione’. Ma dobbiamo distinguere: sono un’invenzione, certo. Come tutto. Esiste forse qualcosa, nelle pratiche di cucina, che non sia stato inventato da qualcuno prima di diventare patrimonio collettivo? Ciò che chiamiamo tradizione non è altro che una invenzione ben riuscita. Anche gli spaghetti alla bolognese lo sono: piacciono a molti, ed è questa la condizione che garantisce il successo e la durevolezza di una ricetta. Se i bolognesi la ripudiano, non per questo possiamo dire che ‘non esiste’. Essa esiste eccome. Semmai è l’attribuzione a Bologna a essere fuorviante, anzi falsa, ma di falsi è piena la nomenclatura gastronomica e sarebbe impensabile cancellarli o correggerli tutti. Ai bolognesi consiglierei piuttosto di entrare nel gioco, recuperando essi stessi, con leggerezza e ironia, la stramba immagine che il nome di quella ricetta ha proiettato sulla loro cucina. In fondo, qualcosa del genere è già accaduto: in Francia, nel Medioevo, si inventò per Bologna l’attributo di ‘grassa’, e i bolognesi non tardarono a farlo proprio.
Per questo mi ha molto divertito la provocatoria iniziativa di un ristoratore di Bologna che ha avuto il coraggio di inserire nel suo menù gli spaghetti alla bolognese (anzi, all’inglese: spagetti bolognese, senza ‘h’). Vi assicuro che sono squisiti.
Lasagne
Dici lasagne e ti vengono in mente Bologna, il ragù, la besciamella. Ma la più antica ricetta di lasagne è nel Liber de coquina, un testo scritto alla corte angioina di Napoli agli inizi del Trecento. E il ragù non è previsto: nel Medioevo non solo le lasagne, ma ogni genere di pasta si condisce solo con burro e formaggio (la besciamella arriverà solo nel diciottesimo secolo). Perciò le lasagne possono comparire come vivanda ‘di magro’: in una novella quattrocentesca di Sabadino degli Arienti, i monaci bolognesi di S. Procolo le mangiano di venerdì, «giorno di passione». Le attingono col cucchiaio da un «catino» appena sfornato, caldissimo. E proprio il calore della vivanda sarà protagonista del racconto: un monaco particolarmente affamato (o goloso) non riesce ad attendere e si affretta a imboccare una cucchiaiata di lasagne. Il volto gli si infiamma, il calore insopportabile lo opprime, dagli occhi gli escono lacrime. «Perché piangi?», gli chiede un fratello. E lui, per non svelarsi: «Piango la sorte dei nostri compagni che quest’anno sono morti di peste». Poco dopo, anche l’altro monaco addenta le lasagne bollenti, e pure lui si mette a piangere dal dolore: «Perché piangi?», gli chiede il primo. «Della stessa cosa di cui piangevi tu», gli risponde, ironico.
Nel racconto di Sabadino c’è anche un curioso retroscena: il «catino» di lasagne è preparato e servito in tavola da un cuoco «ch’era tedesco» e lavorava nella cucina del monastero. Forse fu proprio a Bologna che quel tedesco apprese l’arte di far lasagne. Ma i libri di cucina medievali sembrano attestare una larga presenza di questa pratica culinaria, in Italia e fuori d’Italia. In ogni caso, il particolare rivela un’interessante contaminazione di culture. Lasagne vuol dire Bologna, ragù, besciamella. Ma anche altri luoghi, e altri condimenti.
La ricetta del Liber de coquina è molto dettagliata. Spiega che la pasta deve essere fermentata (particolarità che, in qualche modo, assimila la pasta al pane). Che va stesa sottile e poi divisa in quadrati della larghezza di tre dita. Poi bisogna bollirla in acqua e condirla, a strati alterni, con formaggio grattugiato (caseum gratatum) e, a piacere, spezie in polvere.
Il gusto delle lasagne attraversa l’intero corpo sociale: tra Medioevo e Rinascimento, con il progressivo affermarsi della cultura della pasta, il loro successo è generale, nelle città come nelle campagne, nei castelli nobiliari come nell’eremo di Camaldoli (dove sappiamo che erano servite in certe festività, secondo un preciso calendario). Anche un sonetto di Simone Prudenzani, cittadino di Orvieto, insiste sul carattere festivo di questa vivanda, ironizzando sulla ‘devozione’ di una pia donna che approfitta di ogni santa ricorrenza per fare scorpacciate del piatto di rito in quel giorno – per esempio, delle «lasagnie di Natale».
Nelle corti signorili le lasagne potevano essere servite come contorno alle carni: «capponi appastati alessati coperti di lasagne» compaiono nel ricettario di Bartolomeo Scappi, il più importante cuoco italiano del Rinascimento. Nell’uso popolare, invece, le lasagne conservano il loro statuto di vivanda complessa, ricca, autosufficiente. Come scriverà Girolamo Cirelli nel 1694, i contadini «pretendono di fare un gran sfoggio, quando invitano un amico a mangiare, il darli lasagne».
Tortelli vs ravioli
Oggi sono praticamente sinonimi. Magari hanno forme diverse o cambiano nel ripieno, ma i nomi sono di fatto intercambiabili. Parlo dei ‘tortelli’ e dei ‘ravioli’.
In origine non era così. Nel Medioevo, quando fu inventata la pasta ripiena, ‘tortelli’ e ‘ravioli’ erano due cose diverse. ‘Tortello’ era l’involucro di pasta, il contenitore. Termine derivato da ‘torta’, una specialità gastronomica dell’epoca, geniale invenzione per racchiudere, cuocere, trasportare il cibo dentro una crosta di pane poco lievitato, molto duro, spesso immangiabile. In una civiltà che nel frattempo stava sviluppando la cultura della pasta, era abbastanza naturale che nascesse l’idea di utilizzare anche la pasta – dopo averla ritagliata in piccoli pezzetti – per contenere ingredienti di vario genere. «Io credo nella torta e nel tortello: l’una è la madre e l’altro il suo figliuolo», proclama Margutte nel Morgante di Luigi Pulci. Proseguendone il credo, aggiungeremo che i tortellini (o «tortelletti», come si chiamavano nel Medioevo) ne sono i nipoti.
‘Raviolo’ invece era l’interno, il contenuto: la polpettina di carne, o di formaggio, o di verdura, o di qualsiasi cosa entrasse nel tortello dopo essere stata opportunamente ‘raviolata’ (in certi dialetti italiani esiste ancora questa curiosa parola, a indicare il gesto di accarezzare la polpettina facendola rotolare su se stessa).
Dunque il raviolo può essere nudo: nel tredicesimo secolo il francescano Salimbene ricorda di avere mangiato per la festa di Santa Chiara dei «ravioli senza crosta di pasta». A loro volta, i tortelli possono essere vuoti: uno dei più antichi ricettari italiani, nel quattordicesimo secolo, spiega che si possono fare di qualsiasi forma, a ferro di cavallo, a fibbia, ad anello, a forma di animale, ecc., e alla fine aggiunge: «puoli empiere, se tu vuoli». Se vuoi, puoi riempirli. Ma non è detto che accada. Una cronaca medievale racconta che i cittadini di Parma, in un anno di grave penuria alimentare, non avevano nulla da mettere dentro le torte ma continuavano ugualmente a prepararle, lasciandole vuote. Lo stesso avrebbero potuto fare coi tortelli.
I ricettari italiani hanno a lungo conservato questa distinzione. Bartolomeo Scappi, nel Cinquecento, prevede ravioli «con spoglia» o «senza spoglia». Nel Seicento, Giovanni Del Turco prescrive come fare i ravioli «con il medesimo ripieno dei tortelli, ma senza spoglia». Pellegrino Artusi, alla fine dell’Ottocento, ci fa capire che la distinzione ormai non funziona più. Dopo aver dato la ricetta dei «ravioli all’uso di Romagna», semplici gnocchetti di farina, ricotta, parmigiano e uova (dunque ravioli nel senso antico), passa ai «ravioli alla genovese» e commenta: «Questi, veramente, non si dovrebbero chiamar ravioli, perché i veri ravioli non si involgono nella sfoglia». Intanto però li chiama ravioli.
Minestrine
La miniaturizzazione dei formati di pasta è un fenomeno tipico del Medioevo. Dalla sfoglia-madre, la larga lasagna conosciuta già dai Romani, nei secoli medievali si cominciarono a ritagliare lunghe fettucce o sghembi riquadri. Tenendo grosso l’impasto e manipolandolo opportunamente, si trassero ‘spaghi’ e cilindri forati, antesignani dei moderni spaghetti e macc...