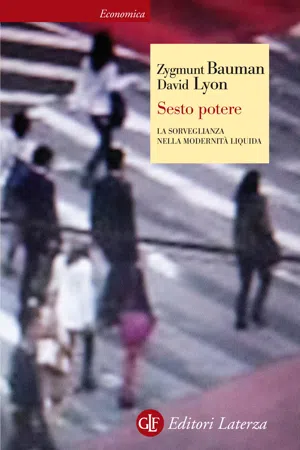1. Droni e «social media»
David Lyon La prima questione che vorrei porti, prendendo le mosse dai commenti introduttivi sulla sorveglianza liquida, è questa: nel mondo che hai chiamato liquido-moderno la sorveglianza assume nuove, significative forme, di cui i droni e i social media – come hai notato recentemente intervenendo in un blog – sono ottimi esempi. Sia gli uni che gli altri generano informazioni personali per ulteriori elaborazioni, ma lo fanno in modi diversi. Esiste tra questi mezzi una complementarietà, data ad esempio dal fatto che l’uso dei social media ci prepara all’estrazione inavvertita di dati personali attraverso droni sempre più miniaturizzati? E che cosa comportano per noi questi sviluppi, in termini di anonimato e di relativa invisibilità nel mondo quotidiano?
Zygmunt Bauman Forse il piccolo intervento che hai ricordato, pubblicato mesi fa in un blog sul sito di «Social Europe», può essere un buon punto di partenza. Spero che mi perdonerai se lo cito ampiamente. In quel saggio mettevo insieme due notizie, apparentemente scollegate, uscite lo stesso giorno, il 19 giugno 2011: nessuna di queste notizie ha avuto titoloni, ed è più che comprensibile che l’una, l’altra o entrambe siano passate inosservate a molti lettori. Anche queste due notizie, come qualsiasi altra, sono arrivate fino a noi con lo «tsunami informativo» quotidiano: sono solo due gocce nel diluvio di notizie che, se apparentemente si propone di portare luce e chiarezza, in realtà ottenebra la vista e stordisce lo spettatore...
Una delle notizie, firmata da Elisabeth Bumiller e Thom Shanker, parlava dello spettacolare aumento del numero di droni, con dimensioni paragonabili a quelle di una libellula o di un colibrì, in grado di posarsi su un davanzale e progettati, secondo la significativa espressione dell’ingegnere aerospaziale Greg Parker, «per essere invisibili anche quando li abbiamo davanti agli occhi». La seconda notizia, redatta da Brian Stelter, proclamava Internet come «la fine dell’anonimato». Le due notizie, pur essendo state redatte indipendentemente l’una dall’altra e senza sapere dell’esistenza reciproca, presagivano e preannunciavano, all’unisono, la fine della invisibilità e dell’autonomia: i due attributi che definiscono la privacy.
I droni senza equipaggio, adibiti agli stessi compiti di spionaggio e di attacco che hanno reso famosi i Predator («oltre 1.900 insorti nelle aree tribali del Pakistan uccisi da droni americani dal 2006»), stanno per ridursi alla dimensione di volatili, o meglio ancora di insetti (il batter d’ali degli insetti, rispetto a quello degli uccelli, tecnicamente sembra molto più facile da riprodurre e secondo il maggiore Michael J. Anderson, dottorando in tecnologia di navigazione avanzata, le eccellenti caratteristiche aerodinamiche della sfinge – lepidottero che si distingue per la grande abilità nel volo stabile – sono state scelte come obiettivo, non ancora raggiunto ma destinato a esserlo quanto prima, dell’attuale fermento progettuale, che potenzialmente farà apparire superato tutto ciò che «sa fare la nostra goffa aeronautica»).
La nuova generazione di droni resterà invisibile ma renderà visibile tutto il resto; resterà invulnerabile ma renderà vulnerabile qualsiasi cosa. Come ha affermato Peter Baker, professore di etica alla United States Naval Academy, quei droni faranno entrare la guerra nell’«era post-eroica», ma secondo altri studiosi di «etica militare» amplieranno ulteriormente lo «sganciamento» già in atto «tra l’opinione pubblica americana e la sua guerra»; in altri termini, faranno un altro passo da gigante (il secondo, dopo la sostituzione dell’esercito di leva con forze armate professionali) verso l’obiettivo di rendere la guerra invisibile alla nazione nel cui nome viene combattuta la guerra stessa (nessuno dei suoi cittadini rischierà la vita), rendendola dunque più facile e allettante, grazie anche alla quasi totale assenza di danni collaterali e di costi politici.
I droni di nuova generazione vedranno tutto ma resteranno comodamente invisibili, in senso letterale oltre che metaforico. Non ci sarà più dove rifugiarsi per non essere spiati: per nessuno. Persino i tecnici che inviano i droni rinunceranno a controllarne i movimenti, nemmeno loro (per quanto sollecitati in tal senso) saranno più in grado di rendere un oggetto immune a una eventuale sorveglianza: i droni «nuovi e migliori» saranno concepiti per volare per proprio conto, seguendo itinerari a loro scelta in momenti a loro scelta. Una volta messi in esercizio nelle quantità previste, non ci sarà limite alle informazioni che forniranno.
In realtà è proprio questo l’aspetto della nuova tecnologia di spionaggio e sorveglianza in grado di operare autonomamente a distanza che più preoccupa i suoi progettisti, e con loro i giornalisti che ne riportano le preoccupazioni: uno «tsunami di dati» sta già sommergendo il personale del quartier generale dell’Aeronautica Militare, minacciando di superare la sua capacità di elaborazione e assimilazione, e con ciò di sfuggire al controllo suo e di chiunque altro. Dopo l’11 Settembre il numero di ore necessarie ai dipendenti dell’Air Force per riutilizzare l’intelligence fornita dai droni è aumentato del 3.100% – e ogni giorno alla quantità di informazioni che chiede a gran voce di essere elaborata si aggiungono altre 1.500 ore di video. Una volta che nei sensori dei droni la visuale ristretta, «a cannuccia da bibita», sarà stata sostituita (come è imminente) dallo «sguardo da Gorgone», capace di coprire d’un solo colpo un’intera città, per far fronte ai dati inviati da un solo drone non basteranno più 19 analisti, ma ce ne vorranno 2.000. Tuttavia, aggiungo, ciò significa soltanto che pescare dal contenitore inesauribile dei «dati» un oggetto «interessante», «rilevante», richiederà un sacco di lavoro e costerà un sacco di soldi, e non certo che un qualsiasi oggetto di potenziale interesse sia al riparo dal rischio di essere sbattuto in quel contenitore. Nessuno saprà mai per certo se o quando un «colibrì» si poserà sul suo davanzale.
Quanto alla «morte dell’anonimato», di cui Internet ci fa gentile omaggio, la storia è leggermente diversa: in questo caso siamo noi, per nostra volontà, a mandare al massacro il nostro diritto alla privacy. O forse acconsentiamo a perdere la privacy perché lo consideriamo un prezzo ragionevole da pagare in cambio delle meraviglie che ci vengono offerte. O ancora, la pressione a consegnare al mattatoio la nostra autonomia personale è così forte, e ci avvicina a tal punto alla condizione di un gregge di pecore, che solo pochissime volontà eccezionalmente ribelli, audaci, combattive e risolute sono preparate a tentare seriamente una resistenza. In un modo o nell’altro, però, ci viene offerta, almeno sulla carta, la parvenza di un contratto bilaterale e, almeno formalmente, abbiamo il diritto di sporgere reclamo o fare causa se quel contratto dovesse essere violato: tutte cose di cui nel caso dei droni non c’è più alcuna traccia.
Eppure, nonostante tutto, una volta dentro siamo ostaggio della sorte. Come osserva Brian Stelter, «l’intelligenza collettiva dei due miliardi di utenti Internet e le impronte digitali che tanti di loro lasciano nei siti web si combinano rendendo sempre più facile risalire alla fonte di qualsiasi video imbarazzante, di qualsiasi foto intima e di qualsiasi email sconveniente: che la fonte lo voglia o no». A Rich Lam, fotografo freelance che aveva documentato i disordini scoppiati nelle strade di Vancouver, è bastato un giorno per rintracciare e identificare due persone che si baciavano appassionatamente e che erano (casualmente) finite in uno dei suoi scatti. Ormai tutto ciò che è privato avviene potenzialmente in pubblico, è potenzialmente disponibile al pubblico consumo e tale resta per tutto il tempo, fino alla fine dei tempi, poiché è impossibile «far dimenticare» a Internet qualcosa una volta che è stato registrato in uno dei suoi innumerevoli server. «Questa erosione dell’anonimato è un prodotto di social media pervasivi, di servizi di hosting gratuito di foto e video e – la cosa forse più importante di tutte – di un mutamento di opinione delle persone riguardo a cosa debba essere pubblico e cosa debba essere privato». Tutti quei gadget tecnici sono, ci dicono, «user-friendly»: anche se quella frase tanto amata dai copy pubblicitari segnala, a ben vedere, un prodotto che per essere completo richiede, un po’ come i mobili Ikea, uno sforzo da parte dell’utilizzatore e, aggiungo, la devozione entusiastica e il plauso assordante degli utenti. Un Étienne de la Boétie contemporaneo probabilmente non parlerebbe più di servitù volontaria, ma addirittura «fai da te»...
Che conclusione possiamo trarre da questo incontro tra operatori di droni e gestori di account Facebook, ossia tra due figure che apparentemente hanno fini diversi e sembrano animati da motivazioni opposte, ma ciononostante collaborano strettamente, volontariamente e molto efficacemente nel produrre, sostenere ed espandere quello che tu hai felicemente chiamato social sorting? Io credo che la caratteristica più saliente della versione contemporanea della sorveglianza sia il fatto che è riuscita in qualche modo a costringere e persuadere gli opposti a lavorare all’unisono, a metterli tutti al servizio della stessa realtà. Da una parte, il vecchio stratagemma panottico («non saprai mai quando osservano il tuo corpo, e in tal modo la tua mente non smetterà mai di sentirsi osservata») viene implementato, gradualmente ma in modo coerente e apparentemente inarrestabile, su una scala pressoché universale. Dall’altra parte, ora che il vecchio incubo panottico di «non essere mai soli» ha ceduto il posto alla speranza di «non essere mai più soli» (abbandonati, ignorati e negletti, bocciati ed esclusi), la gioia di essere notati ha la meglio sulla paura di essere svelati.
Naturalmente questi due sviluppi, e soprattutto la loro riconciliazione e collaborazione per uno stesso compito, sono resi possibili dal fatto che all’incarcerazione e al confino è subentrata l’esclusione nel ruolo di minaccia numero uno alla sicurezza esistenziale e di principale fonte di ansia. La condizione di essere sorvegliati e visibili è stata derubricata da minaccia a tentazione. La promessa di accresciuta visibilità, la prospettiva di essere «allo scoperto» e di poter essere visti e notati da tutti, ben si collega all’ambita prova di essere socialmente riconosciuti e, dunque, di avere un’esistenza valorizzata, «significativa». Il fatto che tutta la nostra esistenza, nel bene e nel male, sia registrata in archivi pubblicamente accessibili appare l’antidoto più potente alla pericolosità dell’esclusione e un modo efficace per tenere a bada la minaccia dell’espulsione; anzi, è una tentazione cui pochi tra coloro che vivono una vita sociale dichiaratamente precaria si sentiranno abbastanza forti da resistere. La vicenda del recente, fenomenale successo dei «siti social» su Internet mi sembra un eccellente esempio di questa tendenza.
Effettivamente, il ventenne studente fuoricorso di Harvard Mark Zuckerberg, inventando Facebook (o, secondo alcuni, rubandone l’idea) e lanciandolo su Internet nel febbraio del 2004 a uso esclusivo degli studenti di Harvard, si era imbattuto in una specie di miniera d’oro: questo è evidente. Ma che cos’era quel minerale simile all’oro che «Lucky Mark» ha scoperto e continua a estrarre con profitti favolosi e in continuo aumento?
Così vengono descritti, sul sito ufficiale di Facebook, i vantaggi che avrebbero tentato, attratto e sedotto quel mezzo miliardo di persone, portandole a trascorrere nelle sue lande virtuali buona parte del loro tempo di veglia:
Gli utenti possono creare profili con foto, elenchi di interessi personali, dati di contatto utili e altre informazioni personali. Possono comunicare con amici e altri utenti tramite messaggi privati o pubblici e via chat. Possono inoltre creare o associarsi a gruppi d’interesse e pagine «mi piace» (quelle che fino al 19 aprile 2010 si chiamavano «pagine fan»), alcune delle quali sono gestite da organizzazioni che se ne servono come canale pubblicitario.
In altre parole, la prospettiva entusiasticamente abbracciata da vaste schiere di persone entrate a far parte degli «utenti attivi» di Facebook è la possibilità di avere due cose che sicuramente sognavano anche prima che Zuckerberg offrisse il servizio su Internet ai suoi colleghi di Harvard, ma che non sapevano dove cercare e trovare. Innanzitutto, quelle persone dovevano sentirsi molto sole, ma per un motivo o per l’altro trovavano troppo difficile sfuggire alla solitudine con i mezzi a loro disposizione. In secondo luogo, dovevano sentirsi penosamente trascurate, inosservate, ignorate e dirottate su un binario morto, esiliate ed escluse, ma anche in questo caso dovevano trovare difficile, se non impossibile, tirarsi fuori da quell’odioso anonimato con i mezzi a loro disposizione. Zuckerberg ha offerto loro gli strumenti per entrambi questi scopi, strumenti che fino ad allora avevano cercato invano e di cui sentivano terribilmente la mancanza. E loro hanno afferrato al volo l’occasione... Dovevano essere prontissimi, piedi ai blocchi di part...