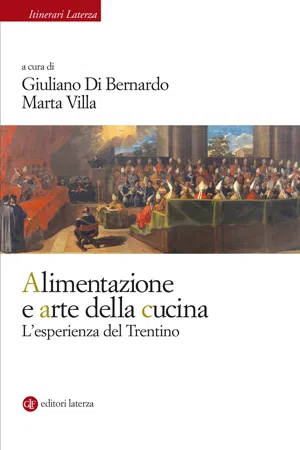Quando il cibo è specchio del territorio:
l’antropologia culturale e l’alimentazione
Marta Villa
La cucina di un popolo
è la sola esatta testimonianza della sua civiltà.
E. Briffault
1. Introduzione
Il cibo è una delle possibilità concrete per poter incontrare e scoprire un popolo e il territorio in cui esso abita: potrebbe infatti esserne la sua immagine speculare. Sono proprio gli alimenti e la cucina, che ne è l’ars combinatoria, che permettono all’uomo di apprezzare ciò che un ambiente offre spontaneamente: decide infine di modellare lo spazio a propria immagine e somiglianza, o meglio secondo la necessità del proprio gusto. Il territorio grazie agli alimenti che produce parla di sé presentando al nostro sguardo, anche solo frettoloso, il proprio capitale economico, sociale e culturale. Il cibo diventa allora una rappresentazione del luogo e viene percepito come autentico e legato alla dimensione intima e identitaria della comunità: il sapore diviene un sapere culturalmente trasmesso tra le generazioni e si sedimenta.
Alcuni cibi, che pensiamo di origine tradizionalmente lontana nel tempo, sono invece di scoperta recente, altri invece che sembrano assai moderni affondano le radici nella storia più antica. Gli alimenti infatti ingannano poiché si adattano facilmente, subiscono processi di addomesticamento da parte della cultura che li sussume dentro di sé.
La cucina è certamente una modalità di studiare ed esperire una cultura nella sua manifestazione nel contempo più intima e individuale ma anche più esteriore e collettiva: molte delle tradizioni alimentari del mondo oggi sono il risultato di una storia di sovrapposizioni e di incontri. Abitudini lontane vengono assimilate e incorporate, spazio e tempo sembrano vivere in una dimensione diversa da quella conosciuta: si trovano sposati a volte in una stessa preparazione tempi arcaici e luoghi distanti tra loro.
La cucina infine permette di osservare da un punto di vista privilegiato e specialissimo la cultura di cui è parte: gli ingredienti sono dei legami unici tra la memoria e il passato anche millenario che li ha avvicinati, sono essi stessi una porta verso un altrove mentale e reale e portano con sé tradizioni famigliari alle quali difficilmente riusciamo a rinunciare.
La memoria e la nostalgia sono elementi che troviamo nella valigia di qualsiasi essere umano, viaggiatore per diletto o per forza, che si allontana dalla casa e dal territorio che possiamo definire propria patria geografica, culturale, spirituale. Memoria, nostalgia e cibo diventano allora i vertici di un triangolo i cui lati sono indissolubili: odori e sapori vengono all’uomo senza che egli li possa fermare e mettono in moto forze e tensioni legate ai ricordi ai quali si è impossibilitati a non cedere.
2. La madeleine, una “focaccia” straordinariamente ordinaria
Che cos’è la madeleine? Forse è possibile definirla come uno dei dolci più citati della storia della letteratura mondiale dopo che il suo padre intellettuale, Marcel Proust, ne ha fatto un simbolo di cosa possa e voglia essere il cibo per l’essere umano. Una semplice focaccina di farina, zucchero, burro e uova, dalla forma quasi a barchetta è divenuta un topos mentale prima che culinario.
Nella prima parte di Dalla parte di Swann, primo volume di Alla ricerca del tempo perduto, il protagonista del romanzo attraverso il celebre episodio della madeleine riesce a rievocare la sua infanzia nel piccolo villaggio francese di Combray. Proust permette al suo narratore di vivere una delle esperienze sensoriali più interessanti che la letteratura occidentale ci ha lasciato in dono. Il passaggio presente nelle prime pagine del testo ha una importanza nodale e, anche per chi si occupa di cibo e legami con la memoria umana, è un esempio che, al di là del sommo valore letterario, può svelare il sodalizio indissolubile e profondissimo che viene a crearsi tra cibo e cultura, di cui la madeleine è il più umile, ma autorevole rappresentante.
Ed ecco portai alle labbra un cucchiaino di the, in cui avevo inzuppato un pezzo di madeleine. Ma nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M’aveva subito reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità inoffensive, la sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l’amore, colmandomi di una essenza preziosa: o meglio, questa essenza non era in me, era me stesso.
Il dolcetto francese è un mezzo che permette a Proust di introdurre il significato e il valore della memoria, e come tale deve essere analizzato: dal punto di vista antropologico l’atto descritto è assimilabile a una esperienza rituale scatenata da un cibo appartenente all’ordinario, ma che ha in sé qualcosa di così necessario e di evocativo che gli permette di divenire straordinario. Quando un sapore assale gli organi sensoriali umani (olfatto e papille gustative) in modo così intenso da permettere la riemersione del profondo, diviene veicolo per ciascun individuo per affrontare un percorso emotivo a ritroso: un viaggio della memoria.
Per l’antropologia questa associazione di sapore e memoria è molto importante perché è una operazione solo e squisitamente culturale. Un cibo potrebbe riportare alla mente l’infanzia, un tempo perduto esteriormente ma assolutamente vitale ed energico dentro di sé, oppure luoghi e tempi della vita legati a ricordi. La potenza di un sapore possiede in sé la capacità di far rivivere situazioni passate; per questo l’uomo non è capace di trovare una spiegazione plausibile attraverso una parte del proprio cervello, quello sinistro, parlante e calcolatore, a un’esperienza fatta con l’emisfero destro, emotivo e sensoriale.
La madeleine può essere così il simbolo del tempo perduto, della memoria, della facoltà umana di ricordare e per questo chiave del testo proustiano perché assimilabile alla coscienza: la meravigliosa possibilità data da questa esperienza è la sua semplicità. Tale azione può essere rivissuta e ogni volta potrà avvenire qualcosa che procura un piacere impossibile da fermare.
Il ricordo gratifica: il cibo avvicina a luoghi lontani e a tempi passati; sapori e odori possono creare nell’essere umano sensibile qualcosa di unico e svolgono una azione prepotente. La volontà, e quindi il raziocinio, non riescono a opporre una barriera e vengono travolti: il risultato è qualcosa che si può solo vivere. La potenza della madeleine descritta da Proust lascia il lettore senza parole, capace solo di ascoltare cosa accade in sé di fuori dal comune. Per l’antropologo questa esperienza da documentare in una comunità, in una famiglia o in un singolo individuo è irrinunciabile: in tal modo è possibile costruire una vera e propria mappa degli affetti, della memoria, delle radici, dell’appartenenza; anch’essa contribuisce alla formazione della identità personale e collettiva di cui ciascun individuo è portatore.
Proust ci rivela in questo passaggio un altro binomio estremamente vero e specificatamente umano: cibo e amore colmano di una essenza preziosa che si rivela essere presente non in noi stessi, ma essere noi stessi. L’assenza della preposizione inclusiva è cruciale: se si comprende che quello che sta avvenendo è il nostro essere umani e non qualcosa che è solo dentro di noi, è possibile cogliere quanto la memoria abbia una importanza costitutiva per la nostra cultura e la nostra società. Sapore, amore e memoria sono vincolati in una simbiosi emozionale che è privilegio solo della nostra specie: solo l’uomo è in grado di percepire e riconoscere la straordinarietà di questo tipo di esperienza.
Scrive l’antropologa Alessandra Guigoni:
raccolta, conservazione, coltivazione, preparazione e consumo del cibo costituiscono attività indispensabili in tutte le società umane. L’atto di nutrirsi è essenziale per la nostra permanenza in vita, e più in generale per la sopravvivenza di tutti gli esseri viventi sulla Terra. Quest’atto, in apparenza meramente fisiologico e materiale, è anche carico di significati culturali, sociali e simbolici. L’alimentazione difatti è un fatto culturale e sociale, ogni cultura regola l’alimentazione dettando una serie di norme più o meno esplicite e rigide che fissano cibi commestibili e cibi considerati ripugnanti o vietati, ma anche i modi di preparazione, tempi e luoghi, contesti e persone con cui il cibo può o deve essere consumato. Il consumo del cibo, in una parola, è un procedimento per costruire, comunicare regole sociali, gerarchiche, legami.
Cibo e cultura hanno infatti una relazione significativa: qualsiasi essere vivente si alimenta per sopravvivere, ma l’unico che dona a questo atto un significato simbolico eccezionale è l’uomo.
3. Quando l’antropologo siede a tavola:
il simposio di Claude Lévi-Strauss
L’etnografia riguardante l’alimentazione sta assumendo sempre più importanza nella nostra società: parlare di cibo con un altro essere umano significa entrare in una relazione profonda con lo stesso; se il dialogo non è superficiale, vengono svelati pensieri e situazioni significative per comprendere l’altro da sé, soprattutto in un contesto di incontro cultu...