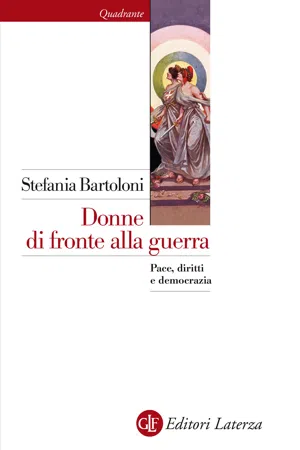IV.
Una lunga guerra
1. Caporetto
Il 24 ottobre 1917, con un pesante bombardamento sul fronte dell’Isonzo, ebbe inizio la battaglia di Caporetto che si concluse con una disfatta e inaugurò una nuova fase della guerra e della storia del paese. Il 9 novembre l’invasione del territorio e l’arretramento dell’esercito si stabilizzarono sulla linea del Piave dopo aver messo fuori combattimento, tra morti, feriti e prigionieri, circa trecentocinquantamila uomini, una cifra impressionante che quasi dimezzò il numero complessivo dei militari italiani. Mentre la popolazione cercava di riprendersi dallo stupore e dalla preoccupazione, centinaia di migliaia di profughi si riversarono sulle città più vicine e tutti gli italiani furono chiamati a prestare aiuto. Dopo ventinove mesi di operazioni belliche, col loro portato di morte, dolore e disagi, l’idea del nemico in casa agì come una potente sferzata e tutto, anche la profonda stanchezza, passò in secondo piano.
Fin dall’inizio i motivi per giustificare l’entrata nel conflitto non erano certo mancati e vi avevano contribuito idee vecchie e nuove, ma quella che fu classificata come guerra giusta, inevitabile, o tragica necessità, divenne a un certo punto una guerra santa per ricacciare il nemico e riconquistare la dignità. Come giustificare una delle peggiori iatture dell’umanità, si era chiesta Beatrice Casati nell’estate del ’15? La guerra è brutta cosa, affermò con sicurezza, ma poi aggiunse «esalta i migliori sentimenti umani, cementa la solidarietà nazionale e spinge lo spirito di sacrificio a limiti impreveduti». Ciò che si chiedeva ora agli italiani era proprio varcare quel confine che, facendo appello a tutte le forze, portava a impegnarsi oltre ogni umana possibilità. Non si trattava di far riferimento alle eroiche virtù e alle orgogliose tradizioni nazionali, ma di allontanare il pericolo e di riscattare un popolo ferito e umiliato.
Per fronteggiare la nuova fase furono rafforzate la propaganda per la resistenza interna e l’assistenza che, in quest’ultimo caso, dovette diversificarsi per ottemperare alle innumerevoli necessità. Nel giro di poco nacque l’Ufficio notizie per i profughi delle terre invase, mentre per i militari caduti prigionieri venne rafforzata la collaborazione con la Croce Rossa e con la Santa Sede. Per le femministe del fronte interno significò mettere nuovamente da parte la piattaforma di richieste lanciata al Convegno dell’ottobre appena passato e che aveva ottenuto l’appoggio degli esponenti politici lì intervenuti. L’emergenza dovette fare i conti con la spossatezza che si manifestava da tempo in coloro che avevano aderito alle associazioni e ai comitati patriottici e di assistenza civile nati a supporto del conflitto. Per questo dall’Unione femminile fu indetto un comizio a cui parteciparono tutti i sodalizi femminili lombardi. Riunite a Milano il 27 dicembre, nel salone della Borsa, le intervenute si contarono e sull’onda di una fortissima emozione chiesero al governo:
a) che vengano energicamente applicate tutte quelle restrizioni che la gravità dell’ora reclama, non esclusa la chiusura dei teatri di varietà;
b) che siano soppressi l’Avanti e tutti quei giornali che fanno opera di disfattismo;
c) che siano espulsi tutti i tedeschi dall’Italia e sia intensificata la vigilanza per scoprire i traditori della Patria.
Poi si dissero pronte a sostituire i militari imboscati negli uffici, a far propaganda verso il popolo, essere esempio di austerità e vigilare ovunque si trovassero per contrastare le trame dei disfattisti. Al pari di ciò che chiedevano da tempo gli interventisti più oltranzisti, le partecipanti espressero la loro disponibilità a osservare tutte le disposizioni restrittive che il governo avrebbe varato. Nel frattempo, presso l’Unione femminile si costituì un gruppo di profughe e di fuoriuscite trentine. A loro portò un saluto Alma Dolens, che a Milano aveva dato vita alla Società Pro civiltà, una delle tre principali organizzazioni femminili aderente alla Federazione nazionale delle Leghe d’azione antitedesche. Il numero unico «La riscossa», uscito qualche giorno dopo il Comizio del 27 dicembre, riportò gli interventi di Ada Negri, Maria Magnocavallo e del mutilato Paulucci de Calboli. All’incontro non partecipò Ersilia Majno, in totale disaccordo con la torsione subita dall’associazione che aveva contribuito a fondare. Lontana dalla linea della presidente Clara Ferri, qualche mese prima, come consigliera, aveva rassegnato le sue dimissioni dal Consiglio d’amministrazione, anticipando una scelta che tre anni dopo l’avrebbe portata a dimettersi addirittura da socia dell’Unione. Dietro il dissenso di Majno vi era l’angoscia per il mutamento di clima e per le manifestazioni di paura e di odio che animavano le sue antiche compagne di lotta.
Le iniziative non finirono lì. In un elegante cofanetto in pelle furono raccolte e inviate al neo presidente del Consiglio Orlando circa seimilatrecento schede con centinaia di migliaia di firme di donne. Le firme vennero raccolte dal Comitato femminile di mobilitazione volontaria, nato all’indomani di Caporetto sotto la presidenza di Angelina De Leva, già a capo del Comitato femminile per gli aiuti alla patria in caso di guerra, di concerto col Comitato d’azione tra i mutilati invalidi e feriti di guerra di Milano. Nell’appello si avanzarono quattro richieste, ancor più radicali di quelle lanciate dalle femministe, che anticipavano il decreto sui civili di nazionalità nemica emanato nel gennaio successivo. Dopo le misure restrittive varate nei loro confronti nell’agosto del 1916, si chiedeva l’internamento di tutti i sudditi nemici, la confisca dei loro beni, il sequestro di tutti i crediti e la requisizione degli appartamenti dove erano in affitto per ospitarvi i profughi delle province invase. Inoltre si affermò:
Noi, Donne Lombarde, che non vogliamo essere indegne dei nostri cari che versano il loro sangue alla frontiera; in quest’ora, che per la violazione del Territorio Nazionale, ha reso più tragico lo spasimo della guerra, più sacro il compito della difesa della Patria ad ogni cuore italiano, sentiamo di non avere più soltanto il diritto, ma anche e soprattutto il dovere di esprimere qual’è [sic] la nostra volontà a cui il Governo d’Italia deve inchinarsi.
Non possiamo più tacere, né parlare a mezzo, né indulgere. [...] Coloro che combattono, quanti soffrono, amano e odiano italianamente, ci ascoltino; e sia il nostro monito irresistibile perché ogni tregua, ogni transazione con chi ancora abusa, ospite subdolo, della nostra debolezza, senta che l’Italia, sorta dall’attimo della sventura, si è fatta più salda, più forte e inesorabile contro ogni insidia, ogni frode nemica.
Nella capitale, in un clima da caccia alle streghe, il 17 novembre si tenne un’affollatissima riunione di interventisti a cui parteciparono per il Comitato femminile per l’intervento italiano Bice Sacchi, Anna Maria Mozzoni, Romelia Troise, Elvira Cimino, Roberta Bargoni, Linda Ferrari, ed Eva Amendola. All’incontro si decise di rilanciare alcune misure di assistenza ai profughi e l’inasprimento di quelle contro i socialisti, le spie e i tedeschi. Alle reazioni emotive, cariche di preoccupazione, si affiancarono le invettive di Teresa Labriola e di Maria Rygier che, con toni sempre più esasperati, denunciarono i nemici esterni e interni, cioè neutralisti, giolittiani, socialisti e bolscevichi, bollati come disfattisti e traditori.
Fin dall’inizio la presenza di Labriola nel Comitato femminile per l’intervento italiano si era caratterizzata per la radicalità di alcune proposte. Tra queste, la costruzione di un’internazionale femminile antitedesca aperta alle donne delle nazioni alleate. Successivamente la filosofa si espresse contro la Pro suffragio austriaca, che aveva tentato di ristabilire le relazioni tra le organizzazioni femministe e proposto di lavorare insieme a una pace senza vinti né vincitori. Si fece poi eleggere negli organi direttivi del Comitato per l’intervento italiano dove, per l’influenza esercitata da Bice Sacchi, non riuscì a condizionare i rapporti di forza. Tuttavia, dopo aver constatato un’insanabile disparità di vedute, decise di abbandonare il gruppo. Proprio qualche giorno prima di Caporetto, Labriola aveva dato vita alla Lega patriottica femminile, un raggruppamento, come ebbe a dire, animato da un ristrettissimo ma motivato numero di interventiste in cui figuravano Maria Rygier, Ester Danesi Traversari, Maria Albertina Loschi e la futurista Eva Amendola.
L’obiettivo della formazione, scriveva Rygier nel documento costitutivo, era il rilancio del concetto di patria per fronteggiare la crisi del patriottismo a cui avevano contribuito le idee socialiste e pacifiste: «Il contagio dell’internazionalismo proletario, avvalorato dall’osservazione superficiale e unilaterale di certi fenomeni economici di carattere universale, si era propagato ad alcuni strati delle stesse classi dirigenti, le quali lo avevano assimilato sotto la forma meno violenta e meno catastrofica di un pacifismo dottrinario e sentimentale». L’amore per la patria si era rinnovato...