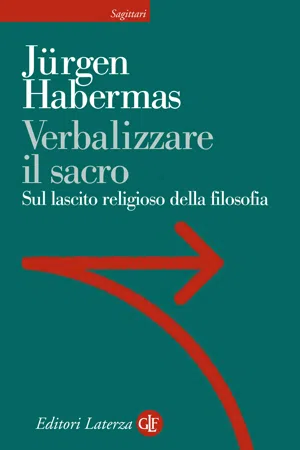V. Religione e pensiero post-metafisico.
Una replica
Craig Calhoun, Eduardo Mendieta e Jonathan VanAntwerpen hanno invitato un qualificato gruppo di colleghi a discutere gli ultimi miei lavori sul tema «pensiero post-metafisico e religione». Sono loro molto grato per questa iniziativa. I risultati di quel seminario mi sono stati di aiuto, in quanto le obbiezioni e le proposte dei colleghi mi hanno messo a confronto con pensieri nuovi, segnalato passi avventati, costretto a chiarimenti. Per contro, il fatto che quel seminario abbia preso spunto da un compleanno rotondo (i miei ottant’anni) ha portato con sé lo svantaggio di fare riferimento a pensieri che sono tuttora in fieri. Così i partecipanti hanno dovuto riferirsi a una posizione non ancora compiutamente elaborata. Per questo ricade ora solo su me il bisogno di chiarire meglio: cosa che vorrei cercare di fare nei limiti di una breve replica. Ringrazio pertanto tutti i colleghi: sia della pazienza e dell’attenzione con cui hanno letto i miei lavori sia, soprattutto, della loro disponibilità a criticare e intervenire nel dettaglio.
1. Gli stadi dell’evoluzione religiosa
Da circa vent’anni si ridiscute il rapporto tra religione e modernizzazione sociale. Movimenti e tradizioni religiose stanno rinascendo ovunque, ma non è questo l’oggetto primario del mio interesse. Vorrei piuttosto prenderne spunto per una riflessione più generale. José Casanova è tra i sociologi più intelligenti che hanno da tempo spinto a rivedere la tesi – universalmente imperante in sede accademica (e anche da me condivisa a suo tempo) – di un gioco «a somma zero» tra modernizzazione sociale e sopravvivenza delle comunità religiose. Le tesi e gli argomenti con cui Casanova risponde ai suoi critici mi piacciono molto. Non ho tuttavia la competenza necessaria per poter esprimere qualcosa di più che questa semplice impressione.
Quando parlo di società «post-secolare», io intendo descrivere un cambiamento di mentalità che sta avvenendo in società già ampiamente secolarizzate e sottratte all’influenza delle istituzioni ecclesiastiche. Queste società hanno ormai accettato di convivere con l’ininterrotta presenza di comunità religiose, così come hanno anche accettato di «fare i conti» con l’incidenza delle voci religiose sia nelle sfere pubbliche nazionali sia sulla scena politica globale. A Casanova non interessa tanto far vedere come stia indebolendosi, in queste società, il secolarismo antireligioso. Gli interessa di più confutare, sul piano empirico, la tesi stessa della secolarizzazione, in altri termini, contestare che le convinzioni e le pratiche religiose siano sostanzialmente espressione di un livello di coscienza storicamente superato. In questo senso divento anch’io oggetto delle sue critiche. Infatti, lui interpreta l’uso filosofico ch’io faccio del termine «post-metafisico» come il tentativo, da parte mia, di giustificare un pensiero secolare che – pur rifiutando ogni riduzione «naturalistica» dello spirito e della cultura dell’uomo – continui tuttavia a negare che la religione possa ancora essere vista come una figura contemporanea dello spirito. L’equivoco deriva dal fatto che Casanova non accetta l’idea di una generale evoluzione per stadi della coscienza – una evoluzione che finirebbe poi per produrre anche una coscienza secolaristica. Sennonché – nel ricostruire la genealogia con cui l’uomo sviluppa una comprensione del Sé e del mondo articolata in una pluralità di tradizioni culturali – io non intendo affatto sostenere che ogni processo di apprendimento, spinta cognitiva o stadio evolutivo, debba eo ipso farci scivolare in quella discutibile «filosofia della storia» cui si deve la svalutazione e il discredito del pensiero religioso.
Il futuro delle comunità religiose resta per me una questione aperta. E le estrapolazioni compiute da Casanova sotto l’etichetta «secolarizzazioni globali» le trovo più che convincenti. Secondo me, sia le interpretazioni religiose del Sé e del mondo rispettose dei moderni presupposti della vita e della conoscenza sia le varie correnti di pensiero post-metafisico tra loro concorrenti rientrano entrambe nei legittimi discorsi della modernità. Ciò che distingue le religioni dalla filosofia è la diversa modalità, e il diverso onere probatorio, del loro «tener-per-vero»; ma anche, e soprattutto, lo stabilizzante radicarsi della fede in pratiche cultuali di tipo comunitario. Al giorno d’oggi le figure del pensiero secolare e della coscienza religiosa si sono fortemente divaricate tra loro. Questo è ciò che mi spinge a indagare la genealogia che accomuna il pensiero post-metafisico alle religioni mondiali. Ancora oggi, infatti, la filosofia si differenzia dalle scienze oggettivanti per il suo riflessivo interrogarsi sulla comprensione del Sé e del mondo sviluppata – nella modernità – sia dall’umanità nel suo insieme sia dai singoli individui.
Vorrei solo accennare ai motivi per cui ritengo utile pensare l’evoluzione come uno sviluppo attraverso «stadi» delle immagini-di-mondo. Secondo Casanova, le condizioni contingenti ed empiriche della fede sono ragioni più che sufficienti a spiegare «cesure» storiche tipo la nascita delle religioni mondiali nell’età assiale oppure la nuova prospettiva del protestantesimo europeo descrittaci da Charles Taylor. Io invece non credo che l’evoluzione delle immagini-di-mondo religiose, nonché delle corrispondenti pratiche rituali, possa spiegarsi esclusivamente a partire dall’adattamento ai diversi contesti sociali. Si tratta di una evoluzione dovuta anche – vorrei quasi dire: soprattutto – a interni processi di apprendimento. Pur essendo scatenati da rivolgimenti sociali, questi processi di apprendimento cercano, in realtà, di rispondere a sfide d’ordine cognitivo. A partire dal 4000 avanti Cristo – nel quadro delle prime società statalmente organizzate – nacquero quelle «culture del testo scritto» (Schriftkulturen) che modificarono in profondità le tradizioni orali delle società tribali. L’organizzazione del culto venne allora statalizzata e asservita alla legittimazione del sovrano, laddove le narrazioni mitiche si differenziarono in sistemi politeistici centralizzati, rispecchianti le gerarchie politiche terrene. Epperò, nonostante le forti pressioni che tali cesure nella forma sociale esercitarono sulle tradizioni culturali del rito e del mito, i due millenni successivi non videro quasi nessuna sostanziale modifica nella struttura cognitiva delle immagini-di-mondo e nella forma magico-rituale del pensiero.
Soltanto intorno al 500 avanti Cristo, le immagini-di-mondo metafisiche e le religioni mondiali – sorte nel frattempo in Cina, nella valle dell’Indo, in Israele e nella Grecia classica – produssero uno sfondamento (Durchbruch) trascendente nella forma del monoteismo oppure della legalità cosmica. Questa spinta cognitiva (kognitiver Schub) – illustrata da Robert N. Bellah in una esauriente monografia – non è riducibile al semplice adattarsi delle credenze a un contesto sociale modificato. Piuttosto, le nuove immagini-di-mondo rappresentano risposte produttive a sfide di tipo cognitivo. Le vecchie potenze salvifiche e demoniache, un tempo intramondane, si «moralizzano» e si trasformano in un Dio (o in un «divino») che trascende la totalità del mondo. Questo Dio concilia e placa la coscienza morale di profeti, monaci, eremiti e sapienti, che – insoddisfatti dei capricci dei vecchi dèi – nelle società imperiali altamente stratificate avevano nel frattempo sviluppato nuove sensibilità, e più esigenti pretese, nel rapporto quotidiano con la sofferenza dell’esistente. Negli strati più colti si era infatti formata una consapevolezza riflessiva sui testi sacri, sommandosi a conoscenze tecniche e organizzative, nonché a saperi di natura matematica, astronomica, medica, filosofico-naturale. L’accumulo di tali saperi profani non poteva non entrare in conflitto con le spiegazione mitiche e le pratiche magiche. Queste dissonanze cognitive trovavano soluzione solo nelle prospettive concettuali – teologiche oppure cosmologiche – delle nuove immagini-di-mondo dell’età assiale. Alla sublimazione in forza trascendente delle potenze salvifiche e demoniache si aggiunsero anche approcci epistemici che rileggevano in termini etici i vecchi riti eliminando (più tardi: invertendo) il sacrificio.
José Casanova illustra molto bene lo sviluppo occidentale delle immagini-di-mondo a partire dalla simbiosi che, nell’impero romano, sposò il cristianesimo paolino alla filosofia greca. Mi sono sorpreso solo nel leggere la sua spiegazione del termine «secolare». Riferendosi al tardo impero – quando la maggioranza della popolazione sacrificava ancora sugli altari pagani, mentre la minoranza cristiana si rifiutava di obbedire ai riti di stato – Casanova descrive con queste parole la percezione reciproca delle due fedi: «La sacralità dei cristiani era profanità per i pagani e viceversa». A prescindere dal fatto che i cultori della filosofia greca (epicurei o stoici tipo Cicerone) non presero mai sul serio le credenze popolari, formando piuttosto con i neoplatonici un vero e proprio «terzo partito», la descrizione di Casanova suggerisce una sorta di «simmetria» tra cristiani e pagani che, in realtà, non è mai esistita. Nell’idea che i cristiani avevano del «paganesimo» non c’era soltanto il rifiuto dell’idolatria e del politeismo. C’era anche il rifiuto di quel pensiero concretistico che, nelle rappresentazioni religiose, continuava a stare dentro agli eventi intramondani. Nel partito avverso, i pagani devoti non riuscivano a capire come mai il dio dei giudei e dei cristiani non potesse essere paragonato a Giove, così come si faceva per Zeus o altre divinità dell’Oriente. Questa asimmetria prova ch’erano avvenute trasformazioni cognitive non riconducibili a un diverso condizionamento sociale delle credenze. Erano gli stessi cristiani a vantarsi di possedere, nei confronti dei pagani, la consapevolezza di un diverso «stadio» della coscienza. Può anche darsi che nel discutibile «senso di superiorità» ostentato dai secolaristi di oggi verso le credenze religiose si possa riscontrare qualcosa dell’atteggiamento dei primi cristiani verso il paganesimo. Ma per criticare questo atteggiamento non c’è bisogno di negare (o livellare) l’esistenza di «stadi» evolutivi nella coscienza religiosa.
Sulla linea occidentale dell’evoluzione religiosa, il passaggio alla modernità rappresenta una cesura analoga a quella dell’età assiale. Anche qui, la dinamica interna del sapere gioca un ruolo importante: chiesa e teologia mettono in moto processi presto destinati a sfuggire loro di mano – processi che finiscono per far saltare sia il diritto naturale cristiano sia la filosofia aristotelica della natura. Si pensi, per quanto riguarda la chiesa, alle conseguenze giuridiche seguite alla «rivoluzione papale» del diritto canonico, e, per quanto riguarda la teologia, alle conseguenze che la «rivoluzione nominalistica» produsse sul piano scientifico. Dall’interna dinamica morale (moralischer Eigensinn) del diritto moderno, così come dall’interna dinamica empirica delle scienze moderne, nascono forme profane di conoscenza che ripercuotono i loro effetti all’indietro, sulle loro origini teologiche e metafisiche. A prima vista potremmo pensare che questa autonomizzazione di morale, diritto e scienza, nonché questa secolarizzazione dello stato, rappresentino una vittoria della filosofia cont...