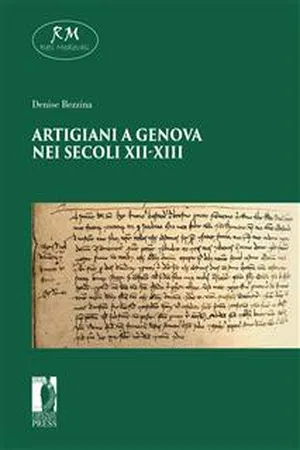![]()
Capitolo 1
Il sistema antroponimico del mondo dei mestieri
e la provenienza dei membri del ceto artigiano
Nei secoli qui in esame il cognomen di ciascun individuo fornisce informazioni sullo strato sociale di appartenenza, sulle relazioni parentali, sui luoghi di origine e di abitazione: l’antroponimia può dunque essere ritenuta un utile indicatore del ruolo dell’individuo nella società. Proprio l’esigenza di definire l’identità dei protagonisti di questo studio impone come punto di partenza l’indagine sui modelli di designazione antroponimica in uso presso il ceto artigiano.
Queste medesime motivazioni hanno dato slancio, a partire dagli anni Novanta del secolo scorso, a un’iniziativa volta a definire i sistemi antroponimici in uso nel contesto francese, un’iniziativa che è stata successivamente trasposta anche in ambito italiano. Tali studi da un lato chiariscono le basi metodologiche di partenza, dall’altro suggeriscono i nuclei problematici che ruotano attorno all’argomento. La mancanza di uniformità che caratterizza i sistemi di denominazione coevi spinge ad attuare, come punto di inizio, un’indagine quantitativa attraverso una classificazione delle forme antroponimiche ricorrenti presso le categorie di mestiere. Si procederà con una valutazione dei casi in cui avviene il processo di trasmissione di cognomina così da definire fino a che punto le designazioni che indicano i mestieri segnalano l’occupazione dell’individuo il cui cognomen presenta questa peculiarità. Infine, l’ultima parte del capitolo sarà dedicata alla definizione dell’elemento che risulta più evidente: la mobilità geografica legata al mondo dei mestieri.
1. Analisi quantitativa dei dati
Nonostante le ricerche condotte dal gruppo di studio francese abbiano fornito degli schemi utili al fine di classificare le forme antroponimiche, per catalogare in modo preciso i nominativi raccolti dalle imbreviature si è deciso di elaborare un modello che potesse esaurire tutte le tipologie di designazione in uso presso gli artigiani, cioè una griglia che consenta di leggere la tabella 1.1.
Nello studiare il sistema antroponimico degli artigiani vercellesi, Andrea Degrandi nota come «i documenti del XIII secolo non forniscono sempre la denominazione corrente degli uomini che ne sono attestatori». Oltre a quanto si è premesso in introduzione circa l’impossibilità di determinare la collocazione sociale di gran parte dei protagonisti dei rogiti contenuti in ogni cartolare – e i cartolari notarili sono sostanzialmente l’unica fonte di questo studio – è importante sottolineare come, scorrendo le liste degli artigiani schedati, i modi di registrare le persone talora varino. Ecco alcuni esempi. Nel 1248 un tale Binello è identificato sia come scutarius de Mediolano, sia come Binello scutarius: la certezza che si tratti della stessa persona viene dal fatto che i due atti, contratti lo stesso giorno, sono collegati e si devono al medesimo notaio. Un altro caso è rappresentato dai fratelli Ruffino e Aimerico, entrambi lanaioli che vengono identificati di volta in volta sia con il riferimento topografico della loro provenienza unito al loro mestiere, cioè de Laude lanerius, sia con il solo riferimento topografico (Lodi); Aimerico risulta anche come Aimericus de Rivotorbido lanerius (Rivotorbido indica il quartiere genovese di residenza di questo artigiano). Evidentemente, trattandosi entrambi di clienti assidui, il notaio non ritiene necessario registrare ogni volta anche il mestiere che esercitano. Questi casi rappresentano in realtà una fetta molto marginale della documentazione raccolta, perché non arrivano a superare l’1% dei nominativi; tuttavia, di fronte a tale incertezza, si è deciso di escludere tali istanze dal conteggio che è rappresentato nella tabella. In secondo luogo, si è potuta confermare l’appartenenza alle categorie di mestiere da parte degli individui che sono registrati usando la forma VI, unicamente quando la natura del contratto rende esplicito che il rogatario è un artigiano: per lo più attraverso contratti di lavoro e di apprendistato e contratti corporativi. Per citare qualche esempio: nel 1190, Resprandina e Inarda collocano il figlio di Resprandina, Guglielmino, in apprendistato presso Raimondo Moreto. Il fatto che il contratto preveda l’insegnamento di un mestiere al giovane rivela come Raimondo sia un artigiano nonostante il notaio non lo registri con una qualifica di mestiere. Nel 1253, invece, Alberto de Fontanellis de Placentina affida la figlia Sibillina come apprendista a Simone Camilla, specificando che quest’ultimo deve insegnare alla giovane a incidere l’oro: il mestiere di Simone – che non viene registrato dal notaio – è palese attraverso l’informazione fornita dall’atto. Nel 1280, ancora, Guglielmo di Busalla fornarius stipula un contratto di lavoro con Bonifacio di Costa, obbligandosi a lavorare nel forno di quest’ultimo, che evidentemente pratica anch’egli il mestiere di fornaio nonostante il notaio non lo registri come tale. Dato che la possibilità di evincere che individui il cui cognomen è privo di una designazione di mestiere siano in effetti artigiani è circoscritta a poche tipologie contrattuali, ne consegue che è stata identificata solo una piccola percentuale degli artigiani registrati con questa forma antroponimica; una percentuale che, dipendendo dalla disponibilità di questi contratti per ciascuna scansione cronologica, risulta del tutto casuale.
Seguendo i dati della tabella si nota come l’equilibrio delle percentuali fra le diverse forme di denominazione sembra assestarsi entro parametri più o meno stabili a partire dagli anni Venti del secolo XII. Sebbene non vi sia alcuna intenzione di ascrivere ai d...