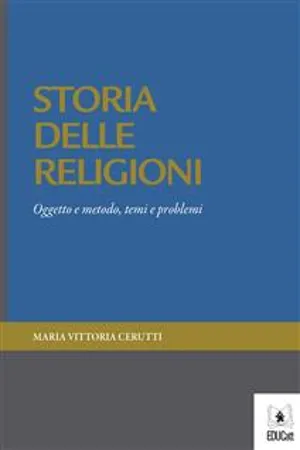![]()
Parte seconda
Per una tipologia storica
delle religioni
![]()
Capitolo Primo
Introduzione alle tipologie storiche
Dopo avere trattato di questioni metodologiche relative alla Storia delle religioni in quanto disciplina scientifica, entreremo nel merito della materia di questa disciplina, presentando le principali tipologie secondo le quali le religioni, considerate storicamente, possono essere classificate.
La disciplina storico-religiosa, dunque, comporta una ricerca storico-comparativa che muovendo da un concreto contesto culturale gradualmente si allarga verso ambienti contigui fino a quelli più lontani, nel tempo e nello spazio, venendo a cogliere tra i vari fenomeni suo oggetto di studio – quei fenomeni che con termine di significato analogico essa, come visto, chiama religiosi – difformità ma anche affinità, le quali permettono di raggruppare le religioni in categorie o tipi o – appunto – tipologie, sulla base di criteri diversi, ossia in base a specifiche e qualificate caratteristiche delle stesse.
In sostanza, il metodo storico-comparativo, sopra illustrato, permette allo studioso di costruire induttivamente e positivamente – ossia muovendo dall’esame concreto e puntuale dei singoli fatti documentati, inseriti nei rispettivi contesti e processi storici, e dalla successiva comparazione fra di essi, la quale consente di individuare elementi e aspetti affini insieme alle differenze – ‘tipologie’ storiche delle religioni. La formulazione di tipologie religiose permette di organizzare in categorie, duttili e non rigide, categorie costituite sull’esclusiva base della documentazione storica, la materia vasta e multiforme che è possibile ricondurre al parametro ‘religioso’.
Tali tipologie sono dunque costruite empiricamente, ossia attraverso l’esperienza dei diversi ambiti religiosi e nel rispetto della specificità storica di ciascuno. Contesti culturali assai diversi potranno, sulla base delle qualificate analogie riscontrate, essere situati sotto un’unica rubrica – appunto, la tipologia – senza che ciò significhi che la ricerca storica trascurerà le differenze anche notevoli che intervengono tra fenomeni tipologicamente affini, differenze che verranno invece adeguatamente sottolineate e che sarà proprio la comparazione tra fenomeni pur appartenenti al medesimo tipo a illuminare ancor più efficacemente.
V’è consenso sul fatto che per orientarsi nella complessità e diversità dei dati, c’è bisogno di schemi classificatori.[203]
Così, di fronte alla ricchezza e varietà delle forme religiose “si impone anzitutto il dovere di classificare. Dovere penoso, talora difficile, ma essenziale. Una classificazione non rigida delle religioni, delle esperienze religiose, ma insieme una classificazione severa che non permetta di confondere concetti, espressioni, idee, credenze, fedi che rimangono insieme simili e diverse. Una certa fenomenologia della religione, oggi, ci ha poco avvezzi a questa necessaria esigenza di classificazione, di distinzione, insieme tipologica e storica, delle diverse manifestazioni dell’esperienza religiosa. Una tale fenomenologia può avere alcuni vantaggi, perché può sottolineare nell’uomo, nell’umanità, concretamente e storicamente indagata, la presenza di quella che qualcuno senz’altro chiamerebbe un particolare facoltà, una particolare categoria, quella della religiosità; peraltro, questa medesima fenomenologia sotto altri profili è pericolosa. Pericolosa, dico, da un punto di vista di conoscenza scientifica, perché tutto assimilando e talora confondendo, rende meno facile, meno attento, meno intelligente lo sguardo, e forse dissimula, copre e nasconde quelle stesse realtà che l’uomo religioso e lo studioso, o, semplicemente, l’uomo umano avrebbero tutto l’interesse a conoscere: anche quelle realtà religiose che sono diverse, estranee alla sua propria tradizione religiosa. Eppure, c’è tutto l’interesse a conoscerle, tutto l’interesse a chiedersi a quali domande, a quali esigenze, queste diverse risposte religiose corrispondano”.[204] Si tratta dunque di abbandonare “i temi di una fenomenologia troppo facile, che nella sua genericità troppo fin dall’inizio volesse concludere e provare, ma non provando in realtà nulla di più di quanto è già noto – che cioè il fatto religioso è di estrema rilevanza storica e umana”.[205]
Orbene, le topologie storiche sono categorie in cui sono situabili i vari fenomeni sulla base di significative affinità che la ricerca storico-comparativa riscontra tra quelli. Esse identificano tipi di religioni che, pur rimanendo ciascuna unica e irripetibile nella sua individualità, offrono tra di loro qualificate somiglianze sotto specifici aspetti che pertengono la loro origine nella storia (religioni etniche e fondate), la loro diffusione e ‘vocazione’ (religioni nazionali, universali e complessi mitico-rituali cosmopolitici), i loro contenuti (fondamentalmente – ma non esclusivamente –: politeismi, monoteismi, monismi, dualismi).
La ricerca storico-comparativa è chiamata – anche se non sempre è in grado di farlo – a spiegare le affinità da essa riscontrate tra i fenomeni, ovvero a optare tra due opposte possibilità: da un lato, l’ipotesi genetica e diffusionistica, che ammette la possibilità di rapporti genetici o di influssi documentati tra fatti e processi storici e che comporta il diffusionismo, ovvero la diffusione storicamente provata di un rito, una credenza, una istituzione a partire da un centro originario. Dall’altro lato, l’ipotesi che comporta il policentrismo o parallelismo, ovvero lo sviluppo parallelo di riti, credenze, istituzioni, a partire da una pluralità di centri di origine e da una affinità storicamente valutabile di circostanze che ne hanno segnato l’origine, ne hanno offerto gli impulsi iniziali e ne hanno caratterizzato i rispettivi svolgimenti.[206]
Il primo caso è costituito, ad esempio, dalle affinità riscontrabili tra l’antico complesso già d’età faraonica relativo a Iside e Osiride e i tardi complessi mitico-rituali di tipo misterico relativi a queste stesse entità divine, come pure dalle affinità riscontrabili tra i diversi culti di mistero d’età ellenistico-romana diffusi nelle terre dell’Impero.
Sembra invece, il secondo, il caso – ad esempio – dei politeismi, tipiche manifestazioni religiose delle alte culture del mondo antico, sorti – verisimilmente in maniera indipendente, almeno taluni di essi – in circostanze analoghe, appunto quelle costituite dalle stesse alte culture, come risposta a stimoli ed esigenze storiche analoghi.
Le tipologie non sono aprioristiche classificazioni imposte alla storia ma sono il frutto, parziale e provvisorio, della ricerca storico-comparativa e lo strumento per un approfondimento della ricerca stessa. Come non si tratta di ‘tipi ideali’, previamente stabiliti, o modelli normativi, ma di tipi storici, appunto, induttivamente costruiti, così non si tratta neppure di classificazioni fini a se stesse, ma si tratta piuttosto di stimoli a un progresso della ricerca storica.
Se una forma di classificazione è indispensabile per muoversi nel mondo così ampio e variegato delle religioni, questo avviene non solo per una necessità pratica di sistematizzazione, ma anche perché identificare e circoscrivere aspetti peculiari analoghi tra diversi quadri religiosi permette di comprendere meglio i loro rapporti, le eventuali connessioni sul piano storico, le possibilità di influsso reciproco.
Inoltre, anche sotto un ulteriore aspetto la tipologia favorisce la comprensione storica. Infatti, la comparazione tra le formazioni appartenenti a una medesima tipologia, ad esempio quella delle religioni fondate, conduce a cogliere meglio la specificità di una singola formazione religiosa in relazione alle altre della tipologia cui appartiene, ovvero il suo specifico in rapporto al criterio distintivo che comanda quella tipologia stessa. Nel caso addotto come esempio, quello delle religioni fondate, essa aiuterà a cogliere lo specifico di una formazione religiosa fondata rispetto alle altre affini,...