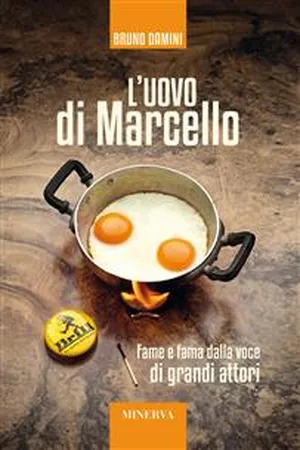![]()
APPENDICE
La fame in commedia e la tavola sul palcoscenico
Il mestiere più antico del mondo è quello dell’attore, contrariamente a quanto sostengono i nostalgici del boudoir. Alle remote origini del teatro, nell’esaltazione dei riti dionisiaci, l’hypocrités, con sacralità sacerdotale, intermediava con la divinità per i partecipanti al rito (spettatori attivamente coinvolti). All’apice delle civiltà greca e romana l’attore godeva di uno status di privilegio, ma da allora sarebbero seguiti secoli di fame e di vita grama come un malaugurio, fra scomuniche delle autorità religiose e persecuzioni di quelle civili in una lunga decadenza che ridurrà i teatranti alla stregua di esseri inferiori dediti a un’attività abietta (i guitti venivano seppelliti in terra sconsacrata, le attrici considerate alla stregua di prostitute), sempre assillati dalla fame e dai disagi esistenziali di un mestiere precario che, in alcune fortunate occasioni, poteva godere degli avanzi delle tavole di corte, ma frequentemente ricadeva in penurie quaresimali. Fino a tutto l’Ottocento infatti, nei quaranta giorni che seguivano il Carnevale, interdetti alle rappresentazioni, le compagnie si scioglievano e lo spettro della fame si ingigantiva tanto che a esorcizzarlo ancor oggi sopravvive la superstizione che bandisce il viola quaresimale in teatro.
Il plurisecolare cammino dell’attore è dunque legato indissolubilmente, così come la storia stessa del teatro, al “doppio” spettrale del cibo e della tavola: la fame. Anche le due più famose maschere della commedia dell’arte, Arlecchino e Pulcinella, erano affratellate da quel comune nemico che trovava rimedio solo in un’utopistica abbondanza, nell’apologia virtuale dell’abbuffata, nel nutrirsi di iperboli, nello sberleffo – almeno sul palcoscenico – a una cultura che, a dispetto delle carestie imperanti, aveva classificato la gola fra i sette peccati capitali.
Goldoni al suo Arlecchino fa dire: «Ho servido in tavola do padroni e un non ha savudo de l’altro. Ma se ho servido per do, adess voio andar a magnar per quattro».
È direttamente dalla commedia dell’arte che Dario Fo eleva il personaggio dello Zanni (un Gianni veneto dal fare contadinesco) al rango di maschera grazie alla sua straordinaria mimica facciale. Lo Zanni protagonista della farsa della mosca in Mistero buffo è un poveraccio che, preso da una fame orba, si addormenta e sogna di mangiare ogni ben di Dio tra pentoloni di polenta, cinghiale e verdure poi, non ancora sazio, s’infila una mano in gola e inizia ad estrarre le budella per mangiarsele, poi passa a mangiare parti del suo stesso corpo, lasciando solo la bocca a masticare. Si sveglia e s’accorge che quell’abbondanza era solo un sogno, allora piange e si dispera poi, sempre in preda ai morsi della fame, avverte il ronzio di un moscone, lo afferra con gesto disperato e con le dita dell’altra mano gli strappa una zampa e se la mangia decantandola come si trattasse di una coscia di pollo. Strappa le ali e se le mangia poi si mette in bocca il resto masticandolo lentamente e mugolando di piacere, come se masticasse una delizia.
Fame, cibo e teatro, corteggiandosi a vicenda, si sono spesso occupati reciproci spazi. Attraverso i secoli, tanto la fame quanto la cucina si ripresentano in palcoscenico in drammi e commedie, assumendo la valenza di dramatis personæ, con il peso drammaturgico che hanno i veri personaggi.
Grande cantore della miseria e della fame del mondo contadino, il cinquecentesco Angelo Beolco detto Ruzante, nella sua commedia Bilòra dà voce a un protagonista così male in arnese da vaneggiare di andare a impietosire la moglie fedifraga che gli ha preferito le molli agiatezze di un vecchio cicisbeo:
O canchero! […] Muoio di fame, e non ho pane, e non ho neanche denari per comprarne. Almeno sapessi dove lei sta, e dove lui l’ha menata… Che la pregherei pur tanto che mi darebbe un pezzo di pane.
All’epoca della commedia dell’arte gli spettatori partecipavano delle vicende rappresentate senz’interrompere le loro attività, incluse quelle conviviali. Nel teatro elisabettiano il popolo in piedi e i nobili accomodati direttamente sul palcoscenico assistevano alla rappresentazione delle opere di Shakespeare, o di Ben Jonson, mangiando e conversando, cambiando di posto e intervenendo con commenti ad alta voce sulla vicenda.
Nel suo La bisbetica domata Shakespeare fa adottare a Petruccio, gentiluomo di Verona, spasimante della bisbetica Caterina, l’arma della fame per piegare le intemperanze dell’amata:
Petruccio: La mia falcona è affamata ed ha il ventre vuoto vuoto; e fino a che essa non divenga maniera, non dev’essere impinzata, poiché allora non baderebbe più al suo logoro. Ma ho altri mezzi per ammansire questa selvaggia, per far che torni e conosca il richiamo del suo strozziere: tenerla desta, cioè, come si tengon desti quei falchi che svolazzano e batton l’ali e non vogliono mai ubbidire. Cibo non ne ha mangiato e non ne mangia per oggi… così piegherò il suo strambo o ostinato umore.
Caterina: Più egli mi fa soffrire e più dà fuori il suo dispetto. E che? M’ha egli sposata per affamarmi? Quando gli accattoni vengono all’uscio di mio padre, si dà loro subito l’elemosina, se la chiedono: altrimenti trovano carità altrove. Ma io che non ho mai appreso a supplicare, e non ho avuto mai bisogno di supplicare, sono morta di fame ed ho il capogiro per l’insonnia… E quel che mi fa stizza più di tutte queste privazioni è che egli fa questo sotto nome di perfetto amore.
Goldoni di converso ne La locandiera fa mettere in campo a Mirandolina tutte le sue arti culinarie per fare breccia nel cuore del misogino Cavaliere di Ripafratta:
Mirandolina: Mi piace l’arrosto, e del fumo non so che farne… E questo signor Cavaliere, rustico come un orso, mi tratta sì bruscamente? Questi è il primo forestiere capitato alla mia locanda, il quale non abbia avuto piacere di trattare con me. Non dico che tutti in un salto s’abbiano a innamorare: ma disprezzarmi così? È una cosa che mi muove la bile terribilmente.
Ci pensa poi Bertolt Brecht a riportare la fame in scena. Prendiamo ad esempio Madre Courage e i suoi figli con le dispute fra il cuoco dell’esercito svedese e la stessa Madre Courage:
Madre courage: Ne ho visti di quelli che per la fame arrivano a scavar radici e che si leccano le dita dopo aver mangiato una cintura lessa…
Cuoco: Non ho più voglia di fare il cuoco per quelli là. Mi tocca fargli da cucina con le radici delle piante e il cuoio per le scarpe, e poi, quando la zuppa è calda, me la buttano in faccia. Oggi, quella del cuoco è una vita da cani. Meglio fare il soldato: ma già, ora c’è la pace.
In Molière si passa dalla dispensa rarefatta de L’avaro alle fantasiose iperboli gastronomiche de Il borghese gentiluomo:
Dorando: [...] un pane cotto sull’orlo del forno e dalla punta dorata, con la sua bella crosta uniforme che crocchia dolcemente sotto i denti; d’un vino dal succo vellutato, irrobustito da un agretto che non si fa troppo sentire; d’un quarto di montone profumato di prezzemolo; d’una lombata di vitello lunga così, bianca, delicata, che sotto i denti è una vera pasta d...