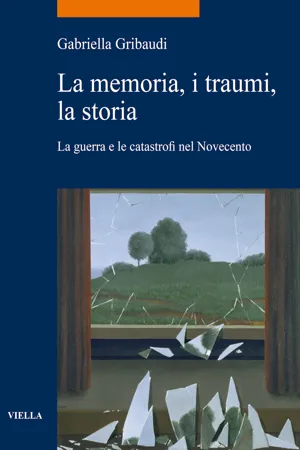![]()
1. I percorsi della memoria e dell’oblio
1. Memoria, memorie
In questi ultimi anni si è assistito a un vero e proprio boom degli studi sulla memoria. Un numero sterminato di articoli, libri, siti incentrati sul tema occupano lo spazio globale dell’universo letterario e del mondo virtuale.
In realtà la memoria gioca un ruolo cruciale già nell’Ottocento con l’ascesa delle nazioni e dei nazionalismi: la costruzione degli stati-nazione è intimamente legata alla formazione di una memoria nazionale che modelli l’identità del paese. In questo caso la memoria è costruzione istituzionale e si oggettiva in simboli, monumenti, celebrazioni che servono a ricordare e proporre eventi, personaggi, luoghi significativi che costituiranno o andranno a rafforzare la «comunità immaginata» della nazione.
Il memory boom della fine del Novecento è invece legato a due fenomeni apparentemente contraddittori. Da un canto sono venute meno quelle identità nazionali e quei nazionalismi che avevano caratterizzato il lungo Ottocento e i primi cinquant’anni del Novecento con i due conflitti mondiali, e con loro hanno perso significato le costruzioni mnemoniche che ne avevano accompagnato la formazione. Nello stesso tempo, con il crollo del mondo sovietico sono andate in crisi le macro-narrazioni e le ideologie che hanno dominato gli anni della Guerra fredda: memorie binarie emerse dalla rappresentazione della seconda guerra mondiale, secondo un’interpretazione in bianco e nero del conflitto, «un set familiare di convenzioni morali: dio versus diavolo; antifascisti contro fascisti; resistenti contro collaboratori». Come vedremo le esperienze delle popolazioni contrastavano profondamente con queste interpretazioni dicotomiche: i liberatori si erano spesso comportati da occupanti brutali, vittime e sofferenza avevano caratterizzato tutti i fronti e tutte le società, contraddizioni e conflitti avevano attraversato le società stesse (guerre civili, conflitti di genere…). Con la caduta dell’universo comunista e delle logiche di schieramento che confermavano le dicotomie, hanno potuto emergere le memorie delle vittime e dei traumi da loro subiti. Chi non aveva avuto fino ad allora il riconoscimento della sua sofferenza lo richiede, a volte lo pretende. In questo senso i processi di rammemorazione sono spesso legati alla richiesta di «rispetto, attenzione, legittimazione» della sofferenza subita.
Si generano conflitti di memorie, contese fra vittime. Possono emergere le vittime di violenze fino a quel momento oscurate. Ma emergono anche quelle che Olick definisce «politiche del rimorso» (politics of regret) che hanno ad esempio caratterizzato la Germania. Collassa la struttura binaria delle culture occidentali e orientali della memoria. Le popolazioni dell’Europa orientale liberate dall’Armata rossa possono finalmente narrare le violenze subite durante la Seconda guerra mondiale contestando la categoria stessa di “liberazione”.
Dai monumenti la memoria pubblica si trasferisce nei memoriali si lega all’esperienza dei soggetti, anche quando serve a rievocare un evento collettivo: sono i nomi, le fotografie delle vittime, le storie individuali a costituire la trama delle celebrazioni, dei musei, delle opere architettoniche che rimandano a eventi storici cruciali. Il memoriale del Vietnam, i memoriali dell’Olocausto, gli archivi multimediali che raccolgono le testimonianze.
D’altro canto, nello sgretolarsi del mondo irrigidito dalla Guerra fredda si propongono, spesso con grande violenza, nuovi nazionalismi che pretendono di rappresentare un luogo rifacendosi a una lunga memoria. La Serbia di MiloŠević per rivendicare il territorio del Kosovo si rifaceva a una battaglia del 1389, la battaglia della piana dei Merli, in cui i serbi si scontrarono con l’esercito ottomano: la piana era stata bagnata dal loro sangue di cristiani per difendere l’Europa dall’avanzata dei musulmani e apparteneva per questo alla loro terra.
Nella Russia post-sovietica, dopo una prima fase che seguiva la perestrojka e la rivoluzione del 1989, si è scoperto che la contro-memoria non era affatto condivisa. Le riflessioni critiche sulla storia molto presto passarono di moda e divennero addirittura divisive. Svetlana Aleksievič ha mostrato attraverso le narrazioni di donne e uomini cresciuti e vissuti nell’universo sovietico tutte le contraddizioni, i drammi interiori, il disorientamento di una generazione improvvisamente catapultata in un altro mondo. Emergevano poi i conflitti rimossi tra gruppi etnici e nazionalità che vivevano nello spazio sovietico. Come ha scritto Tony Judt «c’era troppa memoria, troppi passati che le persone possono utilizzare, di solito come un’arma contro il passato di qualcun altro». I conflitti fra azeri e armeni, fra uzbechi e kazachi, quelli fra ucraini e russi che si ripropongono drammaticamente ancora oggi si nutrono di antiche memorie, memorie di violenze, memorie di spazi contesi da tempo immemorabile. Casi simili si verificano nel mondo post-coloniale: la violenza è stata alla base della costituzione degli stati, la memoria della violenza si rinnova e anticipa le violenze future in un percorso di esclusione o vittimizzazione.
Il conflitto israelo-palestinese si alimenta anche nella contesa sulle rovine archeologiche e sul loro significato: appartengono alla Bibbia o al Corano, alla memoria ebraica o alla memoria musulmana-palestinese? A chi appartiene simbolicamente la tomba di Abramo? Quella che per gli ebrei è la Me’arat Ha-Machpela (la grotta di Machpela) mentre per i musulmani è l’al-Masjid al-Ibrāhīmī (la moschea di Abramo)? Il monte che sorge al centro di Gerusalemme è quello su cui Abramo stava per compiere il sacrificio del figlio Isacco, quello stesso su cui sarebbe sorto il tempio sacro che conservava l’arca dell’Alleanza con le tavole della legge? Oppure è il monte da cui Maometto salì al cielo e su cui è sorta la moschea di al-Aqṣā? Sullo stesso luogo si fondano due miti opposti delle origini entrambi al servizio di una battaglia ormai secolare. Si tratta di un tipico conflitto di memorie sostenuto da due nazionalismi che si contendono la stessa terra.
Ma proprio il caso israeliano può illustrare come percorsi diversi si intreccino. Israele costruisce una memoria ebraica che si identifica con il territorio, i suoi manufatti e i suoi luoghi simbolici, ma allo stesso tempo raccoglie le memorie individuali dei sopravvissuti alla Shoah, pianta gli alberi dei giusti che sono sempre e solo individui. Le due dimensioni convivono con finalità diverse.
La storia non avanza mai secondo un percorso unilin...