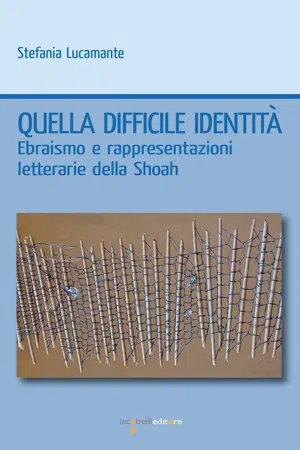Capitolo 1
Rappresentare/analizzare la Shoah oggi:
un difficile percorso di genere
All’inizio del ventunesimo secolo, la Shoah, o l’Olocausto secondo il termine più generalmente accettato1, si configura ormai come un’immensa costruzione culturale, spesso strumentalizzata, coercizzata, mediatizzata, e per la quale, quasi a testimoniare la difficoltà della sua eventuale elaborazione, si ripropongono con periodici intervalli nuovi trattamenti teorici e critici. In tempi recenti si parla spesso ormai di “sovrabbondanza” della memoria ebraica della Shoah, di eventuali “reazioni di rigetto”2, di “assuefazione”3 a commemorazioni quali persino la Giornata della Memoria4, celebrazione istituita dalla Repubblica italiana con la legge n. 211 del 20 luglio 2000. Si commenta sulla vastità del corpus bibliografico sulla Shoah, un corpus che «tende ad avere, anche in Italia, caratteri ripetitivi, oltre che scolastici, in rapporto a quella sgradevole banalizzazione sociale, spettacolarizzazione e appiattimento didattico del tema della Shoah su cui hanno puntato fra gli altri il dito, e il secondo in malo modo, Broszat (in Höss) e Finkelstein»5.
Si trovano a convivere paradossalmente due elementi: da un lato la paura della “ritualizzazione” – rappresentata dalle critiche mosse agli eventi sterili e ormai troppo reiterati che vengono organizzati in occasione della Giornata della Memoria – insieme a quella della musealizzazione della Shoah, mentre dall’altro sussiste la mancanza di un’effettiva conoscenza dei fatti da parte della collettività. Ancor prima di aver acquisito tale conoscenza, i singoli individui avanzano, allora, ragioni di stanchezza morale nei confronti di cose che si pensa di sapere, che si pensa di conoscere sin troppo. Costoro manifestano in fondo, il timore che questa memoria afflittiva distolga l’interesse, anche per un attimo, dai quotidiani problemi legati al consumismo e alla corsa al pursuit of happiness, quella ricerca della felicità a cui tutti hanno diritto come decreta, per esempio, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo statunitense, e che il sociologo Zygmunt Bauman ci ammonisce, invece, a non ricercare6.
Il problema, forse, non risiede soltanto nella necessità di una migliore conoscenza dei fatti, ma anche nel palesamento del processo di dis-umanizzazione degli esseri (e per di più italiani), della differenza politicizzata. Lo smascheramento di una finzione pronominale che contrappone il noi a voi. Il diverso di cui è emblematica, in Italia, la figura dei vicini di pianerottolo delle narratrici dei romanzi di Rosetta Loy. Questi diversi, ricordati comediversi proprio da quel pronome noi indicante la maggioranza silenziosa degli italiani cattolici in La parola ebreo e in altri romanzi di Loy in cui l’Italia delle leggi razziali e delle deportazioni si mantiene inalterata quale sfondo principale per le vicende dei personaggi, esigono l’atto del fare memoria. Come sostiene David Bidussa,
Perché un evento acquisti il carattere di significato nazionale per una comunità occorre che si costruisca la consapevolezza di un lutto e dunque di un vuoto, ovvero di una cosa che segni pubblicamente un prima e un dopo. In quel vuoto si costruisce una memoria pubblica.7
Nonostante, come scrive Michele Sarfatti, il termine Shoah adesso designi una «intera vicenda storica»8 alla stregua dei vari termini che hanno contraddistinto momenti di rilievo per la storia del paese, come quelli di Rinascimento e Risorgimento, la memoria pubblica stenta a configurarne la costruzione su un piano collettivo, in parte per via dell’effettiva mancanza di conoscenza da parte di molti italiani di questo lutto, di questo vuoto che, in cambio, produce indifferenza, come anche per via delle narrazioni estremamente selettive che vengono rese disponibili. Come per il vuoto creato dalla mancanza di un’effettiva storia di un’altra Italia, rappresentata dalla storia dell’emigrazione di tanti connazionali verso altri continenti in cerca di fortuna dopo l’unificazione del paese, anche in questo caso il sapere comune di molti fra coloro i quali hanno frequentato la scuola dell’obbligo prima dell’istituzione della Giornata della Memoria mostra gravi lacune, lacune di cui sono emblematiche quelle rivelate dalla Giovanna protagonista del film del 2003 La finestra di fronte. L’itinerario tematico costruito per gli spettatori dalla memoria lunga e dolorosa di Davide, il pasticciere ebreo che ha perso il proprio amato Simone ad Auschwitz e continua a cercare il viso e il sorriso del proprio amore nei luoghi dei loro incontri, va interpretato e rivisto mediante un elemento fondante: la sua storia verrà finalmente ascoltata da Giovanna, una donna semplice che non conosce la storia delle persecuzioni accadute anche vicino a dove lei vive oggi con la sua famiglia. Come in Una giornata particolare di Ettore Scola un omosessuale, Davide, trasmette la sofferenza della propria discriminazione a Giovanna, esponente di un altro gruppo discriminato, le donne di umili condizioni. La non-conoscenza da parte di Giovanna di una storia collettiva e pure a noi assai prossima, come quella della deportazione degli ebrei romani del 16 ottobre 1943, ci porta a riflettere proprio su due livelli di storia, quella tramandata e quella studiata. Se la giovane donna conosce il motivo del tremendo tatuaggio che scorge sul braccio di Davide mentre lo cambia in bagno in una coinvolgente scena di istintivo accudimento materno, lo conosce soltanto perché, lei come tanti, ha pur sentito qualche volta parlare in modo astratto e traslato dell’evento in generale, di un mondo che pensa non appartenerle. Tutti gli italiani hanno pur visto qualche sceneggiato televisivo ambientato sullo sfondo della Shoah, oppure apprezzato La lista di Schindler di Steven Spielberg in prima serata9. ...