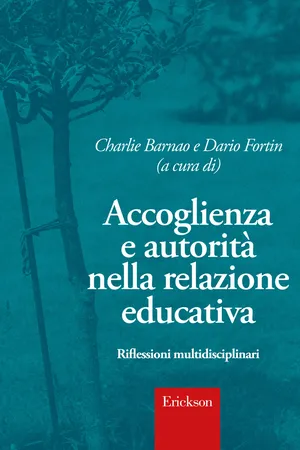
eBook - ePub
Accoglienza e autorità nella relazione educativa
Riflessioni multidisciplinari
- 304 pagine
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Accoglienza e autorità nella relazione educativa
Riflessioni multidisciplinari
Informazioni su questo libro
I temi della libertà e dell'autonomia in educazione hanno ormai messo in crisi il modello tradizionale legato all'autorità forte, lasciando tuttavia un vuoto non sufficientemente colmato dalle scienze dell'educazione. Il volume porta il proprio contributo in questo dibattito tentando una pista controcorrente rispetto alle tendenze frammentarie di questa nostra epoca, proponendo delle risposte più integrate e complete. Il tema della relazione educativa tra autoritarismo, permissivismo e autorevolezza è infatti affrontato nell'ambito di una riflessione multidisciplinare (sociologica, psicologica, filosofica, storica, antropologica, teologica, pedagogica e sociale), che punta a un recupero dell'unicità della persona e della relazione. La prima parte del volume raccoglie saggi e brevi scritti che ribadiscono la necessità di aprire l'educazione a una visione pluralista; la seconda presenta e interpreta esperienze concrete che possono aiutare genitori, insegnanti, studenti universitari e operatori sociali nel loro difficile ruolo di educatori.
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Accoglienza e autorità nella relazione educativa di Charlie Barnao,Dario Fortin in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Psicologia e Psicologia sociale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
PRIMA PARTE
Saggi
Capitolo primo
La relazione educativa rogersiana
Luisa Lorusso
Cercherò di illustrare con le mie parole, ma anche con molte citazioni tratte da vari libri di Carl Rogers, la teoria rogersiana dello sviluppo della personalità da un punto di vista psicologico e ne illustrerò il conseguente atteggiamento educativo utile per permettere che ogni individuo realizzi se stesso.
Carl Rogers ha iniziato a fare ipotesi sulla natura umana osservando la natura nei suoi eventi quotidiani e ha utilizzato tali osservazioni al fine di avvalorare la sua teoria dello sviluppo della personalità:
Ricordo che durante la mia adolescenza conservavamo la nostra provvista di patate dell’inverno in un recipiente posto sotto una piccola finestra, nel seminterrato. Le condizioni non erano favorevoli, tuttavia le patate germogliavano ugualmente — dei pallidi germogli biancastri — tanto diversi da quelli verdi e vigorosi che spuntavano quando le patate venivano piantate in terra a primavera. Ma questi tristi ed esili germogli si allungavano fino ad un metro per raggiungere la distante luce della finestra. Nella loro bizzarra e inutile crescita essi erano una specie di disperata espressione di quella tendenza direzionale […] a realizzare se stessi, non esaurivano la loro reale potenzialità ma, pur nelle più avverse condizioni, si sforzavano di farlo. La vita non cede mai, anche se non può fiorire. […] Durante il trattamento di clienti la cui vita è stata terribilmente rovinata […] spesso mi tornano in mente quei germogli di patate. Queste persone si sono sviluppate in condizioni così sfavorevoli che la loro vita sembra spesso anormale, distorta, addirittura poco umana […] esse si sforzano di muoversi verso la crescita e la trasformazione nell’unico modo che è loro possibile. I risultati possono sembrarci inutili o strani ma esse stanno veramente compiendo il disperato tentativo di diventare se stesse. È questa forte tendenza che viene posta alla base della terapia centrata sul cliente ed è da essa che tutto si è sviluppato. (Rogers, 1978, p. 15)
Rogers scrive di come l’osservazione di un’alga sbattuta dalle onde dell’oceano lo aveva condotto a riflettere sulla tenacia e la persistenza della vita, sulla capacità dell’essere vivente di resistere in un ambiente incredibilmente ostile.
Sembra incredibile che un’ora dopo l’altra, giorno e notte, per settimane e forse per anni, una pianta esile possa resistere a urti incessanti, e per tutto il tempo possa nutrirsi, affondare le proprie radici e riprodursi; cioè, mantenere e migliorare se stessa, mantenendo attivo il processo della sua crescita. (Rogers, 1978, pp. 209-210)
Da tali osservazioni trae la considerazione basilare per orientare il suo lavoro clinico e per formulare la sua teoria dello sviluppo della personalità.
La vita è un processo attivo e ogni organismo è teso ad assumere comportamenti tali da mantenere, migliorare e riprodurre se stesso. Sia che lo stimolo derivi dall’interno o dall’esterno, sia che l’ambiente sia favorevole o sfavorevole, questa tendenza è operante in ogni momento e testimonia la vita. Anche quando sono soddisfatti i suoi bisogni primari e l’omeostasi è raggiunta, l’organismo vivo è attivo e intento a qualcosa: a realizzare pienamente se stesso in modi individuali e creativi. (Rogers, 1978, p. 210)
Bisogno di considerazione positiva
Secondo Carl Rogers anche il neonato è costituzionalmente dotato di una tendenza organismica attualizzante, di riflessi fisiologici capaci di garantirgli la sopravvivenza. Egli infatti dorme pacificamente, ma si sveglia per il disagio derivante dal bisogno organismico di cibo. Al solo fine di soddisfare da sé questo bisogno, il neonato ruota il capo per afferrare e succhiare qualunque oggetto gli capiti vicino alle labbra; egli tuttavia non starà attaccato a lungo al succhiotto asciutto e vuoto, bensì si girerà per rifiutarlo e cercare altro. Se trova il seno morbido, succhia avidamente, sebbene sappia staccarsi da quella sorgente buona quando sente che il suo stomaco è sazio, sino a rigettare con facilità la piccola dose di latte in eccesso, così da raggiungere la situazione che gli dà pieno benessere.
Rogers descrive ciò che gli pare essere lo sviluppo psicologico del neonato:
Percepisce la sua esperienza come fosse la realtà: ha il suo specifico quadro di riferimento interno:
– il suo comportamento è finalizzato a soddisfare i suoi bisogni di attualizzazione così come li percepisce, nella sua realtà;
– valuta: dà un valore positivo alle esperienze che percepisce come favorevoli a preservare e arricchire il suo organismo, dà valore negativo a quelle contrarie;
– sa già comunicare: esprime benessere o malessere, gradimento o disapprovazione, richiesta o rifiuto;
– a seguito dell’interazione con l’ambiente differenzia le esperienze e crea la loro simbolizzazione nella coscienza
diventa dunque capace di avere coscienza di esistere e di formarsi una nozione dell’IO. (Rogers e Kinget, 1970, pp. 178-180)
– il suo comportamento è finalizzato a soddisfare i suoi bisogni di attualizzazione così come li percepisce, nella sua realtà;
– valuta: dà un valore positivo alle esperienze che percepisce come favorevoli a preservare e arricchire il suo organismo, dà valore negativo a quelle contrarie;
– sa già comunicare: esprime benessere o malessere, gradimento o disapprovazione, richiesta o rifiuto;
– a seguito dell’interazione con l’ambiente differenzia le esperienze e crea la loro simbolizzazione nella coscienza
diventa dunque capace di avere coscienza di esistere e di formarsi una nozione dell’IO. (Rogers e Kinget, 1970, pp. 178-180)
Anche il neonato così come le patate e le alghe che Carl Rogers osservava, da subito si muove, valuta, sceglie e comunica in modo utile alla sua vita, con assoluta libertà, mantenendo attivo il processo attualizzante della sua crescita.
Viene da porre una domanda cruciale: come mai la persona umana, che nasce saggia, da adulta spesso è nevrotica, insicura, infelice e in conflitto con se stessa o addirittura disfunzionale nel suo agire, disgregata, disadattata ed estraniata dalla propria esperienza organismica?
La spiegazione di Carl Rogers, elaborata nel corso di oltre dieci anni, dal 1959 al 1970, sostiene grossomodo che nel mondo animale, tra tutti i cuccioli, quello dell’uomo è il più dipendente dalle cure genitoriali. Senza l’accudimento di un adulto il neonato non potrebbe sopravvivere. Nonostante sappia che cosa gli è necessario per sopravvivere, quanto latte succhiare per nutrirsi a sufficienza, quanto sonno per rigenerarsi, quanto moto per sviluppare i muscoli e diventare così capace di autonomia, egli necessita comunque di un tramite. Già dalla nascita, la sua tendenza attualizzante lo rende capace di agire in modo tale da richiamare l’attenzione: piange, sorride e gorgheggia per accattivarsi le cure di chi gli sta vicino, mette in atto condotte per sciogliere ogni ritrosia e per ripagare di tanta fatica l’adulto che risponde al suo richiamo pressante.
Il neonato riesce a suscitare nelle figure genitoriali l’istinto a soddisfare i suoi bisogni e a prestare cura al suo corpo dipendente. Dunque, saggiamente, il neonato valuta come bisogno irrinunciabile per la sua sopravvivenza il garantirsi l’amore e la cura dei genitori che gli servono da tramite per soddisfare qualsiasi sua necessità: pur di essere amato dai genitori è disposto a tenerseli vicini delegando loro tutte le scelte che riguardano la sua vita, smettendo di autoregolarsi in base alla sua tendenza organismica e assumendo piuttosto i criteri dei genitori per valutare il proprio comportamento. Il neonato incrementa di giorno in giorno la sua capacità di dare considerazione pur di riceverne, così come il bambino.
Porto ad esempio la nipotina ospite di una nonna, alla quale per strada una passante offre qualche fragolina di bosco da assaggiare. Questa bimba di 4 anni osserva e annusa incuriosita le fragole così piccole e profumate, poi guarda la nonna, che le ha raccomandato tante volte di non accettare nulla dagli estranei, sente l’acquolina in bocca e, infine, quasi a termine di un’irrisolvibile battaglia interiore, chiede: «Nonna, a me piacciono le fragoline di bosco?».
Una simile richiesta testimonia, a mio avviso, che la bimba sta cercando di districarsi tra i tanti tentativi di compiacere la nonna, alla quale delega anche la più personale delle scelte, il proprio gusto, quasi a dire: «Nonna, tu per me sei importante al punto che ti lascio scegliere al mio posto, e considererò le tue scelte più valide delle mie!».
Nell’infanzia si arriva quindi, pur di mantenere su di sé l’amore delle persone significative e accudenti, a delegare ad esse la propria innata capacità di valutazione organismica, perdendola così poco alla volta, per adottare come propri i valori genitoriali.
Così succede anche a quel bimbo la cui madre prima di una gita in montagna prova gli scarponcini del fratello maggiore per vedere se ora vanno bene anche a lui. «Ti fanno male? Perché se ti fanno male, allora purtroppo niente gita». Dopo il timido e incerto: «No, non mi fanno male» del piccolo, la madre si precipita ad aggiungere: «Bada, domani non ti lamentare, altrimenti mi arrabbio e ti lascio per strada».
Come può un bambino piccolo dare ascolto ai suoi piedini se questo significa far arrabbiare la mamma e rischiare l’abbandono?
Altro esempio è di una mia cliente che non sa fare scelte, nemmeno le minori, nemmeno le più banali: nel corso della terapia mi raccontò di quando, da piccola, il suo papà, che faceva il commerciante, l’aveva portata al bar dicendole: «Ti porto con me a incontrare un mio cliente ma non farmi spendere tanti soldi! Quando ti chiederò: “Che gelato vuoi?” mi dovrai rispondere che vuoi quello più piccolo». E quando nel bar, assieme al suo cliente, il papà serio e gentile la guardò negli occhi chiedendole che gelato voleva, lei, senza ricordarsi che si trattava della recita concordata poche decine di minuti prima, scelse il gelato grande che le sarebbe davvero piaciuto avere e non quello pattuito. Il cambiamento dello sguardo del papà, la disapprovazione totale che le fu espressa, le sono impressi dentro e ancora oggi la rendono incapace di esprimere i propri desideri.
Il bambino, di fronte ai genitori che assumono la posizione di giudici, non riesce liberamente a esprimere e ad affermare le sue profonde necessità; e quegli stessi adulti non sanno prendere davvero in considerazione i bisogni del figlio, anche se chiaramente espressi.
Nella teoria di Rogers si trovano descritte queste situazioni per dire come con la crescita e con il moltiplicarsi delle esperienze di non ascolto di sé, il bambino trasformi i valori genitoriali in costrutti, cioè in criteri valoriali che seguono il modello del suo mondo familiare, sociale e culturale per interpretare, leggere e valutare la sua realtà soggettiva.
I costrutti, non essendo parte del normale processo di valutazione del bambino, sono rigidi e statici. Il bambino tende a non prendere in considerazione il proprio processo di esperienza se lo trova in conflitto con tali costrutti ma, così facendo, si allontana dal modo di sentire proprio del suo organismo, operando perciò, una certa dissociazione di se stesso. (Rogers, 1978, pp. 221-233; Rogers, 1983, p. 307)
Pur di essere accudito, il cucciolo dell’uomo si adatta a ricevere considerazione positiva condizionata, cioè subordinata e vincolata al fatto di adeguarsi ai voleri e ai valori genitoriali, sociali e culturali.
Sarà cura dell’adulto fare in modo che le condizioni imposte dall’educazione siano sufficientemente morbide, tali per cui il piccolo possa comunque accedere alla sua esperienza organismica e si possa sentire considerato positivamente anche quando afferma se stesso. Solo così la piccola persona potrà procedere nella sua crescita, in modo psicologicamente sano.
In tale ottica, la stagione dell’adolescenza è quella meravigliosa occasione di crescita verso il divenire più pienamente congruente con la propria tendenza organismica a realizzare se stessi. L’adolescenza è il periodo in cui il bambino e la bambina, crescendo in statura, in possibilità di movimento e quindi di confronto con il mondo esterno alla famiglia, riescono anche a progredire in forza, autonomia e potere personale e possono dunque iniziare a ingaggiare la lotta per l’affermazione della loro identità, ovvero a gettar via i costrutti genitoriali sino ad allora assunti al posto dei propri valori.
L’adolescente esprime innanzitutto la ribellione, la determinazione a liberarsi dal passato, da ciò che ha ricevuto dagli altri; inizia il lavoro di revisione delle sue condotte, inizia a trasgredire, a rifiutare i valori imparati da piccola/o, a disobbedire, a fare di testa sua, a prendersi delle libertà. Può abbandonare i costrutti anche preziosi, ma costruiti da altri e quindi non del tutto adatti a soddisfare i suoi bisogni. Solo facendo dis-ordine troverà, oltre alla sua capacità di opporsi, anche una capacità positiva di diversificarsi e di scegliere con coraggio di riprendere a dare valore e attenzione a se stesso, per ritrovare la sua originaria saggezza.
Tuttavia tale riscoperta di sé, secondo la prospettiva rogersiana, potrà avvenire a patto che l’adolescente sia rispettato dal mondo familiare nella ricerca del senso personale del suo agire e sia libero di interpretarlo e di starci; non deve essere fermato in ciò da alcun giudizio di valore da parte delle persone alle quali sino a ora ha subordinato la propria tendenza organismica. Si tratta dunque di una lotta, un lavoro impegnativo che accompagnerà il ragazzo e la ragazza in tutta la crescita adolescenziale, sino a sfociare nella maturazione.
L’adolescente impiega parecchi anni a liberarsi dalla dipendenza infantile. Come osserva Rogers: «La libertà di essere se stessi è una libertà spaventosamente responsabile, e un individuo va incontro ad essa con timore, cautela e, all’inizio, persino con pochissima fiducia. Dirigersi da sé, responsabilmente, vuol dire scegliere e poi imparare dall’esperienza fatta» (1983, p. 142).
L’adolescente che inizia una certa scuola superiore solo per fare contenti i genitori andrà male, marinerà, faticherà e probabilmente sarà anche bocciato/a. Troverà motivazione e interesse solo quando riuscirà a fare sua la scelta di proseguire negli studi, sentendosi così artefice della sua carriera scolastica.
Secondo Carl Rogers l’epilogo sano del processo di maturazione consiste nel diventare sempre più capaci di ascoltare se stessi, di valu...
Indice dei contenuti
- L’autore
- Ringraziamenti
- Prefazione
- Introduzione
- Intervista a padre Livio Passalacqua
- PRIMA PARTE: Saggi
- SECONDA PARTE: Esperienze
- Conclusioni: Educatori autorevoli in ricerca del proprio stile educativo, oltre l’allarmismo