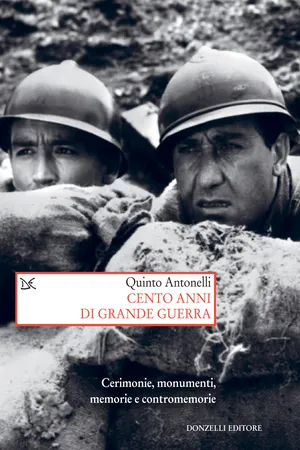
eBook - ePub
Cento anni di grande guerra
Cerimonie, monumenti, memorie e contromemorie
- Italian
- ePUB (disponibile su mobile)
- Disponibile su iOS e Android
eBook - ePub
Informazioni su questo libro
Cento anni sono trascorsi dalla fine della Grande guerra, cento anni durante i quali la memoria del primo conflitto mondiale si è radicata nella nostra identità. È entrata nel calendario civile con le «feste» del 24 maggio e del 4 novembre; ha segnato il volto delle città con monumenti grandi e piccoli; si è impressa nei nomi delle vie; ha trasformato il teatro delle battaglie in luogo di culto punteggiato da decine di sacrari; persino i resti di quel sistema di trincee, forti e caverne sono diventati mete per pellegrini e turisti. Gli autori di queste pratiche commemorative sono stati i più diversi: esponenti delle gerarchie militari e delle associazioni combattentistiche e d'arma, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti politici; e poi architetti, giornalisti, registi, insegnanti, redattori. Una memoria, tuttavia, troppo spesso dominata da un'unica voce solista, retorica e celebrativa, che glorifica la necessità e il valore della guerra, che osanna gli eroi e sovrasta le voci di chi a quella guerra non ha mai creduto: voci stridenti, indisciplinate, a cui è difficile prestare ascolto. È anche su questo controcanto che si sofferma l'analisi attenta e rigorosa di Quinto Antonelli, sfruttando appieno le armi della cultura «materiale». Dagli articoli ai monumenti, dai libri di testo alle lettere, dai pellegrinaggi alle mostre, dai film alle canzoni, ciò che affiora è una vera e propria memoria «polifonica». Pagina dopo pagina prende consistenza l'orrore che appartiene alla guerra, anche – e forse soprattutto – a quella che ricordiamo come la Grande guerra; tra gli acuti di chi ne declama le virtù si fa strada la voce di chi ne smaschera le false ragioni, di chi la mette a nudo e ne condanna la bestialità; mano a mano, sotto l'alone di gloria che circonda l'eroe emerge un'uniforme sporca e lacera, la divisa del soldato in guerra, e in guerra, conclude Antonelli, il soldato «è sempre qualcosa di meno di un uomo».
Domande frequenti
Sì, puoi annullare l'abbonamento in qualsiasi momento dalla sezione Abbonamento nelle impostazioni del tuo account sul sito web di Perlego. L'abbonamento rimarrà attivo fino alla fine del periodo di fatturazione in corso. Scopri come annullare l'abbonamento.
No, i libri non possono essere scaricati come file esterni, ad esempio in formato PDF, per essere utilizzati al di fuori di Perlego. Tuttavia, puoi scaricarli nell'app Perlego per leggerli offline su smartphone o tablet. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Perlego offre due piani: Essential e Complete
- Essential è l'ideale per studenti e professionisti che amano esplorare un'ampia gamma di argomenti. Accedi alla libreria Essential, che include oltre 800.000 titoli di comprovata qualità e bestseller in vari settori, tra cui business, crescita personale e discipline umanistiche. Include tempo di lettura illimitato e voce standard per la sintesi vocale.
- Complete: perfetto per studenti e ricercatori esperti che necessitano di un accesso completo e illimitato. Accedi a oltre 1,4 milioni di libri su centinaia di argomenti, inclusi titoli accademici e specialistici. Il piano Complete include anche funzionalità avanzate come la sintesi vocale premium e l'assistente di ricerca.
Perlego è un servizio di abbonamento a testi accademici, che ti permette di accedere a un'intera libreria online a un prezzo inferiore rispetto a quello che pagheresti per acquistare un singolo libro al mese. Con oltre 1 milione di testi suddivisi in più di 1.000 categorie, troverai sicuramente ciò che fa per te! Per maggiori informazioni, clicca qui.
Cerca l'icona Sintesi vocale nel prossimo libro che leggerai per verificare se è possibile riprodurre l'audio. Questo strumento permette di leggere il testo a voce alta, evidenziandolo man mano che la lettura procede. Puoi aumentare o diminuire la velocità della sintesi vocale, oppure sospendere la riproduzione. Per maggiori informazioni, clicca qui.
Sì! Puoi utilizzare l'app di Perlego su dispositivi iOS o Android per leggere quando e dove vuoi, anche offline. È perfetta per gli spostamenti quotidiani o quando sei in viaggio.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
I dispositivi con iOS 13 e Android 7 o versioni precedenti non sono supportati. Scopri di più su come utilizzare l'app.
Sì, puoi accedere a Cento anni di grande guerra di Quinto Antonelli in formato PDF e/o ePub, così come ad altri libri molto apprezzati nelle sezioni relative a Storia e Storia mondiale. Scopri oltre 1 milione di libri disponibili nel nostro catalogo.
Informazioni
Argomento
StoriaCategoria
Storia mondialeMemorie eroiche. Chiesa, scuola e regime nell’educazione nazionale degli italiani
I. Le vittorie di Dio
1. I cappellani militari e l’esercito «crociato».
Già nella primavera del 1915, su iniziativa del generale Luigi Cadorna, si provvide a introdurre nell’esercito la figura del cappellano militare, assegnato con il grado di ufficiale a ogni reggimento delle varie armi e dei vari corpi. Furono 2400 o forse, secondo altri calcoli, 2700 nel momento della massima efficienza. Si ebbe, in media, un cappellano ogni 3000 uomini1. Erano scelti tra il clero arruolato (composto da 24446 elementi tra chierici e sacerdoti), che in genere viveva come umiliante e poco consona alla dignità sacerdotale la condizione di soldato semplice. Al vescovo castrense, che per tutta la durata della guerra fu monsignor Angelo Bartolomasi, spettava la giurisdizione sui cappellani militari.
A tutti loro si chiedeva di alimentare nei soldati il «risveglio» religioso e, contemporaneamente, di sostenere il morale delle truppe, la coesione, la disciplina, lo spirito di sacrificio. Talvolta erano gli ufficiali superiori, con modi sbrigativi, a rimarcare questo loro ufficio2, ma, come possiamo leggere nelle relazioni che inviavano al vescovo di campo, i cappellani in genere rivendicavano con energia il contributo dato alla causa patriottica e il ruolo centrale avuto nel ravvivare nei soldati l’amor di patria sospingendoli al compimento del loro dovere3.
I cappellani svolgevano una propaganda intensa, quotidiana, minuta. Quali gli argomenti? La bandiera, il giuramento, la missione educativa dell’esercito, la storia d’Italia, la casa Savoia, le virtù del militare. Questi e altri temi disegnavano un corpus «dove la scuola del patriottismo e del dovere militare si ritrova mischiata ad un insegnamento di carattere morale. La giustificazione ed il sostegno ideologico della guerra coesistono con la preoccupazione per una specifica morale cattolica»4.
La messa festiva (la messa «al campo») e la relativa predicazione stavano al centro dell’attività pastorale dei cappellani, e anche queste diventavano occasioni per esortazioni di carattere morale e patriottico. Di solito erano tre i principali temi dell’omelia, che potevano variamente combinarsi con riferimenti ai testi evangelici: la necessità della fede e della pratica religiosa; la purezza dei costumi e la correttezza del linguaggio (particolarmente insistita era la battaglia contro il vizio della bestemmia e del turpiloquio); il sentimento del dovere verso la patria e quello dell’obbedienza come specifica virtù cristiana. Poco diversamente i temi potevano essere articolati su Dio, Patria e Famiglia.
Modelli di riferimenti erano le omelie e le lettere pastorali del vescovo castrense che insistevano sul tema della guerra come occasione di purificazione. Auspicava monsignor Bartolomasi che dal generoso sacrificio di milioni di italiani, «dai nuovi campi solcati dalle trincee, seminati di cadaveri, innaffiati da sudori e sangue abbia a sorgere, a formarsi, a temprarsi, un’Italia politicamente forte, socialmente compatta, moralmente pura, religiosamente serena come il suo cielo, bella come le opere ed istituzioni nelle quali fede, carità ed arte si diedero la mano e sono suo patrimonio, suo tesoro invidiato dalle nazioni tutte, sua gloria per cui essa sempre fu donna e maestra»5.
Monsignore Bartolomasi riprendeva le posizioni condivise da quasi tutta l’intellettualità cattolica italiana (dagli interventisti della Lega democratica cristiana ai cattolici moderati dell’Unione popolare, a gran parte dei vescovi) per cui la guerra, da flagello punitivo, diveniva «la prova del fuoco che avvia al riscatto religioso della società»: anzi, come scriveva l’arcivescovo di Rossano, la guerra si doveva intendere come «un sacramento di rigenerazione, un grande battesimo di sangue» che avrebbe cancellato le vecchie colpe6.
Almeno fino al principio del 1918, quando si venne organizzando il servizio P, l’opera dei cappellani militari nel campo della propaganda, dell’organizzazione del tempo libero e dell’assistenza al soldato si configurò come una vera e propria «supplenza cattolica»7. Si pensi all’articolatissima presenza delle Case del soldato, sorte per iniziativa di don Giovanni Minozzi, che si estendevano capillarmente reggimento dopo reggimento, dalle montagne del Cadore fino alla pianura veneta. Offrivano al soldato istruzione e svago, la scuola per gli analfabeti, sale di lettura, piccole biblioteche, la possibilità di ascoltare e di fare musica, e poi lotterie, giochi. Lo scopo era quello di curare il morale delle truppe in modo indiretto, con l’assistenza pratica. «Farli riposare poi, i combattenti, farli svagare bisognava – scriveva don Minozzi –, confortarli, rasserenarli, riconciliarli con la vita, di tra le lacerazioni cruente e le ingiustizie svergognate, distrarli come ragazzi ammusoniti e stanchi»8.
Al 15 maggio 1917 le Case del soldato, tra grandi e piccole, erano 96. Tutte frequentatissime, secondo don Minozzi, certo per il loro carattere fattivo, pragmatico, assistenziale. Ma al momento opportuno sapevano diventare anche luoghi privilegiati per conferenze e discorsi, come quelli che ordinariamente erano tenuti da ecclesiastici militari. Tra questi i più ricercati erano i padri Giovanni Semeria e Agostino Gemelli, assurti presso il Comando supremo. Ricercati, ascoltati con devozione e imitati dai cappellani ordinari. «Oggi abbiamo avuto il P. Agostino Gemelli, vestito da capitano, con guanti, speroni e non gli mancava neppure lo scudiscio – scriveva don Giovanni De Dominicis nel suo diario –. […] Ha parlato della patria e del sacrificio che in questo momento si deve compiere per essa: sacrificio che procede dall’amore. La patria si concretizza nel cimitero, nella famiglia, nell’arte nazionale. Dobbiamo difendere questo sacro patrimonio, e tutti riunire le genti di una patria sola dentro quei sacri confini che Dio stesso ha posto a ciascuna nazione. Noi rivendichiamo questi sacri confini, e per questo la nostra guerra è giusta e benedetta da Dio»9.
Padre Gemelli, ecclesiastico influente e ascoltato in Vaticano come presso il Comando supremo, fu anche all’origine della consacrazione dell’esercito italiano al sacro Cuore di Gesù, la più grande manifestazione collettiva di fede religiosa che si svolse sul fronte italo-austriaco. Venerdì 5 gennaio 1917 (primo venerdì dell’anno), circa due milioni di soldati si confessarono, si comunicarono e proclamarono il cuore di Gesù loro «Sovrano d’amore». L’atto di consacrazione invocava da Dio protezione e vittoria, era un rito di benedizione delle armi italiane: «Illumina, dirigi, benedici e conduci a vittoria il nostro Re, i nostri Generali, noi tutti, soldati d’Italia, rendi la nostra patria grande e cristiana, ridonaci alle nostre famiglie più forti e più buoni, regna sulla Nazione tutta e sui singoli cuori»10.
L’esercito della nazione diventava così un novello esercito «crociato» (provvisto di un simbolico cuore su bandierina tricolore); proponeva una «causa cattolica» per cui combattere, affermava una religione «nazionale», e già operava per la restaurazione cristiana della società11.
Nel dopoguerra furono in primo luogo gli ex cappellani militari a coltivare e a riproporre una narrazione religiosa della guerra, in tutti i luoghi e i momenti dedicati al ricordo, alle liturgie del 4 novembre, negli spazi sacri dei monumenti ai caduti, nelle adunate dei reduci e delle associazioni d’arma. Negli anni venti e trenta vennero affiancati da giornalisti, scrittori, intellettuali militanti, animatori dell’Azione cattolica, catechisti, maestri, tutti concordi nell’enfatizzare la piena, convinta, «eroica» partecipazione dei cattolici italiani alla Grande guerra.
2. Omelie ai piedi dei monumenti.
Nel periodo successivo alla smobilitazione gli ex cappellani rientrarono nei ranghi in ordine sparso. Alcuni tra i più nazionalisti, tra i più animosi (Reginaldo Giuliani, Edmondo De Amicis, Vittorio Genta, Giovanni Mazzoni, Luigi Pasa), seguirono Gabriele D’Annunzio a Fiume continuando una predicazione imperniata su una semantica che legava Eroismo, Patria, Sangue, Gloria, Sacrificio. Il domenicano Reginaldo Giuliani, che era stato cappellano delle fiamme nere, si spinse in una imbarazzante commistione simbolica a benedire solennemente il pugnale d’oro («arma santa») donato al comandante da un gruppo di donne fiumane, mentre D’Annunzio andava annunciando il nuovo «Sacramento del Ferro»12.
Ai sacerdoti rimasti nelle forze armate si chiese, per lo più, di affiancare i reparti impegnati nella ricerca dei caduti e nella tumulazione delle salme. Altri furono impiegati nelle «nuove province» nella reggenza di sedi vacanti. Tutti svolsero, nel contempo, una multiforme opera di mobilitazione ideologica. Don Felice Tallacchini, ad esempio, tenne in accordo con le autorità militari ben 280 conferenze nei presidi centro-settentrionali, su temi come la patria, il dovere, la disciplina, l’anarchia, il comunismo13.
Gran parte dei cappellani mobilitati rientrò nelle parrocchie di provenienza o negli ordini religiosi che aveva temporaneamente abbandonato e divenne, spesso, il punto di riferimento del reducismo locale. Gli stessi ex cappellani si iscrissero alle associazioni d’arma, in particolare all’Unione nazionale reduci di guerra (Unrg), nata in contrapposizione alla più nota Associazione nazionale combattenti (Anc)14.
Ma ciò che in ogni luogo si chiedeva loro era di essere l’anima, l’elemento vivificatore, delle cerimonie commemorative dei caduti e della vittoria. Cosicché anche i meno nazionalisti tra gli ex cappellani si fecero infaticabili custodi della memoria della guerra. Perfino Giovanni Minzoni, che verrà massacrato a colpi di mazza ferrata il 23 agosto 1923 da due sicari fascisti, andava fiero dei propri trascorsi bellici e delle decorazioni ricevute, e come parroco di Argenta non si sottraeva certo alle ricorrenze del calendario patriottico. Particolarmente solenne fu la celebrazione del 4 novembre 1921, in consonanza con le onoranze romane al Milite Ignoto. Per la circostanza approntò un’immaginetta devozionale e una dedica: «Oggi/ terzo anniversario/ della vittoria delle armi nostre/ Roma/ accoglie nel suo seno/ la spoglia ignota/ simbolo di una stirpe gloriosa/ Argenta con un sol cuore/ tributa/ all’oscuro eroe/ tutta la gloria/ dovuta ai morti/ per un’Italia/ più pura e più grande»15.
Ma, di fatto, che cosa raccontavano questi sacerdoti durante le cerimonie commemorative? Qual era il senso delle loro omelie? Quale visione della guerra passava al popolo dei reduci riuniti intorno al monumento ai caduti o alla bandiera del proprio reggimento?
Il caso di don Primo Mazzolari, che a differe...
Indice dei contenuti
- Copertina
- Frontespizio
- Copyright
- Indice
- Cento anni di Grande guerra
- Premessa
- Parte prima. Memorie in conflitto. Socialisti, reduci e fascisti nel primo dopoguerra
- Parte seconda. Memorie «redente». Trento, Bolzano, Trieste e il culto degli «eroi martiri»
- Parte terza. Memorie eroiche. Chiesa, scuola e regime nell’educazione nazionale degli italiani
- Parte quarta. Memorie nazionali. Il patriottismo competitivo di cattolici e comunisti nell’epoca della guerra fredda
- Parte quinta. Memorie del dissenso. Pacifismo e nuova storiografia negli anni sessanta
- Parte sesta. Memorie soggettive. Tradizioni estenuate e ricerche dal basso
- Epilogo. Dove si cerca di riannodare qualche filo