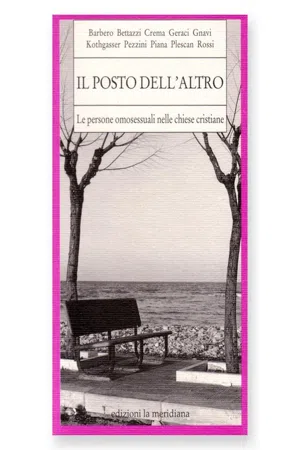![]() PARTE SECONDA: TESTIMONIANZE
PARTE SECONDA: TESTIMONIANZE![]()
Partire da una storia
Sono nato nel 1959 e sono cresciuto in un piccolo paese della diocesi di Milano dove, fin dalla prima adolescenza, ho partecipato attivamente alla vita ecclesiale: ho animato l’oratorio maschile per diversi anni; ho incontrato alcune esperienze come Comunione e liberazione e il Movimento dei focolari che, in quei primi anni Settanta, non avevano ancora concluso, all’interno della Chiesa, quel percorso di legittimazione che ora si è compiuto; andavo regolarmente a Messa e, spesso, la animavo suonando l’organo o assistendo il celebrante e facevo volontariato in una casa famiglia per handicappati. Probabilmente sapevo fin da allora di essere omosessuale, ma, un po’ per la vergogna, un po’ perché convinto di potermi controllare senza problemi, non ne avevo mai parlato con nessuno, covando probabilmente dentro di me la speranza che si trattasse di una condizione transitoria.
Nell’autunno del 1978, dopo essere approdato all’Università Cattolica di Milano, ho iniziato a frequentare il Seminario diocesano di Saronno, dove speravo di entrare l’anno successivo: mi ha bloccato monsignor Corti, l’attuale vescovo di Novara, che, pur non avendo ricevuto da me alcuna confidenza particolare, mi disse chiaramente che, a suo avviso, la mia maturità affettiva consigliava una pausa di riflessione. Ho allora iniziato a frequentare la Fuci, che stava ricostituendosi in quegli anni, e ho avuto modo di incontrare persone (Giuseppe Lazzati, Vittorio Bachelet e Alberto Monticone) che, se da un lato mi hanno aiutato a diventare un “cristiano adulto”, d’altro canto non sono state in grado di affrontare il nodo della mia affettività repressa e, probabilmente, hanno favorito quel processo di rimozione che stavo attuando da diversi anni.
Alla fine del 1983, durante l’anno di leva, mi sono innamorato (senza peraltro rendermene conto) di un mio compagno di caserma: cercavo in tutti i modi la sua compagnia, soffrivo per la confidenza che aveva con altri e che non riusciva ad avere con me, tremavo all’idea di dovermi allontanare da lui al termine del servizio militare. Nell’estate del 1984, quando sono rientrato finalmente a casa, ero sconvolto e non sapevo a chi chiedere aiuto: con i miei educatori non avevo mai affrontato certi argomenti; amici al mio paese non ne avevo; i vecchi compagni della Fuci erano lontani e, se anche mi fossero stati vicini, avrei avuto vergogna a parlare con loro di ciò che provavo; i ritiri spirituali dell’estate, che tanto mi avevano aiutato in altre circostanze, non mi dicevano più niente: mi sentivo fuori posto, con problemi completamente diversi da quelli che emergevano e non sapevo come comunicare il mio disagio.
Ho pensato allora di consultare uno psicologo, ma ho subito scartato l’idea per paura di incontrare qualcuno che potesse darmi del represso, mettendo così in crisi il sistema di certezze che, fino ad allora, aveva sorretto la mia vita. Nei primi mesi del 1985 ho finalmente conosciuto, grazie all’interessamento di un sacerdote milanese, uno psicologo cattolico che mi ha fatto capire di poter intervenire sul mio orientamento sessuale per modificarlo. Ho allora deciso di lasciare l’attività di ricercatore che avevo intrapreso all’Università di Milano e di intraprendere una professione che non mi attirava molto, ma che mi permetteva di pagare tranquillamente la terapia. Purtroppo, durante l’anno di cura, la mia situazione, invece di migliorare, ha iniziato a peggiorare vistosamente e quando ho deciso di sospendere le sedute ero in condizioni pietose: l’omosessualità era diventata una vera e propria “fissazione” che mi provocava sensi di colpa lancinanti da cui non riuscivano a liberarmi neppure le sagge parole di incoraggiamento del mio confessore.
Qualche anno dopo ho avuto modo di riflettere su quel tentativo di trattare analiticamente la mia omosessualità e sono arrivato alla conclusione che si sia trattato di un intervento inopportuno e maldestro: inopportuno perché l’esperienza mi ha insegnato che l’omosessualità non è una malattia che si può “curare”; maldestro perché ha dato origine a una serie di disturbi psicosomatici che non sono ancora scomparsi e, probabilmente, mi accompagneranno per tutto il resto della mia vita.
Nel frattempo avevo conosciuto un’esperienza monastica che stava muovendo i suoi primi passi in diocesi di Milano. Tra l’altro, uno dei monaci, si era rivelato un ottimo direttore spirituale che mi aveva fatto nascere il desiderio di entrare in monastero: in vista di questo obiettivo avevo messo a punto un serio cammino che prevedeva il mio trasferimento in una città che offrisse meno tentazioni di Milano e la scelta di un lavoro (quello del libraio) più adatto a me.
I miei disturbi psicosomatici si andavano però aggravando e anche il mio bisogno di intimità con persone del mio stesso sesso aveva assunto le forme di una vera e propria “fissazione omosessuale1” che mi portava a fuggire quando il partner usciva dall’anonimato e acquistava un volto preciso. Avevo, in sostanza, adottato un comportamento schizofrenico, in cui detestavo ciò che in realtà andavo a cercare ed esaltavo una continenza che non coltivavo più in alcun modo: le poche relazioni che riuscivo a costruire naufragavano immancabilmente a causa delle mie paure e della mia immaturità; amici omosessuali non ne avevo, anche perché mi terrorizzava l’idea che qualcuno scoprisse il mio orientamento sessuale; i disturbi psicosomatici avevano assunto una gravità particolarmente penosa che probabilmente si alimentava al disprezzo profondo che avevo per l’omosessualità in generale e per la mia in particolare.
Con queste contraddizioni sulle spalle ho iniziato a frequentare un gruppo carismatico con cui ero entrato casualmente in contatto: speravo in un miracolo che mi guarisse e mi permettesse di arrivare, attraverso una vita continente e ordinata, a quella scelta monastica che, secondo me, era l’unica vocazione a cui potevo aspirare. Niente però è cambiato e, dopo aver chiesto per anni un miracolo a cui mi sembrava di “avere diritto” (il controllo della mia omosessualità), mi sono ritrovato senza fede e, soprattutto, senza alcuna speranza: all’improvviso mi sentivo completamente escluso dal progetto salvifico di Dio a cui avevo cercato di dedicare tutta la mia vita.
Sono seguiti mesi tremendi: ero diventato uno schiavo del sesso e i miei disturbi psicosomatici, invece di diminuire, si erano aggravati. È stato l’incontro con due autori come Lewis e McNeill2 che mi ha aiutato a ritrovare quella fede che, ormai, aveva perso qualunque significato per me: in particolare mi hanno fatto scoprire come dietro al forte desiderio di superamento delle mie pulsioni omosessuali ci fosse un vero e proprio peccato di idolatria, un peccato che mi aveva spinto ad amare la mia “perfezione” più di Dio stesso. Una pedagogia poco attenta alla mia natura mi aveva allontanato dalla fede e mi aveva portato a disprezzare me stesso con tutte le mie forze, ma finalmente capivo che, per vivere la mia fede, dovevo ripartire da Dio e accettare serenamente la sua volontà, così come si manifestava nei miei limiti e nelle mie debolezze.
È stato a quel punto che ho conosciuto Il guado, il gruppo che mi ha aiutato concretamente ad accettarmi per quello che ero e a iniziare un cammino di integrazione della mia omosessualità nel resto della mia vita. Sempre nel Guado ho scoperto l’importanza che assumeva, per me, la scelta di servire gli altri omosessuali e di aiutarli a riconciliare la loro fede con la loro omosessualità: da allora ho capito che quella è la mia vera vocazione, una vocazione che sono chiamato a vivere con gli altri omosessuali con cui lavoro.
Elaborare e vivere un progetto
Come dimostra la mia storia personale, il primo problema che l’omosessuale credente (e non solo lui) si trova costretto ad affrontare è quello dell’accettazione della propria omosessualità: spesso, questa mancata accettazione viene rimossa a livello razionale ed emerge in alcuni comportamenti tipici che caratterizzano il vissuto di certi omosessuali. Tra gli elementi più vistosi che denunciano la presenza di un disagio profondo con la propria omosessualità ci sono il rifiuto di qualunque contatto con persone che non rispondono ai propri canoni estetici (si frequenta un altro omosessuale solo quando se ne subisce il fascino, in qualunque altro caso lo si rifiuta perché, in quanto omosessuale, è uno specchio della propria omosessualità) e un difficile rapporto con la propria fisicità (fanno paura tutti i contatti fisici con altri uomini e si sente il bisogno di “modificare” il proprio corpo per conformarlo ai propri modelli estetici).
Per meglio spiegare questa situazione è possibile fare riferimento a una preghiera di Santa Teresa d’Avila che inizia con l’invocazione: «Prendimi Signore come sono!» e si conclude con una bellissima espressione di abbandono alla volontà di Dio: «Fammi, Signore come vuoi!». Molti omosessuali non riescono a riconoscersi in questa preghiera e cercano di diventare ciò che in realtà non sono: persone capaci di mascherare sempre e comunque la propria omosessualità; persone capaci di esercitare una grossa carica seduttiva nei confronti di quanti entrano in contatto con loro, in maniera da non essere costretti a scoprirsi rivelando, prima dell’ipotetico partner, il proprio orientamento sessuale; uomini e donne ossessionati da un loro personale ideale di perfezione che lascia poco spazio all’azione della Grazia divina che invece sorprende e ci conduce là dove non avremmo mai pensato di andare. In alcuni casi si arriva addirittura a negare realtà del tutto evidenti quali la propria omosessualità («Vado con gli uomini, ma non sono omosessuale») oppure la propria appartenenza alla comunità omosessuale («Non esistono omosessuali seri a parte me e quelli che mi piacciono») con conseguenze grottesche.
Avendo vissuto questi atteggiamenti in prima persona, sono consapevole della loro pericolosità. Alcune volte costituiscono addirittura un ostacolo insormontabile, che blocca sul nascere qualunque rapporto continuativo con ogni esperienza capace di aggregare le persone omosessuali: io stesso, nel 1988 e nel 1992, ho fatto due fugaci visite al Guado, scappando poi via, perché non ci trovavo nessuno che fosse omosessuale nel modo speciale in cui (a mio avviso) lo ero io.
Nei nostri gruppi quello dell’accettazione di sé è un passaggio inevitabile: fino a quando una persona omosessuale continua a disprezzare se stesso e a odiare la propria omosessualità non sarà in grado di approdare a quella sana auto-stima che è indispensabile per intraprendere qualunque cammino di cambiamento; fino a quando una persona omosessuale non è in grado di considerarsi una persona capace di vivere in libertà le proprie scelte continuerà a correre il rischio di cadere in una sterile quanto dannosa auto-commiserazione; fino a quando una persona omosessuale continua a considerarsi un povero malato da compatire e da commiserare, giustificherà ogni compromesso e ogni depravazione senza rendersi conto che un atteggiamento del genere rischia di ingenerare atteggiamenti schizofrenici.
Tra le esperienze che, di solito, vengono proposte a chi ha bisogno di accettarsi in quanto omosessuale sono di fondamentale importanza i gruppi di riflessione sui quali si basano i nostri ritiri: qui, secondo un metodo mutuato dalla pratica di gruppi di autoaiuto, ciascuno è invitato a condividere gli aspetti più imbarazzanti della propria vita affettiva in maniera da trasformare i suoi problemi in problemi di tutto il gruppo, che insieme si sente chiamato ad aiutare chi vive una situazione di disagio a uscirne una volta per tutte. In questi momenti di condivisione viene dato un grande spazio alla comunicazione corporea e, in particolare alla “biodanza”, una tecnica psicocorporea elaborata dallo psicologo cileno Rolando Toro3. Proprio grazie alla “biodanza”, io stesso ho imparato a non aver paura del contatto fisico con gli altri maschi e ad assumere quelle forme di comunicazione fisica tipiche delle amicizie maschili che, per paura della mia omosessualità (e quindi delle implicazioni erotiche che io davo al contatto fisico con un altro uomo), avevo sempre rifiutato di vivere.
Una persona omosessuale che ha finalmente imparato ad accettarsi e a non disprezzare più l’omosessualità (la propria e quella degli altri) è finalmente in grado di vivere pienamente quelle amicizie disinteressate a cui il Catechismo della Chiesa Cattolica fa riferimento quando parla di omosessualità4. Ci siamo infatti accorti che, spesso, il vero dramma della persona omosessuale non è la mancanza di una relazione erotica, ma la profonda solitudine in cui è costretta a vivere la propria affettività: raccontare ad altri, che non ci giudicano e che sono in grado di comprenderci, quello che proviamo quando vediamo qualcuno che ci piace, è un’esperienza liberante che spesso, da sola, riesce a trasformare un’omosessualità “fissata” (in cui la dimensione genitale del proprio orientamento sessuale è prevalente, se non addirittura esclusiva) in un’omosessualità “integrata” (in cui il sé omosessuale entra in dialogo con il consesso degli altri sé e ne rispetta, magari modificandolo e integrandolo a partire dai propri bisogni, il sistema di valori).
Contemporaneamente all’offerta di esperienze forti, capaci di riconciliare le persone omosessuali con la loro biografia, i nostri gruppi cercano di rispondere all’esigenza, condivisa da molti, di cogliere con maggiore esattezza le dinamiche che caratterizzano il vissuto omosessuale. I numerosi incontri che offriamo alla comunità omosessuale delle città in cui operiamo vanno esattamente in questa direzione. Qualche volta l’approccio è caratterizzato da un grande rigore scientifico (numerosi sono stati gli psicologi, i sessuologi e gli psichiatri con cui abbiamo collaborato), altre volte si privilegiano aspetti più incerti da decifrare (si pensi, ad esempio, agli incontri con scrittori e artisti omosessuali che hanno cercato di leggerci la loro esperienza artistica alla luce della loro omosessualità), altre volte ancora ci siamo avvalsi del contributo di specialisti che coltivavano discipline che, solo marginalmente, si occupano di sessualità (la Storia5, ad esempio, si è rivelata uno strumento formidabile per comprendere i meccanismi che regolano la percezione e l’esercizio di un particolare orientamento sessuale). La scelta, portata avanti con onestà di intenti, di non accontentarci di spiegazioni affrettate ci ha spinto a sottoscrivere in pieno alcune affermazioni, richiamate dal magistero della Chiesa, quando parla di omosessualità: in particolare ci riconosciamo pienamente nell’idea che la genesi dell’omosessualità sia in gran parte inspiegabile6 e nel considerare profondamente radicato il nostro orientamento sessuale7. Purtroppo, uno degli errori più diffusi tra quanti affrontano il tema “omosessualità” è quello di proporre in maniera perentoria tesi superficiali, che nulla hanno a che fare con l’esperienza delle persone omosessuali, senza riconoscere l’articolata complessità con cui si presenta il fenomeno: tra questi errori vanno annoverati quelli che portano molti a considerare l’omosessualità come la conseguenza di qualche particolare dinamica parentale, oppure quelli di chi non tiene conto dell’intimo radicamento che la tendenza omosessuale ha avuto in molti uomini e in molte donne in tutte le epoche.
Comprendere la complessità dei meccanismi che regolano la propria omosessualità si è rivelato, per molti di noi, un antidoto molto efficace nei confronti dei molti ciarlatani che, facendo leva sul disagio che spesso caratterizza il nostro vissuto, propongono facili scorciatoie quali le terapie riparative finalizzate alla modifica dell’orientamento sessuale, le quali, quando va bene, lasciano il tempo che trovano e, quando va male, provocano gravi psicosi che possono risultare fatali.
Indispensabile, nel lavoro che portiamo avanti, è poi il confronto con il magistero della Chiesa, con la cultura teologica e con il dibattito in corso nelle varie confessioni cristiane sull’omosessualità: l’obiettivo di questo lavoro è quello di favorire, in quanti frequentano i nostri gruppi, la maturazione di una fede adulta, capace di ispirare cristianamente le scelte etiche, senza dipendere sempre e comunque da una autorizzazione esterna. Si tratta, in sostanza, di ribadire i due criteri ispiratori a cui fa riferimento il Concilio, quando parla della libertà di coscienza: il dovere di seguire la propria coscienza e, quindi, l’obbligo di considerarla il criterio ultimo di valutazione delle nostre scelte morali, l’impegno di formare questa stessa coscienza attraverso l’ascolto orante della Parola di Dio e l’accoglienza rispettosa del magistero della Chiesa nei suoi vari livelli di autorevolezza8.
In ogni caso occorre sottolineare il primato che il rapporto con Dio ha, rispetto alla nostra capacità di aderire pienamente a un particolare aspetto che caratterizza l’etica cattolica: abbandonare la fede solo perché...