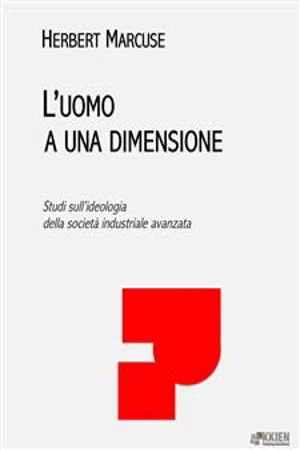![]()
Le possibilità delle alternative
![]()
8. L’impegno storico della filosofia
L’impegno della filosofia analitica di studiare soprattutto la realtà mutilata del pensiero e del discorso è singolarmente palese nel modo con cui considera gli universali. Del problema si è fatta menzione in precedenza, come parte del carattere storico inerente e nello stesso tempo trascendente, generale dei concetti filosofici. Esso richiede ora una discussione più dettagliata. Lungi dall’essere solo una questione astratta di epistemologia, o una questione pseudo-concreta di linguaggio e di uso di esso, la questione dello status degli universali è al centro del pensiero filosofico. La considerazione degli universali rivela la posizione di una filosofia nella cultura intellettuale, la sua funzione storica.
La filosofia analitica contemporanea è volta ad esorcizzare «miti» o «fantasmi» metafisici quali Mente, Coscienza, Volontà, Spirito, Io, dissolvendo l’intento di questi concetti in enunciati su particolari operazioni, prestazioni, capacità, inclinazioni, tendenze, abilità, chiaramente identificabili. Il risultato mostra, in modo curioso, come la distruzione sia impotente - il fantasma non cessa di perseguitare. Sebbene ogni interpretazione o traduzione possa descrivere adeguatamente un processo mentale particolare, l’atto di immaginarsi che cosa intendo quando dico «io», o che cosa intende il prete quando dice che Maria è una «brava ragazza», non una sola di queste riformulazioni, e neppure la loro somma totale, sembra afferrare o anche circoscrivere il pieno significato di termini quali Mente, Volontà, Io, Dio. Questi universali continuano a persistere sia nell’uso comune sia in quello «poetico», e ambedue gli usi li distinguono dai vari modi di comportamento o di disposizione che secondo il filosofo analitico esaurirebbe il loro significato.
Senza dubbio, questi universali non possono essere convalidati asserendo che denotano un insieme il quale è più e altro che le sue parti. All’apparenza sembra cosi, ma questo «insieme» richiede un’analisi del contesto di esperienza non mutilato. Se questa analisi metalinguistica è respinta, se il linguaggio comune è preso alla lettera — ovvero se un universo illusorio di comprensione generale tra le persone è sostituito all’universo prevalente di incomprensione e di comunicazione amministrata - allora gli universali accusati sono davvero traducibili, e la loro sostanza «mitologica» può venire dissolta in modi di comportamento ed inclinazioni.
Tuttavia, questa stessa dissoluzione deve essere posta in dubbio, non solo nell’interesse del filosofo, ma nell’interesse della gente comune nella cui vita e nel cui discorso essa ha luogo. Essa non rappresenta il loro vero modo di fare e di parlare; essa accade loro e li viola mentre sono costretti, dalle «circostanze», ad identificare la loro mente con i processi mentali, le loro persone con i ruoli e le funzioni che devono svolgere nella loro società. Se la filosofia non comprende questi processi di traduzione ed identificazione come processi societari - e cioè come una mutilazione della mente (e del corpo) inflitta agli individui dalla loro società - la filosofia lotta soltanto con i fantasmi della sostanza che vorrebbe demistificare. Il carattere mistificatore pertiene non ai concetti di «mente», «io», «coscienza», ecc. ma piuttosto alla loro traduzione in termini di comportamento. La traduzione è ingannevole proprio perché trasferisce fedelmente il concetto in modi effettivi di comportamento, di propensione, di inclinazione e così facendo scambia le apparenze mutilate ed organizzate (in sé abbastanza reali!) per la realtà.
Tuttavia, persino in questa battaglia di fantasmi sono evocate forze che potrebbero porre fine alla finta guerra. Uno dei problemi che recano scompiglio nella filosofia analitica è quello degli enunciati che riguardano universali come «nazione», «Stato», «la Costituzione britannica», «l’Università di Oxford», «Inghilterra»{125}. Nessuna particolare entità corrisponde a questi universali, eppure rende bene l’idea, ed è anzi inevitabile, dire che «la nazione» è mobilitata, che l’«Inghilterra» ha dichiarato guerra, che io ho studiato all’«Università di Oxford». Ogni traduzione riduttiva di queste dichiarazioni sembra cambiarne il significato. Noi possiamo dire che l’Università non è una entità a sé, a parte dai suoi vari collegi, biblioteche, ecc., ma è appunto il modo in cui questi sono organizzati; la medesima spiegazione può valere, modificata, per altri enunciati. Tuttavia, il modo in cui tali cose e persone sono organizzate, integrate ed amministrate opera come un’entità differente dalle sue parti componenti — al punto che può disporre della vita e della morte, come nel caso della nazione e della costituzione. Le persone che eseguono il verdetto, ammesso che siano affatto identificabili, agiscono in tal modo non come individui, ma come «rappresentanti» della Nazione, dell’Azienda, dell’Università. Il Congresso degli Stati Uniti in sessione, il Comitato Centrale, il Partito, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli Amministratori, la Facoltà, tutti questi enti che si riuniscono e decidono sulla linea di condotta sono entità tangibili e reali al disopra degli individui che li compongono. Essi sono tangibili nei documenti, negli effetti dei loro decreti, nelle armi nucleari che ordinano e producono, nelle nomine, nei salari, nelle condizioni che stabiliscono. Incontrandosi in assemblea, gli individui sono i portavoce (spesso inconsapevoli) delle istituzioni, delle influenze, degli interessi incorporati nelle organizzazioni. Nella loro decisione (voto, pressione, propaganda) - che è già l’esito di istituzioni ed interessi in competizione - la Nazione, il Partito, l’Azienda, l’Università sono messi in movimento, conservati, riprodotti come una realtà (relativamente) definitiva, universale, che sopraffa le istituzioni particolari o le persone soggette ad essa.
Questa realtà ha assunto un’esistenza superiore ed indipendente; perciò gli enunciati che la concernono costituiscono un vero universale e non possono essere adeguatamente tradotti in enunciati che concernono entità particolari. Con tutto ciò, l’urgenza di tentare tale traduzione, la protesta contro la sua impossibilità indicano che c’è qualcosa di sbagliato. Per rendere bene l’idea, «la nazione» o il «Partito» dovrebbero essere traducibili nei loro costituenti e componenti. Il fatto che non lo siano, è un fatto storico che si frappone al cammino della linguistica e dell’analisi logica.
La disarmonia tra l’individuo ed i bisogni sociali, e la mancanza di istituzioni rappresentative in cui gli individui lavorino e parlino per sé, conduce alla realtà di universali quali la Nazione, il Partito, la Costituzione, la Corporazione, la Chiesa - una realtà che non si identifica con alcuna particolare entità identificabile (individuo, gruppo, o istituzione). Tali universali esprimono vari gradi e forme di reificazione. La loro indipendenza, sebbene reale, è spuria poiché spuria è l’indipendenza delle potenze particolari che hanno organizzato l’insieme della società. Una ritraduzione che dissolvesse la sostanza spuria dell’universale è pur sempre necessaria - ma è una necessità politica.
“Si crede di morire per la Classe, si muore per gli uomini del Partito. Si crede di morire per la Patria, si muore per gli Industriali. Si crede di morire per la Libertà delle persone, si muore per la Libertà dei dividendi. Si crede di morire per il Proletariato, si muore per la sua Burocrazia. Si crede di morire per ordine di uno Stato, si muore per il Denaro che lo sostiene. Si crede di morire per una nazione, si muore per i banditi che la imbavagliano. Si crede - ma perché si crederebbe in una ombra così fitta? Credere, morire?... quando si tratta d’imparare a vivere?”{126}.
Questa è una «traduzione» genuina di un...