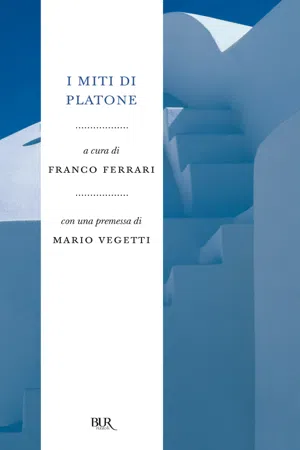![]()
LINK
DALL’ANTICO AL MODERNO
Stefano Amendola
Via da me, Platone e Spinoza!
Via da me scimmie chiacchierone!
Il disperato appello del Pierre di Melville sembra essere caduto nel vuoto: di Platone, ad oggi, non ci si è affatto liberati, anzi il nome del filosofo è un brand, un marchio di successo, sì da affiancarsi a veri cult della nostra epoca, quali Star Trek (John McCrone, The Myth of Irrationality. The Science of the Mind from Plato to Star Trek, Macmillan Publishing, New York 1993) e il Prozac (Lou Marinoff, Plato, Not Prozac!. Applying Eternal Wisdom to Everyday Problems, Harper Collins Publishers New York 1999, tr. it. a cura di Francesco Saba Sardi, Platone è meglio del Prozac, Piemme, Casale Monferrato 2001). Finanche negli scaffali degli ipermercati, tra vini più o meno ricercati, si possono scorgere il nome e il volto di Platone, scelti dal produttore vinicolo Al Bano Carrisi (noto ai più come cantante o naufrago televisivo) per nobilitare un vino del Salento, il «Platone», appunto.
Citazioni più o meno esplicite, suggestioni, rimandi: una fitta rete di agganci, di link a Platone, sembra avvolgere il nostro tempo, abbracciando mondi (il cinema, la Tv, la musica pop, la pubblicità) apparentemente lontanissimi da quello della speculazione filosofica.
In questa appendice – che non ha certo pretese di rigore scientifico – si desidera offrire un breve percorso attraverso alcuni echi dei miti platonici in epoca moderna, per dimostrare ancora una volta come il mito di Platone – con buona pace del Pierre melvilliano – continui a parlarci.
dp n="348" folio="346" ? L’invisibilità e l’anello del potere (T. 2)*
Il diventare invisibili è un potere che da sempre si accompagna all’interrogativo di carattere etico su come utilizzarlo, se per il bene comune o per trame un immediato profitto personale. A tale domanda solo a volte si può rispondere in maniera netta e decisa. Se tanti eroi dei fumetti si servono dell’invisibilità per combattere il male, non così sceglie di comportarsi il grullo Calandrino, protagonista di una celebre novella boccaccesca. Il bonaccione non ha dubbi nel voler utilizzare il presunto potere della pietra elitropia per «andar nelle banche a far manbassa di tutto senza che nessuno ci veda»: suo sogno è diventare milionario, anzi miliardario!!!
Ben più pericoloso di Calandrino è il protagonista dell’Uomo senza ombra (The Hollow Man, 2000), opera cinematografica di P. Verhoeven, ultimo nato di tanti invisible men del grande schermo. È lo stesso regista ad avvalersi della Repubblica di Platone («se diventasse invisibile l’uomo non potrebbe fare a meno di toccare ciò che non gli appartiene, entrerebbe in qualsiasi casa, farebbe l’amore con chi gli piacesse, ammazzerebbe chiunque avesse voglia di uccidere. Si comporterebbe insomma come un Dio fra gli uomini») per condannare l’invisibilità. Nel film uno scienziato, scopritore di un siero che rende invisibili, si sottrae alla vista per assassinare i suoi avversari e molestare giovani ragazze.
La scelta tra bene e male non è sempre così univoca. Ne è testimonianza il giovane Frodo, personaggio partorito dalla fantasia di J.R.R. Tolkien e portato sul grande schermo dal regista Peter Jackson: il piccolo hobbit, pur animato da nobile eroismo e determinato a correre i peggiori rischi per salvare la Terra di Mezzo, subirà l’oscuro fascino di un anello (l’anello del potere) che, come accade a Gige, lo renderà invisibile. Nel Signore degli Anelli (titolo originale: The Lord of the Rings, 1954-1955) emerge – in termini potremmo dire platonici – il conflitto tra una volontà tesa al bene, che caratterizza l’animo puro di Frodo, e il fascino oscuro del male, che più volte cercherà di piegare il portatore dell’anello a servirsi di esso per soddisfare la propria sete di potere e di grandezza.
Per saperne di più:
Deligiorgis, S., Boccaccio and the Greek romances, «Comparative Literature» XIX (1967), pp. 97-113.
Jocelyn, H.D., Giovanni Boccaccio’s interpretations of the Graeco-Roman myths and the constraints and impulses of his own times, in H.-J. Horn – H. Walter (eds.), Die Allegorese des antiken Mythos in der Literatur, Wissenschaft und Kunst Europas, Harrassowitz, Wiesbaden 1997, pp. 253-65.
Nagy, G., Saving the Myths. The Re-creation of Mythology in Plato and Tolkien, in Chance, J. (ed.), Tolkien and the Invention of Myth. A Reader, University Press of Kentucky, Lexington 2004, pp. 81-100.
Le marionette (T. 3)
Al tragico destino dell’uomo, convinto di essere una creatura libera, ma in realtà sempre in balia di forze superiori quali la divinità o il destino, H. von Kleist dedica il suo saggio Sul teatro delle marionette (1810). Come nel mito platonico, così nello scrittore romantico l’uomo è un burattino che vede le sue azioni e le sue scelte sempre determinate da altro e da altri.
Giocattoli, bambole, marionette diventano spesso i simboli chiamati a denunciare la falsità di un’esistenza: così la Nora di Ibsen (Casa di bambola, 1879) ammette di aver vissuto in una stanza da giochi quale moglie-bambola e figlia-bambola, un oggetto nelle mani prima del padre e poi del marito.
Un significativo rovesciamento di prospettiva nel rapporto simbolico uomo-marionetta ci è offerto da Le Nuvole stanno a guardare, episodio a firma di Pier Paolo Pasolini, del film Capriccio Italiano (1961). Stanche di essere imprigionate in una recita lontana dalla propria indole sono in questo caso proprio alcune marionette, impegnate nell’allestimento di Otello. La loro ribellione contro una finzione scenica, che attraverso i fili del burattinaio le costringe a ripetere azioni oramai odiate, finirà in una discarica di rifiuti: qui però le marionette troveranno un nuovo senso della vita nella contemplazione delle nuvole. Nell’episodio pasoliniano notevole ancora è un cortocircuito che sembra crearsi tra vita reale e finzione cinematografica. A interpretare la marionetta di un riluttante Otello è infatti Totò, burattino per eccellenza della risata italiana, quel Totò che Pasolini avrebbe voluto in tutti i modi liberare dai fili del suo essere marione...