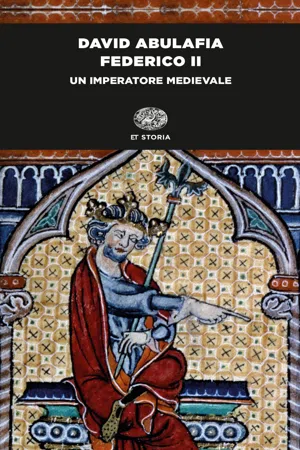I.
Pochi principi medievali si sono guadagnati imperitura fama di mecenatismo come Federico II. Scrivendo intorno al 1920, Charles Homer Haskins dichiara con entusiasmo che Federico sta alla pari di Ruggero II nella promozione delle scienze e della filosofia; la «brillante e precoce cultura del suo regno siciliano» era in parte un’eredità normanna e in parte una conseguenza della sua pressoché inesauribile curiosità per il mondo naturale. Presupposto di questi fermenti culturali era l’ubicazione geografica della Sicilia, crocevia di influenze greche, arabe e latine, crogiolo autocratico di tre o piú civiltà. Motivo di angustie per Haskins era l’esiguità delle testimonianze di un’intensa attività scientifica, senza contare che ovviamente la corte degli Hohenstaufen andava inserita nel contesto delle tradizioni culturali siciliane del XII secolo e di altre monarchie europee del XIII, in Castiglia e Aragona, che manifestarono interessi analoghi. Vista in questa prospettiva, la corte sveva comincia a perdere un po’ della sua reputazione di unicità; ma non importa, poiché all’origine di tutte le sue manifestazioni si colloca lo spirito stimolante di «una delle menti piú brillanti del Medioevo», lo stesso Federico II. In questa corsa all’incensazione Haskins fu in seguito sopravvanzato da vari colleghi tedeschi. Lo stupor mundi, il precursore del principe del Rinascimento, il razionalista e lo scettico: un personaggio costruito dagli storici, i cui tratti parevano trovare ampia conferma nei racconti degli autori contemporanei: Matteo di Parigi in Inghilterra, o l’impudico pettegolo (e frate) Salimbene in Italia.
La tesi della continuità dal periodo normanno a Federico II venne data per dimostrata. Nella sua biografia dell’imperatore, Van Cleve elencò l’impressionante fiorire di scuole e monasteri nel Mezzogiorno – il collegio medico di Salerno, l’abbazia di Montecassino – e partí dal semplice presupposto che ciò che era stato conseguito in ogni parte del regnum durante il XII secolo fosse un trampolino di lancio per glorie ancor maggiori nel centralizzato XIII. Gli anni giovanili dell’imperatore segnarono un’inevitabile arretramento del patronato culturale, ma ciò non ha impedito a Kantorowicz di evocare un benevolo centauro che avrebbe insegnato al real giovinetto i segreti dell’universo. Lo storico attinge alla mitologia greca, non alla realtà documentata. Federico ricevette una lodevole istruzione, ma non per merito di un centauro, né degli eruditi rabbini e imam di Palermo. Nel fiore dei suoi anni, era trascorso un secolo dacché Ruggero II aveva intrattenuto a corte gli ambasciatori del califfo fatimide e dato pieno appoggio a al-Idrisi e Doxopatrios. Il processo di latinizzazione era già piuttosto avanzato all’epoca di Guglielmo il Buono e gli studiosi musulmani a corte erano andati progressivamente scomparendo. Né in quel periodo la Sicilia poteva in alcun modo reggere il confronto con la Castiglia o l’Egitto come centro di conoscenza ebraica: le erano estranei tanto i vociferanti denigratori quanto gli infervorati discepoli del controverso Maimonide. Viene dunque spontaneo chiedersi se Federico II rivitalizzò e sviluppò gli interessi culturali dei suoi antenati. La risposta non gli è favorevole.
In un primo luogo, l’amalgama culturale attribuito alla corte normanna non è visibile in quella sveva. L’elemento musulmano era in pratica ridotto a una guardia scelta di Saraceni di Lucera, che è lecito supporre analfabeti – uomini d’arme, non di lettere. Numerosi erano comunque i visitatori musulmani, ad esempio gli ambasciatori di al-Kamil, e Federico mantenne costanti rapporti epistolari con studiosi islamici sino alla lontana Ceuta. Da alcuni episodi risalenti alla crociata abbiamo motivo di supporre che conoscesse l’arabo, ma gli Arabi della Palestina con cui venne in contatto non appartenevano certo all’intellighenzia; da loro apprese in sostanza l’arte dell’accecare i falchi cucendo loro le palpebre. Né Federico era particolarmente sensibile ai versi composti a sua lode in arabo da adulatori siciliani, maltesi e nordafricani. Quanto all’elemento greco, non si può certo dire che fosse abbondante. Forse Federico aveva un’infarinatura della lingua, ma chiamò a corte pochi Greci. La principale opera in greco uscita dalla reggia di Federico fu di fatto una traduzione delle Costituzioni di Melfi. La nativa cultura greca della Calabria e della Sicilia orientale, testimoniata nei documenti della Messina contemporanea e nelle chiese di Rossano, sfiorò appena la corte. Giovanni d’Otranto e Giorgio di Gallipoli, Greci provenienti dal tallone d’Italia, scrissero poesie in onore di Federico, ma le grandi costruzioni retoriche dei tempi di Ruggero II sarebbero andate sprecate negli ambienti di corte. La tradizione ortodossa rimase viva in una diocesi adagiata tra le montagne calabresi, a Rossano, ma Federico non nutriva un reale interesse per la Chiesa ortodossa italica o bizantina. Dopo la conquista latina del 1204, Costantinopoli aveva abdicato al ruolo di centro internazionale di una cultura cosmopolita che, per patrimonio di conoscenze, non aveva rivali nel mondo cristiano; laddove Ruggero aveva invidiato ai Comneno la loro corona imperiale romana, Federico si cinse di una corona imperiale tutta sua, rifiutandosi di concedere all’imperatore latino di Bisanzio quello status che perfino gli occidentali avevano riconosciuto agli imperatori romani d’Oriente. I buoni rapporti mantenuti con l’impero di Nicea, sopravvissuto ai reiterati attacchi dei Franchi, vanno inquadrati in una strategia mediterranea «a tutto campo».
Per giunta la corte di Federico aveva carattere itinerante, un po’ perché i possedimenti della Germania e dell’Alta Italia impedivano all’imperatore di domiciliarsi in un’unica base o capitale e un po’ perché negli anni trenta e quaranta le campagne belliche lo tennero in movimento per lunghi periodi in Lombardia e nell’Italia centrale. La lenta discesa del 1239 da Parma al regnum non fu l’avvicinarsi ad una destinazione finale, ma un incessante susseguirsi di provvisori attendamenti. Napoli e Messina divennero sedi amministrative importanti, ma Federico preferiva prender sollievo (sono parole sue) nei padiglioni di caccia della Puglia; dopo la giovinezza non aveva avuto tempo di visitare la parte insulare del regno. Questa corte viaggiante non poteva reggere il paragone con la sontuosa reggia palermitana di Ruggero II. Nel 1239-40 Federico diede ordine, da lontano, ai suoi cortigiani di preparare violette candite e di badare al serraglio, che inutilmente avrebbe voluto con sé. Comunque si portava appresso alcuni animali degni di nota – un elefante, cammelli, falchi – nonché i gioielli della corona e parte della fornita biblioteca. Un pingue bottino su cui i suoi nemici lombardi avrebbero messo le mani a Parma. Fosse riuscito a vivere in pace con le città italiane e il papato, con tutta probabilità avrebbe speso somme piú consistenti per libri, bestie e spettacoli; pur tra i disagi della guerra, mai dimenticò infatti di coltivare questi interessi. I suoi dignitari, in particolare i poeti che costituivano la scuola siciliana di lirica dialettale, erano in sintonia con le piú avanzate tendenze della cultura europea, sebbene i loro versi siano soltanto una pallida imitazione del modello provenzale (ma di questo parleremo piú diffusamente tra poco). Ad ogni modo ne esce rimpicciolita la classica immagine dell’imperatore a suo agio tra uomini di genio arabi, greci, ebrei e latini, disinvolto nel mettere in discussione i dogmi dei vari credi monoteistici e nel penetrare i segreti dell’universo insieme a scienziati iconoclasti. Destituita di ogni fondamento è l’accusa di aver definito Mosè, Gesú e Maometto «i tre impostori»: fulmini di repertorio scagliati in Occidente contro i miscredenti molto prima della sua nascita.
Un ulteriore motivo di confusione nella rinomanza di Federico quale sommo protettore dell’attività culturale è la tendenza ad attribuire al suo influsso ogni conquista intellettuale di un qualche peso tra il 1200 e il 1250. Il pisano Leonardo Fibonacci, che tanto s’adoprò per far conoscere in Occidente il valore della numerazione arabica, scrisse per la prima volta dell’argomento nel 1202, quando Federico aveva sette o otto anni. Vero è che incontrò l’imperatore molti anni piú tardi, forse durante un soggiorno di questi a Pisa, e consegnò alla corte sveva una nuova edizione del suo Liber Abaci nel 1228, ma rimane pur sempre il fatto che Fibonacci era in sostanza un mercante pisano con vasti interessi a Tunisi, dove apprese i rudimenti della matematica araba, e dunque un prodotto della cultura mercantile della Toscana piú che della corte di Federico II. L’imperatore lesse l’opera, ma a quell’epoca l’uso delle cifre arabe si era già diffuso in Italia, tant’è vero che un notaio genovese le aveva adottate pochi anni dopo l’uscita del primo trattato di Fibonacci. Un secondo esempio ci è offerto da Michele Scoto, massimo tra gli scienziati di Federico, il quale trascorse gran parte della sua vita attiva a Toledo e si presentò a Palermo forte dell’esperienza di traduttore e cultore di arti magiche. Con lui arrivò nel regnum la scienza arabizzata della Castiglia, un fatto che sottolinea un aspetto importante del cenacolo voluto da Federico. I maggiori progressi culturali agli inizi del XIII secolo furono dovuti a ebrei, musulmani e cristiani che lavoravano fianco a fianco nella traduzione dei testi greci e arabi, non in Sicilia ma in Spagna. La corte sveva era una appendice culturale di quella castigliana.
I traduttori ebrei al seguito di Federico erano pochissimi di numero e neppure originari del Mezzogiorno. Fu dalla Provenza, con i suoi stretti legami con i Sefarditi d’Aragona e Castiglia, che affluirono alcuni membri dell’illustre famiglia Ibn Tibbon – tra gli altri Jacob Anatoli, collaboratore di Michele Scoto, e il di lui cognato Mosè ben Samuel Ibn Tibbon, fecondo volgarizzatore di testi arabi. Questa famiglia era di ceppo spagnolo, ma intorno alla metà del XII secolo, sospinta dalle invasioni dei fanatici Almohadi musulmani, aveva trovato rifugio nel Sud della Francia, apportandovi una conoscenza della lingua araba e della filosofia inusuale anche in una comunità ebraica evoluta come quella della Linguadoca. Anatoli volse in latino i commentari ad Aristotele del grande filosofo arabo Averroè e l’Almagesto di Tolomeo. Di particolare interesse è la comparsa di quest’ultima opera in una nuova traduzione, poiché era già stata volta in latino nella Sicilia normanna attorno al 1160. La versione normanna era una traduzione dal greco, ma Anatoli lavorò su un testo arabo, a sua volta una parafrasi di una traduzione siriana dell’originale. Non è difficile capire perché questo fosse il modo di procedere preferito in Spagna e nella Francia meridionale. In primo luogo, il greco nella penisola iberica era pressoché sconosciuto. E poi si trattava di testi assai ostici per chi non aveva dimestichezza con i concetti che vi venivano espressi, e le versioni arabe molto contribuirono, non sempre con la precisione auspicabile, a rendere intelligibile la filosofia greca, grazie anche alla sapiente utilizzazione dei commentari, di tardi filosofi greci come Apollonio di Afrodisiade o musulmani come Avicenna e Averroè. La sostanza dell’originale andava in gran parte perduta, ma i traduttori del XIII secolo non erano filosofi classici moderni preoccupati di sviscerare l’esatto processo di pensiero insito in ciascuna proposizione. La loro interpretazione di Tolomeo doveva inserirsi nella cornice di una consolidata epistemologia islamizzata, post-ellenistica. Era perciò arduo per i Latini della Sicilia comprendere appieno le volgarizzazioni dall’arabo o dal greco, ma queste ultime si proponevano in forma grezza e non di rado i traduttori rimanevano perplessi di fronte a termini e concetti affatto familiari – donde una miriade di topiche e travisamenti.
Di tutte le traduzioni eseguite nell’Italia meridionale durante il regno di Federico, la piú importante fu senza dubbio quella di un’opera redatta originariamente in arabo ma in seguito volta in ebraico, versione quest’ultima approdata alla corte di Palermo e ai letterati di Napoli. Moses ben Maimon, conosciuto altresí come Maimonide, o Rambam, cercò nella Guida dei perplessi di conciliare la visione aristotelica del mondo con i dettami dell’insegnamento religioso giudaico. I suoi piú ferventi ammiratori dei nostri giorni tendono a ignorare questo scritto in favore di altre sue fatiche piú ortodosse che non ebbero altrettanto impatto al di fuori del mondo israelitico. Egli è dunque un punto di riferimento sia per l’ala ortodossa che per quella anti-fondamentalista dell’ebraismo moderno. Tra i primi lettori della Guida vi fu però il discendente di una nobile stirpe della Bassa Italia, poi apprezzato a corte, Tommaso d’Aquino, che di lí a poco, seguendo le orme di Maimonide e Averroè, si sarebbe a sua volta cimentato nella composizione dell’aristotelismo con la sua fede. Può darsi che nella traduzione ci sia lo zampino di Michele Scoto, ma tutto sommato il suo ebraico, di cui pure non era del tutto digiuno, appare alquanto zoppicante, quanto meno nei manoscritti che ci sono pervenuti. Quanto alle versioni dall’arabo soccorreva un lavoro di equipe con ebrei, cristiani e, al caso, musulmani raccolti attorno allo stesso tavolo e intenti a scambiarsi impressioni nel vernacolo che li accomunava. La corte sveva non traboccava certo di «teste d’uovo» giudee. Federico importò un certo numero di ebrei per migliorare le coltivazioni, ma si premurò di contingentarli ed evitò di conceder loro libertà religiose maggiori di quelle previste dal diritto canonico. Gli intellettuali erano sino a un certo punto al di sopra di queste norme, ma Federico era un acceso filosemita, limitandosi ad accogliere i modi di pensare dei suoi contemporanei piú istruiti. Posto a raffronto del «cristianissimo», isterico, mangia-ebrei Luigi IX di Francia, non durò fatica a mostrarsi uomo di buon senso e moderazione, ma giudizi analoghi circolavano anche nei corridoi della Sede Apostolica, ed ebbero peraltro su di lui una certa influenza. Con ciò non si vuol negare che di quando in quando un erudito ebreo fosse presentato a corte: gli Ibn Tibbon e Judah ha-Cohen conobbero Federico di persona e furono in buoni rapporti con Michele Scoto. Sul piolo piú alto della scala intellettuale vi erano dotti di tutte e tre le religioni desiderosi di dibattere le questioni che stavano loro a cuore, in campo scientifico o anche religioso, come la prova dell’esistenza di Dio, o l’eternità della materia. Sebbene la corte degli Hohenstaufen non mancasse di opportunità, quella castigliana era un pestello piú adatto a macinare le idee, contenendo rappresentanti delle tre confessioni e usufruendo di un piú agevole accesso ai libri del sapere arabo, in molti casi compilati in Spagna.
Federico cercò per quanto poteva di rimediare al disordine di un’esistenza zingara mantenendo vigorosi scambi epistolari; il suo dinamismo culturale si identifica per larga parte in una sorta di «corso per corrispondenza» in scienza e filosofia con ebrei spagnoli, musulmani egiziani e i suoi stessi cortigiani, lontani a volte dalla sua presenza. Judah ben Salomon ha-Cohen ricevette lettere dall’imperatore in Castiglia e piú tardi gli rese visita nell’Italia settentrionale. Fu Michele Scoto a stabilire il collegamento tra questo giovane mistico e scienziato e la corte sveva. Al-Kamil, sultano d’Egitto, si tenne in contatto con l’imperatore dopo la conclusione della crociata, intrecciando idee sulla natura dell’universo, offrendo risposte a quesiti matematici complessi e addirittura incaricando un astronomo di fiducia di addottrinare Federico e al contempo assolvere funzioni diplomatiche. Simili commistioni di offici non erano per nulla inusuali in questo periodo; all’epoca della Sicilia normanna, Aristippo aveva fallito un trattato di pace con Costantinopoli, ma era riuscito a farsi mandare alcuni manoscritti. D’altronde Federico si sforzava di salire nella stima dei suoi vicini mediterranei presentandosi come uomo di cultura del quale si potesse dire (com’era stato per Ruggero II) che, non fosse stato per le convinzioni religiose, avrebbe uguagliato sul piano intellettuale qualunque principe maomettano. In parte era un gioco diplomatico, ma Federico lo giocava con energia; i suoi interessi culturali non erano simulati, e i suoi interessi intellettuali erano di gran lunga piú ampi di quelli dei colleghi sui troni d’Inghilterra o Francia. Ciò non vuol dire che tenesse in funzione una corte particolarmente scintillante, né che avesse tempo di indulgere alle astruse pratiche negromantiche che i suoi denigratori gli attribuivano.
Cosí agli inizi degli anni quaranta Federico, con occhio attento ai vantaggi politici, scrisse al califfo almohade del Marocco sottoponendogli una serie di questioni filosofiche cui rispose un eminente erudito di Ceuta, Ibn Sabin. Ai filosofi musulmani del Medio Oriente, sino al lontano Yemen, furono sottoposti argomenti analoghi, presumibilmente drappeggiati in fluente arabo dall’astrologo di corte Mastro Teodoro, di cui ci occuperemo tra poco. Ibn Sabin comunque non si scompose, facendo notare che l’imperatore non aveva afferrato la terminologia filosofica e lasciando implicitamente intendere che l’unica vera risposta si poneva nell’accettazione della fede islamica. Avesse Federico voluto riceverlo, l’irascibile Ibn Sabin si sarebbe fatto premura di illuminarlo a dovere. Non si pensi alla consueta richiesta di un vitalizio; Ibn Sabin rimandò in effetti al mittente la somma che Federico gli fece pervenire. Quanto all’oggetto del contendere, pare che Federico avesse già contratto il virus delle idee aristoteliche, pur essendo impantanato in una distesa di comprensibili perplessità; non era certo agevole mettere d’accordo queste nuove e oscure rivelazioni con l’affermata e tuttora dominante teoria platonica delle forme. Chiedere a Ibn Sabin quale ragionamento avesse seguito il sommo pensatore per dimostrare l’eternità della materia rivela una conoscenza generica delle sue tesi ma al contempo una carenza di disponibilità o di comprensione delle sue sottili disquisizioni; sappiamo che altri problemi, come l’immortalità dell’anima, agitavano Maimonide e Averroè. Ci troviamo dunque di fronte a un intellettuale che desiderava approfondire concetti orecchiati e mutuati in un fuoco d’artificio di inesattezze, concetti le cui drammatiche implicazioni per la teologia ancora dovevano essere analizzati. Alquanto meno impegnativi erano altri quesiti; a Judah ha-Cohen venne richiesto di risolvere alcuni rompicapo geometrici, mentre la scuderia di «cervelli» di al-Kamil fu messa alla frusta per spiegare su richiesta dell’imperatore, inter alia, perché un bastoncino parzialmente immerso in acqua sembri piegarsi.
Haskins ha portato alla luce un’altra sequenza di domande, questa volta rivolte all’astrologo e medico scozzese Michele Scoto; laddove negli esempi precedenti risulta incerto chi sia il proponente, qui, se dobbiamo prestar fede alla parola di Scoto, udiamo la voce dell’imperatore. Federico pretendeva niente di meno che una descrizione dell’universo dalle fondamenta alle sfere celesti piú esterne. Questi, sosteneva Federico, erano i nodi centrali dell’esistenza. Spesso aveva sentito parlare delle stelle e della natura – le persone, gli animali e i minerali del mondo conosciuto – ma vi erano segreti al di là degli astri: il paradiso, il purgatorio, l’inferno. Dov’erano situati e chi ne era a capo? In quale cielo è Dio nella persona della Sua Divina Maestà e come è seduto sul Suo trono e come è accompagnato da angeli e santi, e cosa fanno essi ininterrottamente dinnanzi a Lui? Si aggiungono domande sulle acque, dolci e salate, che si trovano sul pianeta, con tutta probabilità in rapporto alla spiegazione, fornita nella Genesi, che la terra stessa è sospesa tra «acque». Un altro dei quattro elementi naturali, il fuoco, scaturisce dalla terra sull’Etna e nelle isole Lipari al largo della Sicilia; Federico chiede delucidazioni sui vulcani, sui geyser e altri fenomeni consimili, senza dubbio facendo riferimento a osservazioni personali.
Il salto dalla descrizione dei cieli a un’analisi della natura dell’acqua salata o dello Stromboli è breve, poiché il cielo di cui parla Federico è una realtà materiale. L’anima stessa in un certo senso partecipa delle leggi della fisica e non si colloca su un diverso livello di realtà. Una concezione positiva dell’universo stava rapidamente prendendo forma grazie a quei teologi e filosofi che nel XII secolo avevano cominciato a identificare il purgatorio come un luogo, e non soltanto una condizione nella quale l’anima si sarebbe ritrovata dopo la morte. Si andò cosí delineando una mappa particolareggiata del cosmo, come ci dice Jacques Le Goff, che avrebbe avuto spettacolari ripercussioni sulla teologia del peccato e anche sull’organizzazione economica della società terrena. Collocandosi in un momento storico nel quale l’idea del purgatorio come entità reale aveva ormai preso saldo piede, le domande di Federico non sono da considerarsi stravaganti né, tanto meno, espressioni di uno scetticismo di fondo. «Dov’è Dio?» viene chiesto; e una dottrina che postuli un Dio in grado di assumere sembianze umane e di ascendere al firmamento non può esimersi dalle logiche conseguenze del concetto della corporeità e ubicazione divina. Federico non era uomo da accontentarsi dell’usuale spiegazione delle cose ignote e inconoscibili; di mente poco portata alle astrazioni, era attratto dai fatti del mondo materiale. Non era un filosofo nel senso che oggi attribuiamo a questo termine; mirava all’informazione esatta, applicata ai reami di Dio non meno che a quelli degli uomini.
Un manoscritto contiene altro materiale che ameremmo credere genuino. «Diteci se un’anima nell’aldilà può conoscerne un’altra e se possa far ritorno a questa vita per parlare e mostrarsi», e, poco piú avanti: «Come mai l’anima d’un vivente che è passata a un’altra e diversa vita non può essere indotta a tornare dall’...