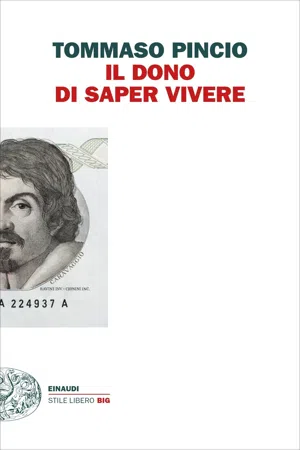Succede da almeno due mesi, odiati muri. Appena l’occhio mi cade sul tavolo e la sedia che gli è davanti, la testa mi si incanta su un proverbio russo del quale non sapevo nulla prima che me ne parlasse il mio avvocato, un paio di mesi fa per l’appunto. Preferirei evitarlo. I pensieri fissi sono una iattura per un uomo nelle mie condizioni. I fetidi due metri per tre in cui vivo rinchiuso offrono però poco su cui far cadere l’occhio. Le sbarre orizzontali della finestra sopra il letto, se vogliamo chiamarlo letto. Le sbarre verticali della porta. Il piccolo specchio sopra il tavolo. Il sedile delle deiezioni quotidiane. I libri di cui mi fa dono il mio avvocato e che io impilo in terra, nell’angolo tra il tavolo e il sedile delle deiezioni, guardandomi bene dal leggerli. Niente di tutto ciò mi distrae né mi ispira riflessioni migliori. Per giunta, negli ultimi tempi il proverbio ha preso ad affacciarsi anche quando oriento lo sguardo altrove e una volta che si è manifestato non c’è piú verso che me ne liberi, mi vortica in testa per ore, un nugolo di zanzare, e la nottata si risolve in strazio.
Dice il proverbio maledetto: «Serba il vestito da che è nuovo e l’onore fin da giovane». O qualcosa di simile. Non so dove il mio avvocato l’abbia pescato. In uno dei suoi libri, immagino; dubito sia mai stato in Russia. Tutto quello che sa della vita lo ha appreso leggendo e non ne fa un mistero, anzi se ne compiace e non manca mai di citare per filo e per segno la fonte di ogni perla che mi dispensa con accanimento inspiegabile, come se alla mia età e considerati i vent’anni che mi restano da passare al gabbio la saggezza potesse servirmi. Con il proverbio russo è andata in maniera diversa, però. Me lo ha scandito in tono quasi afflitto, per commentare qualcosa di cui gli avevo appena parlato e che non doveva essere nulla di importante, visto che l’ho dimenticato. Non ha aggiunto altro, niente note a piè di pagina, come suo solito. Scandito il proverbio, si è limitato ad annuire quasi tra sé a labbra serrate, assumendo l’aria grave che gli piace da matti assumere in frangenti simili malgrado la sua faccia si addica pochissimo a espressioni impegnative.
Sul momento, non ci ho dato peso. Di rado presto attenzione a quel che dice il mio avvocato; le poche volte che lo faccio mi viene il nervoso, quindi evito. Ho archiviato nella testa il proverbio senza esprimermi, convinto che non ci avrei mai piú pensato, e invece. Tornato in cella, tolto il vestito, sistemata la giacca sulla spalliera della sedia, ho steso con cura i pantaloni sul tavolo – ché solo a questo mi serve il tavolo: a stenderci i pantaloni di modo che mantengano un’idea di piega – e ho buttato in terra maglietta e mutande. Ero ormai sul punto di stendermi anch’io e invece sono rimasto in piedi, nudo in mezzo alla cella. Non riuscivo a staccare gli occhi dal vestito. D’un tratto mi è riapparso in testa il proverbio, la prima parte almeno – «Serba il vestito da che è nuovo» – e da allora è cosí ogni volta che mi tolgo quell’abito e lo sistemo su tavolo e sedia, mi fermo a osservarlo e penso al proverbio. Non me lo tolgo spesso, avendo poche occasioni per indossarlo; due o tre volte alla settimana, in sala colloqui, per le visite del mio avvocato. In cella sono sempre nudo, l’abito se ne sta per conto proprio, al posto suo, giacca e pantaloni riposti come ho detto. Ma basta un niente – e anche questo ho detto – perché mi ci caschi l’occhio e mi impantani in pensieri inutili e domande oziose.
Mi chiedo, per esempio, da quanto lo serbo, che è una domanda oziosissima, sapendolo bene. Da moltissimo. È l’abito che indossavo il giorno del mio arresto e fanno dieci anni da allora. Ma per l’acquisto bisogna tornare piú indietro, risalire agli albori della mia principale e pressoché unica esperienza lavorativa, a ventidue anni prima cioè, a quando ero fresco di studi e mi facevo illusioni sull’avvenire. A conti fatti, quella grisaglia di lana leggera ha quasi gli anni di Cristo, e non li dimostra per nulla. È forse un po’ frusto, come abito, ma in condizioni piú che presentabili, e dubito che le nuove mode l’abbiano reso obsoleto. A parte il risvolto dei pantaloni, già caduto in disuso quando ero ancora un libero cittadino, il resto rimane impeccabile. Abbottonatura monopetto, revers classico, tasche a filetto con pattina. Certi dettagli non tramontano. La grande sartoria non teme le offese del tempo. La stoffa è lisa solo nei punti piú sensibili e non in maniera evidente. Di sicuro ha retto agli anni piú dignitosamente di me, tanto per smentire una delle mille sciocchezze che il mio avvocato pesca nei romanzi e spaccia per verità da scolpire nella pietra: che la materia inorganica degli oggetti con cui addobbiamo la nostra vita invecchia prima e peggio della carne umana. La materia inorganica della roba qualunque che compra lui, forse. Ma questo abito non è mica roba qualunque. Mi costò quasi due stipendi, quasi due milioni del conio di allora. Basta pagare e le cose durano. Eccome se durano. L’abito fa ancora la sua figura, ha dovuto subire un paio di riparazioni, ma a causa mia, per adeguarsi ai cedimenti del mio girovita.
È me che avrei dovuto serbare da giovane, altroché. Prima non ci pensavo, ma ora – e siano maledetti il mio avvocato e i proverbi russi – appena mi ci cade l’occhio non riesco a non pensare che quel vestito mi ha accompagnato per l’intera mia vita di adulto. È in fondo un mio ritratto, la raffigurazione di ciò che sono stato come uomo, del poco che ho combinato in questi trentadue anni. Un «poco» disastroso, se vogliamo essere onesti. L’impresa piú ragguardevole che mi si può ascrivere è un omicidio che neanche ho commesso. Di tutto ciò, il vestito non mostra tracce visibili, eppure è lí, non può non esserci, perché non ho mai smesso di indossarlo, seppure con parsimonia, per non sciuparlo, per serbarlo, appunto.
Immagino cosa direbbe il mio avvocato. Direbbe che è un ritratto di Dorian Gray al contrario. In effetti, i guasti del tempo e gli sbagli, anziché imprimersi nella stoffa, hanno segnato me, lasciando il vestito giovane come era allora, perfettamente serbato. Mi domando perciò se non sia piú corretto dire che io sono il ritratto e il vestito Dorian Gray. Forse sí. Fatto sta che da quando il proverbio russo mi si è ficcato in testa ho cominciato a odiarlo, quel vestito, mentre prima era una delle poche cose a cui tenevo, se non la sola; l’unica scelta di cui non mi ero mai pentito finora. E stai a vedere che, come mio solito, non avevo colto il nocciolo della questione; stai a vedere che proprio acquistarlo è stata la prima vera scelta sbagliata della mia vita, quella da cui sono discese le altre o comunque quella che meglio esemplifica il modo in cui ho sempre sbagliato nello scegliere.
O forse la piú corretta è un’ipotesi ulteriore, secondo cui non importa chi ritrae chi, se io il vestito o il vestito me. In fondo, ritratto e ritratto si equivalgono, sono legati a doppio filo dallo stesso nome. È un ritratto la persona che viene raffigurata, come lo è la cosa in cui vediamo raffigurata una persona. Piú ci penso, piú me ne convinco. Piú butto l’occhio alla mia sinistra, al tavolo e alla sedia, piú vedo riflessi nel vestito tanto la persona che sono stato quanto quella che avrei voluto essere. Questi due individui, seppure diversissimi tra loro, per non dire incompatibili, nel vestito mi appaiono come un essere unico. È una visione mostruosa, non dissimile, mi si passi il riferimento, da quella che vide Perseo nel suo scudo, anzi no, dall’assenza che riflette un vampiro in uno specchio. Immagino che per il vestito sia lo stesso. Faccio discorsi da pazzo? Probabile. Ma non me ne restano altri.
Anch’io potrei tranciare la mia vita nei tre segmenti tipici dell’esistenza umana. Nasci, provi a vivere, ti senti morire. Aspettative, svolgimento, morale della favola. Non è per tutti cosí? Pur non volendo, mi viene in mente Flaubert, grande passione del mio avvocato. Va matto per L’educazione sentimentale. Me ne ha regalato una copia, ovviamente. Ci tiene tanto che lo legga. Tenesse solo a questo. Saranno almeno cento, i libri a cui tiene e che mi ha portato. Ogni tanto ci butto un occhio: sono impilati dietro il cesso, a prendere polvere e impregnarsi di umidità. Dell’Educazione sentimentale, però, se n’è fatto una malattia. Non passa mese che non mi chieda come procede con Gustave. Lo chiama proprio cosí, Gustave. Io, Flaubert, non lo leggerei soltanto per come lo chiama il mio avvocato.
A rilento, rispondo. Sa, il caldo. Faccio fatica.
Lui finge di mostrarsi comprensivo. È tutta una finta, il mio avvocato; una recita continua e pure cagnesca. Ammette che non è facile concentrarsi con il caldo. Neanche il tempo di finire questa falsa concessione che passa a esortarmi. Devo insistere, dice, e mi chiede dove sono arrivato, a che capitolo.
Su due piedi, non saprei, rispondo. Lo alterno con gli altri che mi ha portato, sa. Per cui non ricordo bene. All’inizio, però. Primo capitolo. Secondo, al massimo. E dentro di me rido.
Lui mi fissa perplesso, certi giorni si spinge fino a notare che sono fermo al primo capitolo da un anno. Di solito glissa, va oltre, dice di non vedere l’ora che arrivi a una certa scena a lui particolarmente cara per sapere cosa ne penso, e mentre me lo dice mi racconta nei dettagli di che scena si tratta, e siccome le scene a lui particolarmente care non si contano, succede che mi ha raccontato l’intero libro tante di quelle volte che ormai quasi sono convinto di conoscerlo a memoria.
Una gli è davvero piú cara delle altre, però. È verso la fine, per cui dubito la leggerò mai. Quando Frédéric Moreau si trova d’accordo con un amico riguardo al ricordo migliore delle loro vite. Entrambi pensano sia stata la volta in cui pianificarono nei dettagli una visita a un bordello, ma arrivati al dunque mancò loro il coraggio.
Che universale verità!, dice il mio avvocato. Il piacere autentico è sempre l’attesa, pregustarsi il momento. Che poi il momento arrivi non è importante. Non trovi anche tu?
Ora, sorvolando sui bordelli, che mi sono indigesti per varie ragioni, io ne avrei pure, di pensieri sulla pregustazione, di obiezioni per questo scimunito. Ma non mi avventuro. Sicché.
Mi lasci arrivare al capitolo, dico. Poi le faccio sapere, avvocato.
E tuttavia devo riconoscere che è cosí, l’architettura di una vita si fonda sulle attese. Il sipario si alza sui beati anni in cui ti balocchi con quel che farai da grande. Poi, a questa prima e dolcemente tragica fase – perché non c’è infanzia, credo, con un che di tragico – subentra la seconda, in cui, non piú bambino ma comunque giovane, non smetti di crogiolarti, convinto che il meglio debba ancora venire. Infine il terzo segmento, che per me perdura da tanti di quegli anni che i precedenti mi sembrano un abbaglio dell’immaginazione. La fase nella quale, scoperto che il momento in cui diventare grandi è trascorso da un pezzo e non si ha piú niente da attendere, si depongono le armi e l’eventualità della morte appare non dico gradita ma almeno una crudeltà non cosí priva di giustificazioni.
Le armi che ho deposto sono qui con me, sono la grisaglia che conservo con cura da anni. Ho seguitato a indossare il vestito nel terzo segmento, ma è nel secondo che ha svolto la funzione di corazza per battaglie di là da venire. Che vita era la mia di allora? Qual era la mia giornata tipo di giovane che attende l’occasione? Come si articolava? Il mio avvocato me lo chiede spesso. Io mi scoccio, ovvio.
Ma che domande fa?, sbotto. Come vuole che fossero le mie giornate? Lavoravo, come tutti.
Chiuso il discorso, mi ammutolisco, aspetto che mi riportino in cella, salvo poi, una volta lí, mettermi a parlare per ore da solo come i matti, raccontando ai muri quel che non ho voluto dire al mio avvocato.
E come spiegare ai muri che genere di vita conducevo, qual era la mia giornata tipo? Ebbene, muri, considerate un giovane e il suo tempo. Non il tempo maiuscolo, badate, il tempo maestoso e tragico della Storia. Limitatevi al tempo che un individuo ha in sorte, quello di cui ognuno dispone, che chiamiamo vita e che il nostro giovane spreca con incoscienza metodica, manco dovesse campare in eterno. Consideratelo, questo giovane, mentre sperpera i suoi anni migliori nell’ufficio angusto di una galleria d’arte. E considerate pure la galleria, situata in una grande e tortuosa città, in pieno centro, e però in una via cosí laterale che i passanti sono rarissimi e quei pochi sempre accidentali, gente che vaga o si è perduta. Figuratevi il giovane impiegare il suo tempo nell’angusto ufficio facendo poco o nulla fuorché restare in attesa di un collezionista o anche di un semplice quanto improbabile visitatore, qualcuno che suoni il campanello per ammirare le opere esposte nella grande sala che divide l’angusto ufficio dal portone d’ingresso. Immaginatelo dapprima al mattino, questo giovane, seduto alla scrivania, lo sguardo ancora acceso da una specie di luce sebbene immotivata. Spostatevi quindi al giorno avanzato, quando, dopo ore di niente e nessuno, il giovane trova il coraggio e la sfrontatezza, o forse soltanto la rassegnazione, per migrare sul divano davanti alla scrivania. Bisogna che consideriate pure il divano, un Arcadia in pelle bianca. C’è forse un abisso migliore di un elegante schienale trapuntato per un corpo stanco e annoiato? Non c’è. Difatti il giovane vi sprofonda. Vi sprofonda nel senso piú stretto possibile e con una sola speranza nel cuore: che l’ora di chiusura si affretti ad arrivare. «Et in Arcadia ego», dice, scherzoso e a sé stesso, il giovane mentre, al puro scopo di ingannare il tempo, il suo tempo, osserva senza rapimento un dipinto appeso alla parete di fronte, un David con la testa appena mozzata di Golia, opera di Giuseppe Cesari, detto il Cavalier d’Arpino.
Spesso, per precauzione, smette di fissare quel quadro che non dovrebbe stare in una galleria d’arte contemporanea, solleva il capo e butta un occhio al di là del bracciolo, verso il portone d’ingresso. L’eventualità è remotissima, ma non si può escluderla: sarebbe a dir poco imbarazzante se il suo datore di lavoro, noto nell’ambiente come l’Inestinto, piombasse d’improvviso in galleria per sorprenderlo in un ozio tanto sfrontato. Come previsto, il tempo passa e non piomba anima viva, nessun Inestinto, nessun visitatore. Si diriga pertanto lo sguardo dell’immaginazione all’ora di chiusura. Riemerso dal divano, dall’Arcadia, il giovane spegne le luci dell’angusto ufficio, svuota la vaschetta del deumidificatore nel vaso dell’oleandro accanto al portone d’ingresso, la rimette al suo posto e si avvia di nuovo alla porta.
Provate ora, odiati muri, a udire il suono metallico della chiave che gira nella toppa: pare il gracidio di una rana meccanica dagli ingranaggi arrugginiti. È un suono fondamentale. Groc… groc… Il verso rompe il silenzio del vicolo ormai buio. A volte la serratura s’inceppa e il giovane deve ripetere l’operazione. Groc… groc… Ci sono sere in cui, a forza di dare mandate, il giovane viene aggredito da un senso d’irrealtà. Ha quasi l’impressione che il rumore voglia parlargli, che tenti di tramutarsi in parole. Non vi dà peso. È scettico per natura. Per lui, che una chiave pretenda di fare conversazione è un’assurdità. Del resto perché mai dovrebbe pretenderlo, per dirgli cosa? Il groc groc che fuoriesce dalla serratura è spesso la sola presenza, l’unico evento della giornata. Che si carichi di significato fin quasi ad assumere una consistenza umana, è naturale o almeno comprensibile. A forza di restare dove non c’è niente da vedere e sentire, si finisce per sentire e vedere ciò che non c’è. Questo non serve a consolare il giovane, che preferirebbe essere meno incline allo scetticismo, meno razionale e piú avventato nel giudicare. Non che sia alieno alle fantasie. Fantastica eccome e pure sfrenatamente.
Ma proprio qui si materializza l’intoppo, perché nulla immalinconisce l’esistenza quanto il pensare di vivere tra gli angeli pur non credendo nel paradiso. Non per niente è cosí che lo chiamano da sempre, Melancolia. In fin dei conti, che la serratura gli parli è quel che desidera. Vorrebbe essere abbastanza folle, dotato di un pizzico di sana credulità per sospettare che la chiave lo abbia osservato di nascosto, da dentro la tasca dei pantaloni o dalla scrivania, appostata dietro il telefono, dove il giovane posa il mazzo con le chiavi perché non gli buchi la tasca dell’abito buono. Vorrebbe che la chiave fosse rimasta a spiarlo severa per tutte le lunghe ore che compongono la sua giornata lavorativa, scuotendo il capo – fuor di metafora, s’intende – e in segno di disapprovazione profonda; vorrebbe che, giunta la sera, esasperata da tanto nulla e da tanto spreco, la chiave fosse finalmente sbottata per cantargliene quattro; vorrebbe che la pantomima surreale si ripetesse ogni sera uguale, con la rassicurante ripetitività degli screzi in famiglia; vorrebbe, in sostanza, che la chiave cogliesse proprio quel momento, l’ora della chiusura, per ripetergli chiaro e tondo cosa pensa di lui. Gli è facile immaginare che direbbe, se davvero potesse parlare.
Groc… groc… perché sprechi giornate intere a questa inutile maniera in questa inutile galleria? Groc… groc… perché passi ore cercando di ingannare il tempo, il tuo tempo, l’unico che hai, quando sai bene che è lui a ingannare te? Ecco cosa gli direbbe la chiave, e se gli è tanto facile immaginarlo è per una ragione soltanto: perché sono le stesse identiche parole che ripete a sé stesso ogni sera incamminandosi nello scuro del vicolo, diretto verso casa e senza compagnia se non il rimbombo dei propri passi e il desiderio che il buio lo inghiottisca per sputarlo in un altro luogo, non importa quale purché sia lontano da lí e ancora innocente, un luogo privo d’arte e di gallerie.
Ora che avete considerato il giovane e il suo tempo, signori muri, ora che avete un quadro delle sue abitudini e delle sue propensioni, rispondete con sincerità al seguente quesito: da un individuo di cosí poche speranze ci si può forse aspettare imprese di un qualche rilievo?
Certo che no, direte voi. Chi mai scommetterebbe un centesimo su di lui? Nessuno punterebbe su un suo riscatto, anche solo momentaneo o fortuito; nessuno crederebbe che in lui covi un destino, che possa diventare tre cose in una: un usurpatore d’anime, un omicida, un genio della pittura (l’ordine non è rilevante). Io per primo non ci crederei e men che mai punterei su di lui, non fosse che quel giovane ero io e quel suo tempo il mio.