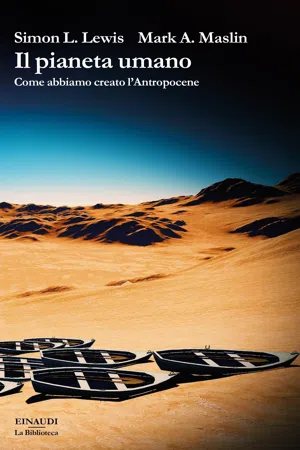Molti pensano che nelle migliaia di anni che seguirono la nascita dell’agricoltura le società umane siano state statiche. Non è vero. Nacquero imperi – alcuni fiorirono e poi scomparvero, mentre altri durarono a lungo. Per la maggior parte le persone continuarono a essere agricoltori di sussistenza che mantenevano in vita sé stessi, o sé stessi e le élite al potere. Lo stile di vita basato sulla ricerca del cibo fu relegato in territori marginali per l’agricoltura. Le popolazioni crebbero rapidamente: le stime vanno da 1-10 milioni di persone agli inizi dell’agricoltura a 425-540 milioni nell’anno 1500, pressappoco 10 000 anni piú tardi1.
Fiorirono le innovazioni. Gli esseri umani idearono strumenti pratici, come la ruota 5500 anni fa e il chiodo 4000 anni fa, e strumenti che aumentavano le capacità intellettive – il papiro 6000 anni fa, l’abaco 5000 anni fa e la carta 2000 anni fa. Si passò dagli utensili di pietra a quelli in bronzo e, piú tardi, in ferro. Con lo sviluppo di sistemi agricoli piú sofisticati, la produzione alimentare divenne piú efficiente. Anche dal punto di vista intellettivo vi furono cambiamenti e la scrittura e i metodi di contabilità permisero a piccole élite di controllare imperi sempre piú grandi. I 50 000 anni e piú di cultura cumulativa continuarono. Poche di queste innovazioni, tuttavia, modificarono le attività quotidiane della maggior parte dell’umanità come aveva fatto la rivoluzione agricola.
Nel Cinquecento tutto iniziò a cambiare, e a cambiare sempre piú velocemente. Lo sviluppo agricolo, dalle piú semplici comunità agricole alle città-stato agli imperi (e spesso poi in direzione opposta), tutti sostenuti dall’agricoltura, iniziò lentamente a essere sostituito da un nuovo modo di vivere. Nella vita quotidiana delle persone tutto subí una rivoluzione, dall’alimentazione al modo di comunicare, dal modo di pensare alla relazione con la terra che le nutriva. In un modo o nell’altro, chi viveva al margine occidentale del continente europeo modificò la traiettoria di sviluppo della società umana, e la traiettoria di sviluppo del sistema Terra, creando il mondo moderno in cui viviamo oggi. Nulla sarebbe piú stato come prima.
Un momento cruciale di questo passaggio al mondo moderno fu l’arrivo degli Europei nella terra che in seguito chiamarono America. Cristoforo Colombo sbarcò alle Bahamas il 12 ottobre 1492, pensando di essere arrivato in India. Persino dopo altri tre viaggi nelle Americhe, durante i quali nel 1498 approdò anche sul continente, nell’attuale Venezuela, Colombo si rifiutò fino alla morte, avvenuta nel 1506, di credere che quella terra fosse un nuovo continente. Era interessato all’oro e alla conquista molto piú che a capire quelle terre e i loro abitanti2. Fu un altro navigatore italiano, Amerigo Vespucci, a convincere sé stesso e chiunque altro – inventando senza vergogna parti dei resoconti dei suoi viaggi – di aver visto un Nuovo Mondo. Nel 1503, in una lettera, Vespucci scrisse:
Ai giorni passati pienamente diedi avviso alla signoria vostra del mio ritorno; e se ben mi ricordo, le raccontai di tutte queste parti del mondo nuovo, alle quali io era andato con le caravelle del serenissimo re di Portogallo. E se diligentemente saranno considerate, parrà veramente che facciano un altro mondo: sicché non senza cagione l’abbiamo chiamato Mondo nuovo; perché gli antichi tutti non n’ebbero cognizione alcuna, e le cose che sono state nuovamente da noi ritrovate, trapassano la loro opinione. Pensarono essi oltra la linea equinoziale verso mezzogiorno niente altro esservi, che un mare larghissimo, ed alcune isole arse e sterili: il mare lo chiamarono Atlantico; e se talvolta confessarono che vi fosse punto di terra, contendevano quella essere sterile, e non potervisi abitare. La opinione de’ quali la presente navigazione rifiuta, ed apertamente a tutti dimostra esser falsa e lontana da ogni verità: perciocché oltra l’equinoziale io ho trovato paesi piú fertili e piú pieni di abitatori, che giammai altrove io abbia ritrovato, sebben vossignoria anche voglia intender dell’Asia, dell’Africa e dell’Europa3.
Queste parole, che all’epoca furono ripubblicate in tutta l’Europa, convinsero un cartografo tedesco, Martin Waldseemüller, a contrassegnare con il nome del navigatore italiano questo nuovo quarto continente nella sua carta del mondo del 1507, usando il genere femminile del nome latinizzato (Americus) poiché Europa, Africa e Asia erano tutti nomi femminili. Il nuovo nome e la nuova mappa divennero popolari. Come abbiamo già notato, i nomi sono importanti e in questo caso abbiamo un continente che prende il nome non da qualche suo aspetto, e nemmeno da coloro che ne rivelarono l’esistenza, ma da qualcuno che, letteralmente, si inventò delle storie. In ogni caso, dopo il suo inserimento nelle carte, il cosiddetto Nuovo Mondo attrasse molte altre persone. Il richiamo di nuove terre sconfinate da esplorare portò a uno scontro fra l’emisfero occidentale e quello orientale dell’umanità destinato a scatenare una serie di eventi che cambiarono la Terra.
I popoli delle Americhe erano stati isolati da quelli asiatici ed europei per circa 12 000 anni, a parte qualche sporadico sbarco sulle coste atlantiche dell’America del Nord di navi vichinghe che si erano perse e rare incursioni dei polinesiani sulle coste pacifiche dell’America del Sud. Questa separazione dell’umanità si realizzò poiché alla fine dell’ultima era glaciale, mentre il mondo si stava riscaldando, il ghiaccio ancora presente permise a qualche essere umano di attraversare lo Stretto di Bering dall’Asia all’America settentrionale, ma questa finestra di opportunità per poter passare non durò a lungo, poiché con il continuo riscaldamento del mondo la maggior parte del ghiaccio marino si sciolse, impedendo il passaggio.
I pochi che riuscirono ad attraversare lo Stretto di Bering si diffusero in tutte le Americhe e lentamente popolarono l’intera massa continentale. Lo sappiamo poiché prima che i viaggi moderni diventassero comuni quasi tutti i nativi americani erano di gruppo sanguigno 0, invece di avere la gamma di tipi A, B, AB e 0 che si trova nel resto del mondo. Piú specificamente, i nativi americani hanno un’unica variante dell’allele – una forma alternativa del gene – del gruppo 0, chiamata O1v(G542A)4. Questa mutazione è assente in Asia, quindi deve essere comparsa subito dopo che le persone emigrarono, per poi essere trasmessa da un unico gruppetto di fondatori che nel corso del tempo si diffuse in tutte le Americhe. Anche se tutti i membri della specie Homo sapiens sono geneticamente molto simili (è una specie molto giovane e non ha avuto il tempo di accumulare molta diversità genetica), nell’ambito di questa similarità genetica, l’esiguità del gruppo che attraversò lo Stretto di Bering fece sí che i nativi americani fossero diversi, isolati e relativamente simili in gran parte delle Americhe.
Dopo 12 000 anni di separazione, i nativi americani incontrarono gli Europei in condizioni di disparità. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, le principali specie animali allevate provenivano dall’Eurasia e quelle che tendono a vivere piú vicino agli esseri umani (mucche, pecore, capre, maiali e cavalli) vivevano con gli Europei da migliaia di anni. Le malattie pertanto avevano avuto molte occasioni per passare dagli animali agli esseri umani e viceversa e per diffondersi in tutta l’Eurasia, dalla Cina orientale alla Spagna occidentale. Quando sbarcò per la seconda volta nei Caraibi, nel 1493, Colombo aveva pianificato di insediarsi in quelle terre: arrivò con diciassette navi, millecinquecento persone e centinaia di maiali e di altri animali. Appena sbarcarono, l’8 dicembre, i maiali, che erano stati isolati nelle stive, furono liberati.
L’indomani tutti, compreso Colombo, iniziarono ad ammalarsi. I nativi americani iniziarono a morire. Probabilmente si trattava di influenza suina, a cui i nativi americani non erano mai stati esposti5. Ventitre anni dopo, nel 1516, dell’isola che oggi è divisa fra Haiti e la Repubblica Dominicana lo storico spagnolo Bartolomé de Las Casas scrisse: «Hispaniola è spopolata, derubata e distrutta […] poiché in soli quattro mesi è morto un terzo degli indiani che erano sotto la tutela [degli Spagnoli]». Due anni dopo, in Memorial de remedios para las indias, Las Casas scrisse che «del milione di anime che vivevano a Hispaniola, i cristiani ne hanno lasciate soltanto 8000 o 9000, le altre sono tutte morte»6. Ma il peggio doveva ancora arrivare.
Inizialmente, i lunghi viaggi dall’Europa costituivano una specie di quarantena per i passeggeri con il vaiolo, che è contagioso soltanto per un mese. I portatori morivano sulla nave oppure arrivavano con una forte immunità. In entrambi i casi, il vaiolo non sopravviveva al viaggio. Quando navi migliori con vele piú resistenti ridussero i tempi di attraversamento dell’oceano, nuove malattie riuscirono a farsi dare un passaggio. Il vaiolo arrivò a Hispaniola nel gennaio del 1519 e si diffuse immediatamente sul territorio continentale dell’America centrale. I nativi americani non erano immuni dal vaiolo, dall’influenza né da altre malattie arrivate dall’Europa. Queste infezioni accelerarono la conquista spagnola di ciò che è comunemente noto come Impero azteco (un nome inventato nell’Ottocento), ossia, piú correttamente, la Triplice alleanza azteca, dal trattato stipulato nel 1428 fra i signori di tre città7.
Le malattie aiutarono i saccheggiatori spagnoli. Nell’agosto del 1519, quando Hernán Cortés fece il primo tentativo di conquistare la piú grande città dell’America precolombiana, Tenochtitlán, forte di 200 000 abitanti, riuscí a malapena ad aver salva la vita. Mentre si stava riorganizzando, però, la malattia devastò Tenochtitlán. Dopo un assedio di settantacinque giorni, i decessi provocati dalla malattia, dai combattimenti e dalla fame avevano lasciato una delle piú grandi città del mondo quasi senza vita. Con qualche centinaio di soldati spagnoli e i Tlaxcaltechi, rivali di Tenochtitlán, il 13 agosto 1521 Cortés annesse la città alla Spagna.
Uno degli ufficiali di Cortés, Bernal Díaz del Castillo, scrisse: «Giuro che tutte le case sul lago erano piene di teste e cadaveri […]. Le strade, le piazze, le case e le corti erano piene di corpi, tanto che era quasi impossibile passare»8. I nativi americani continuarono a combattere, ma non furono in grado di superare le numerose ondate epidemiche, la scarsità di cibo che ne derivava e la tecnologia superiore degli Spagnoli. Cosí finí un impero che si era espanso rapidamente, su un territorio grande come l’attuale Italia (300 000 km2), con una popolazione che ammontava almeno a 11 milioni di persone e forse a 25. Soltanto 2 milioni di persone sopravvissero alla conquista spagnola9.
Le nuove malattie si diffusero verso sud attraverso Panama, dove uno storico contemporaneo in visita stimò che tra il 1514 e il 1530 fossero morte piú di 2 milioni di persone10. Da lí la marcia degli agenti infettivi continuò attraverso la regione del Darién fino in America del Sud. Il piú grande impero delle Americhe – e sotto certi aspetti il piú grande del mondo all’epoca – era l’Impero inca, le cui terre si estendevano lungo la spina dorsale del continente, la catena delle Ande. Gli Inca avevano sentito parlare degli Spagnoli, «uomini barbuti che si spostavano sul mare su grandi case», ben prima di vederli11. Prima degli uomini bianchi, però, arrivò la malattia: Francisco Pizarro, un altro conquistador spagnolo, entrò in contatto con gli Inca nel 1526, senza tentare l’invasione. Li aspettava lo stesso destino della Triplice alleanza: secondo alcune stime, appena un anno dopo l’incontro Huayna Cápac diventò il primo imperatore inca a perdere la vita nell’epidemia.
Come avvenne la caduta dell’Impero inca è piú difficile da ricostruire della catastrofe di Tenochtitlán, poiché la scrittura non faceva parte della civiltà inca e gli Spagnoli vennero a sapere della morte di Cápac soltanto nel 1531. Molti sostengono che morí di vaiolo, ma un’attenta lettura dei vari resoconti, fra cui le descrizioni del corpo mummificato, suggerisce che piú probabilmente morí a causa di una malattia europea che si trasmetteva piú facilmente e si diffondeva piú velocemente, come il morbillo o l’influenza. In ogni caso, gli Inca ne furono fatalmente indeboliti e il loro impero, di 2 milioni di km2 e con una popolazione stimata fra 10 e 25 milioni di persone, fu invaso dagli uomini di Pizarro. Gli Inca, a quanto pare, registravano i dati demografici usando un sistema di cordicelle annodate, detto quipu, ma la chiave per decifrarlo andò persa alla distruzione di una civiltà che si era espansa rapidamente per quattro secoli. Anche in questo caso, non si conoscono le cifre esatte, ma in base alle stime dei ricercatori all’incirca metà della popolazione morí al momento della conquista12.
Queste furono soltanto le prime calamità provocate da microbi che colpirono i nativi americani. Tra gli Inca il vaiolo arrivò definitivamente nel 1558, quando la popolazione era già stata distrutta dalla guerra, dalle malattie e dalla fame. In tutte le Americhe, gli elevati tassi di mortalità causarono una drastica riduzione della capacità lavorativa. I conquistadores, a corto di nativi americani come manodopera per i lavori forzati, portarono nelle Americhe gli Africani. Oltre all’aggiunta degli orrori della schiavitú transatlantica agli orrori di un continente decimato, due nuove malattie mortali, trasmesse dalle zanzare, devastarono i popoli del continente: la febbre gialla e la malaria13. Naturalmente, pochissime persone avevano un’immunità naturale da tutte queste diverse malattie che arrivarono nell’arco di pochi decenni.
Nel tentativo di capire la catastrofica decimazione dei nativi americani, molti si concentrano erroneamente soltanto sul vaiolo. Il vaiolo fu una causa importante di morte, ma senza dubbio non fu l’unica. Una dopo l’altra, arrivarono ondate di influenza, morbillo, tifo, polmonite, scarlattina, malaria e febbre gialla, fra le altre malattie. In aggiunta, vi furono le vittime delle guerre contro gli Spagnoli, e in seguito contro i Portoghesi, gli Inglesi e i Francesi, e tutti coloro che morirono di fatica dopo essere stati ridotti in schiavitú. Il caos provocato dai cambiamenti e la perdita di cosí tante vite furono tali da distruggere in gran parte le società tradizionali e da far crollare l’agricoltura – e quindi alle cause di morte si aggiunse la carestia.
Pare che, in seguito al contatto prolungato con gli Europei, morí almeno il 70 per cento della popolazione, e in molti casi il 90 per cento o piú, in base alle informazioni relative alle borgate, alle città e alle regioni piú studiate. Hispaniola, per esempio, aveva una popolazione molto numerosa, che secondo le stime nel 1492 era...